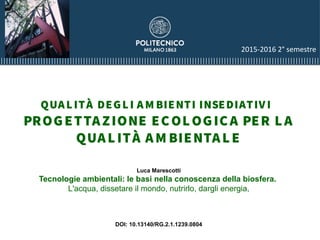
2016 Environmental Technologies: Fundamentals in the biosphere knowledge. The water quench the world, feed him, give him energy. / Le basi nella conoscenza della biosfera. L'acqua, dissetare il mondo, nutrirlo, dargli energia
- 1. QUALITÀ DEGLI AM BIENTI INSEDIATIVI PROGETTAZIONE ECOLOGICA PER LA QUALITÀ AM BIENTALE Luca Marescotti Tecnologie ambientali: le basi nella conoscenza della biosfera. L'acqua, dissetare il mondo, nutrirlo, dargli energia, DOI: 10.13140/RG.2.1.1239.0804 2015-2016 2° semestre
- 2. Luca Marescotti 2 / 100 IL SENSO DELLE PAROLE THE MEANING OF WORDS Le lezioni seguono il libro di testo: Luca Marescotti, Città Tecnologie Ambiente. Le tecnologie per la sostenibilità e la protezione ambientale Nelle diapositive sono riportati estratti del testo
- 3. Luca Marescotti 3 / 100 INFLUENZA DELLE CARTE EUROPEE NELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI Leggete e studiate LE CARTE EUROPEE DELL'ARIA, DEL SUOLO, DELL'ACQUA
- 4. Luca Marescotti 4 / 100 (1) Responsabilità dell’autore di inquinamento - Le legislazioni debbono prevedere che chiunque contribuisca a inquinare l’aria, anche in assenza di danni provati, deve essere tenuto a ridurre tale inquinamento al minimo e ad assicurare una buona dispersione delle emissioni. (2.3) i veicoli a motore e gli apparecchi fabbricati in serie che utilizzino combustibile dovrebbero essere oggetto di prescrizioni generali: poiché i veicoli a motore attraversano le frontiere, norme uniformi europee per la loro costruzione e funzionamento dovrebbero essere fissate appena possibile; tali norme dovrebbero essere previste per gli apparecchi fabbricati in serie che utilizzano combustibile e sono oggetto di commercio internazionale. (8) Urbanesimo e sistemazione regionale - La pianificazione dello sviluppo urbano e industriale dovrebbe prendere in considerazione l’effetto di tale sviluppo sull’inquinamento dell’aria; le autorità responsabili dovrebbero assicurare il mantenimento e la creazione di spazi [Carta Europea dell'Aria] ARIA 1968
- 5. Luca Marescotti 5 / 100 (7) Ogni impianto urbano deve essere organizzato in modo tale che siano ridotte al minimo le ripercussioni sfavorevoli sulle zone circostanti. (9) È indispensabile l’inventario delle risorse del suolo. (11) La conservazione dei suoli deve essere oggetto di insegnamento a tutti i livelli e di informazione pubblica sempre maggiore. [Carta Europea del Suolo] SUOLO 1972
- 6. Luca Marescotti 6 / 100 (11) La gestione delle risorse idriche dovrebbe essere inquadrata nel bacino naturale piuttosto che entro frontiere amministrative e politiche. (12) L’acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune, che necessita di una cooperazione internazionale. [Carta Europea dell'Acqua] ACQUA 1968
- 7. Luca Marescotti 7 / 100 ARIA SUOLO ACQUA dissetare il mondo nutrire il mondo dare energia il mondo RISORSE NATURALI E URBANISTICA
- 8. Luca Marescotti 8 / 100 LA CULTURA POLITECNICA E L'ACQUA UN PIANETA RICOPERTO DALL'ACQUA
- 9. Luca Marescotti 9 / 100 Terra e terre Le terre emerse -terraferma e isole- occupano il 29,2% della superficie terrestre (149,45 milioni km2). Il bilancio globale delle risorse globali disponibili e dei limiti è rappresentato dall’analisi della copertura del suolo: all’interno di questi limiti devono essere poste le ricerche della convivenza umana. Ecosistemi marini e ecosistemi terrestri interagiscono nella varietà climatica e geografica del pianeta. La produttività di risorse per la vita umana deve essere giocata all’interno di queste condizioni mantenendo le possibilità naturali di rigenerazione delle risorse. [fonte: FAO Global Land Cover (GLC-SHARE) Beta-Release 1.0 Database, Land and Water Division, John Latham, Renato Cumani, Ilaria Rosati, Mario Bloise, 2014”.] ACQUA
- 10. Luca Marescotti 10 / 100 COPERTURA DEL SUOLO - GLOBAL LAND COVER SHARE 12,3%
- 11. Luca Marescotti 11 / 100 ARIA atmosfera SUOLO pedosfera - litosfera ACQUA idrosfera Le relazioni tra aria suolo e acqua sono fisiche, chimiche, biologiche sono l'essenza della BIOSFERA attuano servizi ecologici, rigenerando i singoli componenti, rigenerano il sistema CULTURA POLITECNICA ECOLOGIA URBANISTICA
- 12. Luca Marescotti 12 / 100 ACQUA ambiente vitale - diverse specie di organismi riserva di energia - accumula l'energia solare nutrizione - riserva per i fabbisogni alimentari e idrici trasporti – riduce l'attrito
- 13. Luca Marescotti 13 / 100 radiazioni solari 33% 50% energia ciclo delle acqueciclo delle acque L'ENERGIA PER MUOVERE I CICLI DELL'ACQUA
- 14. Luca Marescotti 14 / 100 CICLO DELL'ACQUA E BIOSFERA
- 15. Luca Marescotti 15 / 100 CICLO DELL'ACQUA – i volumi Nel ciclo delle acque interagiscono processi chimici, biologici, geologici e si attuano servizi ambientali di rigenerazione [Ciclo dell’acqua. Volumi in 103 km3 . (Fonte: Newton citato in: Chapman, Mather 1995, p. 184).]
- 16. Luca Marescotti 16 / 100 Scambi di energia tra aria acqua e suolo CICLO DELL'ACQUA – energie e cariche elettriche
- 17. Luca Marescotti 17 / 100 CARATTERIZZATA DA •Viscosità in funzione della temperatura •Turbolenza in funzione del sito E DA TRE DIVERSI STATI DI AGGREGAZIONE • solida • liquida • gassosa ACQUA
- 18. Luca Marescotti 18 / 100 ACQUA LA SUPERFICIE DEGLI OCEANI E DEI MARI 70% della superficie terrestre L’acqua degli oceani e dei mari 94% dell’acqua allo stato libero ACQUA DOLCE = 2% RIPARTITA IN ghiaccio laghi fiumi acqua in falda superficiale umidità del suolo umidità dell’atmosfera
- 19. Luca Marescotti 19 / 100 ACQUA
- 20. Luca Marescotti 20 / 100 AMBIENTI ACQUATICI • Ambienti marini; • Acque di transizione (miscela di acque dolci e acque salate): lagune, estuari di fiumi, foci di canali artificiali, porti e golfi; • Ambienti di acqua dolce. Caratterizzati dalla dinamica: – movimenti orizzontali di modesta entità come i laghi (ambienti lentici, acque calme) – movimenti orizzontali più o meno rapidi, persistenti e orientati, come i fiumi (ambienti lotici).
- 21. Luca Marescotti 21 / 100 Foce del Po Esempio di foce a delta Porto Caleri- Rosolina Mare
- 22. Luca Marescotti 22 / 100 Foce a delta del Po
- 23. Luca Marescotti 23 / 100 Foce del Po Conoscenza come integrazione di dati e informazioni
- 24. Luca Marescotti 24 / 100 Foce del Magra Esempio di foce a estuario A destra l’autostrada A12
- 25. Luca Marescotti 25 / 100 Dinamica delle acque marine Passaggio dei Fornelli tra l’Isola Asinara (a nord) e l’Isola Piana (a sud) la presenza di corrente da ovest a est è denunciata dalla forma delle onde
- 26. Luca Marescotti 26 / 100 Foce a estuario dell’Ofanto Meandri abbandonati, sedimenti trasportati a mare, lotti delle colture agricole parzialmente disegnate dal fiume
- 27. Luca Marescotti 27 / 100 Lago artificiale Passo del Furlo Diga di sbarramento e lago artificiale sul fiume Candigliano, affluente del Metauro lungo il tracciato originario della via Flaminia
- 28. Luca Marescotti 28 / 100 Lago Gaeta Lago di Lungo vicino al mare e Lago di San Puoto Tra i due laghi colture intensive con serre in un terreno molto fertile formato da depositi detritico- alluvionali
- 29. Luca Marescotti 29 / 100 Lago Oggiono Lago di Annone tra Civate, Oggiono, Annone a nord la superstrada Milano Lecco San Pietro al Monte sopra Civate
- 30. Luca Marescotti 30 / 100 Laguna Oristano La laguna delle saline di Mandriano
- 31. Luca Marescotti 31 / 100 Acque di transizione Laguna - Canale - Mare La laguna di Varano con il canale di Capaiale che la connette all’Adriatico La laguna delle saline di Mandriano Lago di Varano
- 32. Luca Marescotti 32 / 100 IMPATTI UMANI: uso, accaparramento e distruzione ACQUA Un problema complesso: sfruttamento per attività industriali e agricole e per la produzione di energia, mezzo per la dispersione di reflui organici e industriali, mezzo per l'estrazione di risorse naturali. Misurazione della qualità delle acque in funzione della turbolenza e del ricambio per l'ossigenazione. “(12) L’acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune, che necessita di una cooperazione internazionale”
- 33. Luca Marescotti 33 / 100 Derivazioni dal fiume Ticino Sfruttamento agricolo di un bacino idrografico per irrigazione e per forza motrice (Fonte: Consorzio del Ticino) IMPATTI UMANI: uso, accaparramento e distruzione
- 34. Luca Marescotti 34 / 100 IMPATTI UMANI: uso, accaparramento e distruzione
- 35. Luca Marescotti 35 / 100 Diga delle Tre Gole sullo Yangtse IMPATTI UMANI: uso, accaparramento e distruzione
- 36. Luca Marescotti 36 / 100 IMPATTI UMANI: uso, accaparramento e distruzione
- 37. Luca Marescotti 37 / 100 Costruzione del condotto nazionale per la derivazione delle acque del Giordano Fonte: Orefice Roberto, Immagini e metamorfosi di Erez in: AA.VV. 1966 p. 37. IMPATTI UMANI: uso, accaparramento e distruzione
- 38. Luca Marescotti 38 / 100 Bilancio idrico di un bacino idrografico Esempio: Bacino idrografico del fiume Giordano (Fonte: Chapman, Mather 1995, p. 204) IMPATTI UMANI: uso, accaparramento e distruzione
- 39. Luca Marescotti 39 / 100 ACQUA: ma che succede dell'oceano Tetide? TRA UZBEKISTAN E KAZAKISTAN
- 40. Luca Marescotti 40 / 100 ACQUA: ma che resta dell'oceano Tetide? CHE SUCCEDE DELL’ACQUA? Il Lago d'Aral è un lago salato di origine oceanica, situato alla frontiera tra l'Uzbekistan e il Kazakistan. Possiede due immissari (Amu Darya e Syr Darya*) e non ha emissari (bacino endoreico**) (*) Darya "fiume" in persiano (**) dal gr. ῥέω «scorrere»: bacino idrografico senza scolo al mare (contrapposto a esoreico)
- 41. Luca Marescotti 41 / 100 ACQUA: ma che resta dell'oceano Tetide? CHE SUCCEDE DELL’ACQUA? 2000 Amu Darya è il fiume più lungo dell'Asia centrale (2650 km), navigabile per oltre 1450 chilometri. Nell'antichità classica, era conosciuto con il nome di Oxos in greco e in persiano Jayḥūn
- 42. Luca Marescotti 42 / 100 ACQUA: DOV'È FINITA L'ACQUA DEL LAGO D'ARAL? CHE SUCCEDE DELL’ACQUA? 2010 Syr Darya (2250 km), chiamato dai greci Iassarte e dagli Arabi come Sayḥūn, segnava un confine dell'impero di Alessandro Magno. Fornisce l'acqua per irrigare le zone più fertili dell'Asia centrale coltivate a cotone.
- 43. Luca Marescotti 43 / 100 ACQUA: DOV'È FINITA L'ACQUA DEL LAGO D'ARAL? Le acque del Syr Darya era usate attraverso un complesso sistema di canali artificiali, costruiti nel XVIII secolo, ma il prelievo idrico nel corso del XX secolo fu incrementato dal governo sovietico per irrigare le piantagioni di cotone così tanto da non giungere più al lago d'Aral. Le acque del Amu Darya non riescono più a raggiungere il lago d'Aral tanto si è ridotto, quindi si perdono nel deserto; solo un ramo confluisce nel lago Sarygamysh a sud-ovest del lago d'Aral.
- 44. Luca Marescotti 44 / 100 ACQUA: DOV'È FINITA L'ACQUA DEL LAGO D'ARAL? CHE SUCCEDE DELL’ACQUA? 2015
- 45. Luca Marescotti 45 / 100 ACQUA: and what about Lakes on the Mongolian Plateau? Lakes on the Mongolian Plateau are shrinking rapidly, according to researchers from Peking University and the Chinese Academy of Sciences. After analyzing several decades of satellite imagery, the researchers found that the total lake surface area had declined from 4,160 square kilometers (1,060 square miles) in the late 1980s to 2,900 square kilometers in 2010, a decrease of 30 percent. The authors attribute the losses to warming temperatures, decreased precipitation, and increased mining and agricultural activity. [NASA Earth Observatory]
- 46. Luca Marescotti 46 / 100 ACQUA: and what about Lakes on the Mongolian Plateau?
- 47. Luca Marescotti 47 / 100 ACQUA: and what about Lake Chapala, the largest lake in Mexico? Water now seldom flows from the lake to the Río Santiago, its natural outlet. The lake’s internal circulation and hydrologic balance are drastically different from historic patterns. Agricultural chemical residues, heavy metals, and dissolved solids have increased due to inputs from upstream and to evaporation from the shallow lake. These changes have contributed to periodic expansion of algae and non- native aquatic plants, diminished quality of commercial fisheries, and impoverished diversity of native fish species. Contaminated and reduced fish stocks pose health threats to both humans and birds that consume them. [NASA Earth Observatory]
- 48. Luca Marescotti 48 / 100 ACQUA: and what about Lake Chapala, the largest lake in Mexico?
- 49. Luca Marescotti 49 / 100 ACQUA: and what about Lake Orumiyeh (also Orumieh or Urmia) in northwestern Iran? Lake Orumiyeh (also Orumieh or Urmia) in northwestern Iran is one of the world’s largest landlocked salt lakes, but it is shrinking. Orumiyeh is fed by roughly 60 rivers and streams—some permanent and some ephemeral—that also deliver salts. Because the lake lacks an outlet, those salts accumulate in the basin. As the region’s arid climate evaporates the water, the salts crystalize along the shore. The cause of Orumiyeh’s depletion has been disputed. The Iranian government blames climate change and drought, while many citizens blame damming of rivers by the government. A study published in 2007 (http://dx.doi.org/10.1186/1746-1448-3-5) concluded that both drought and increased demand for irrigation water contributed to the lake’s falling water levels and rising salinity. The study cited growing populations in the surrounding area and the consequent need for potable water. [NASA Earth Observatory]
- 50. Luca Marescotti 50 / 100 ACQUA: and what about Lake Orumiyeh (also Orumieh or Urmia) in northwestern Iran? August 1998 August 2011 [NASA Earth Observatory - http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=76327]
- 51. Luca Marescotti 51 / 100 ACQUA: and what about Lake Orumiyeh (also Orumieh or Urmia) in northwestern Iran? [June 2014 - NASA Earth Observatory - http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84116]
- 52. Luca Marescotti 52 / 100 LA QUALITÀ DELL'ACQUA dissetare il mondo nutrire il mondo dare energia il mondo LO STATO DI SALUTE DELLE RISORSE NATURALI
- 53. Luca Marescotti 53 / 100 LO STATO DI SALUTE DELLE RISORSE NATURALI EEA European Environment Agency Report N° 4/2006, Priority issues in the Mediterranean environment.
- 54. Luca Marescotti 54 / 100 LO STATO DI SALUTE DELLE RISORSE NATURALI
- 55. Luca Marescotti 55 / 100 OCCORRONO SEMPRE DATI CERTIFICATI dati non certificati = commistione tra dati eterogenei dati non certificati = fonti e di dati non certificati dati non certificati = livelli di precisione non confrontabili (certificazione) MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA
- 56. Luca Marescotti 56 / 100 Nello specifico della qualità delle acque, si deve distinguere tra acque marine e acque dolci. Le acque marine devono essere analizzate sia dal punto di vista dell’utilizzazione (attività portuali, attività di pesca, attività ricreative e balneari, attività di protezione ambientale, ma anche come supporto al trasporto passeggeri e merci, anche se con particolare attenzione alle merci pericolose (prodotti chimici e petrolio). MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA
- 57. Luca Marescotti 57 / 100 Per definire la qualità delle acque dolci esistono diverse tipologie di approccio, quasi sempre considerabili affatto complementari I parametri fisici e chimici permettono di descrivere lo stato dell’acqua e la sua capacità di metabolizzazione parametri fisici = temperatura e torbidità, quest’ultima dovuta alla presenza di materiale sospeso che impedisce la trasmissione diretta della luce parametri chimici (significativi /correlati) = collegati se possibile agli effetti biologici: effetti trofici, effetti tossici. parametri chimico-fisici = per esempio, nitrati e nitriti MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA
- 58. Luca Marescotti 58 / 100 Per definire la qualità delle acque dolci esistono diverse tipologie di approccio, quasi sempre considerabili affatto complementari Elementi significanti per la valutazione della qualità dell’acqua potabile Grado di acidità pH: acida (1<pH<7), neutra (pH = 7); alcalina (7<pH<14). Il valore consigliato per l’acqua potabile è compreso tra 6,5 e 9,5*. Conducibilità: grado di mineralizzazione, più è alto maggiore è la conducibilità elettrica; Durezza: quantità di sali di calcio e magnesio (funzione del terreno di provenienza). Alto contenuto = acqua dura; basso contenuto = acqua dolce. * power of hydrogen, concentrazione degli ioni di idrogeno MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA
- 59. Luca Marescotti 59 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA Esistono però anche metodi basati sull’osservazione delle specie viventi presenti nelle comunità acquatiche indicatori biotici = indici di ricchezza in specie, indici di diversità, indici di abbondanza e indici di dominanza indicatori saprobici(*) = analisi dello stato degli organismi direttamente coinvolti nel processo di autodepurazione per verificare le capacità di autodepurazione (*) organismi saprobi, dal gr. σαπρός "corrotto, putrefatto" e βίος "vita"
- 60. Luca Marescotti 60 / 100 Qualità delle acque ● Classe di qualità delle acque ● Unità sistematica ● Portata (deflusso) naturale ● Portata e potere autodepurativo (e quindi anche i tempi per la depurazione naturale nelle diverse condizioni di portata) ● Dinamica delle trasformazioni e confronto degli andamenti MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA
- 61. Luca Marescotti 61 / 100 Per la qualità delle acque occorre conoscere ● Flussi idrici di scarichi (industriali o civili, più o meno depurati) ● Carichi inquinanti complessivo del fiume come affluente in un altro bacino ● Impianti di depurazione e tecnologie di depurazione (classificabili anche in funzione del loro impatto sul sistema delle acque e del suolo) MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA
- 62. Luca Marescotti 62 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA Esistono però anche metodi basati sull’osservazione delle specie viventi presenti nelle comunità acquatiche METODI E CRITERI PER DEFINIRE UN INDICATORE BIOTICO Regno Unito: BMWP Biological Monitoring Worker Party Score System Francia: IBG Indice Biologique Global Belgio: BBI Belgian Biotic Index Italia: IBE (Indice Biologico Esteso) / EBI (Extended Biotic Index) [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/cwc/monit-assess/biological_assessment_methods.pdf] .
- 63. Luca Marescotti 63 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA ITALIA: IBE (INDICE BIOLOGICO ESTESO) Indice Biotico Esteso (IBE) = analisi delle comunità di macroinvertebrati che colonizzano gli ecosistemi fluviali. Comunità associate al substrato, composte da popolazioni caratterizzate da differenti livelli di sensibilità alle modificazioni ambientali e con differenti ruoli ecologici. Poichè i macroinvertebrati hanno cicli vitali relativamente lunghi, l’indice fornisce un’informazione integrata nel tempo sugli effetti causati da differenti cause di turbativa (fisiche, chimiche e biologiche). Nel monitoraggio di qualità delle acque correnti esso deve quindi considerarsi un metodo complementare al controllo chimico e fisico delle acque. Il D.Lgs. 152/99 e le sue successive modifiche (di legge nazionale e di Direttiva UE) dà ampio rilievo all’utilizzo dell’IBE nel monitoraggio e classificazione dei corpi idrici. Infatti stabilisce che lo stato ecologico venga definito incrociando i dati ricavati dalle misure dell’IBE con il livello di inquinamento espresso da alcuni macrodescrittori-LIM (parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici) [Fonte: ISPRA http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/documenti/indice-biotico-esteso-ibe]
- 64. Luca Marescotti 64 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA
- 65. Luca Marescotti 65 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA Lo stato ecologico dei corsi d'acqua (SECA) è un indicatore sintetico delle alterazioni in atto sugli ecosistemi dei corsi d'acqua. Viene determinato incrociando, secondo la metodologia prescritta dall'allegato 1 al d.lgs. n.152/99, i valori di LIM (Livello di inquinamento da macrodescrittori), un indice che stima il grado di inquinamento causato da fattori chimici e microbiologici) con quelli di IBE (indice biotico esteso, un indice delle alterazioni nella composizione della comunità di macroinvertebrati del corso d'acqua)
- 66. Luca Marescotti 66 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA scarsità o assenza di ossigeno molecolare o di ossigeno biatomico
- 67. Luca Marescotti 67 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA • BOD (Biochemical Oxygen Demand) richiesta biochimica di ossigeno • “Il BOD misura la frazione di ossigeno disciolto (in mg-1) utilizzato da una popolazione microbica eterogenea per stabilizzare, in condizioni specifiche di temperatura e tempo, il materiale organico biodegradabile presente nell’acqua. (…) La misura del BOD5 viene effettuata controllando all’inizio e al termine (dopo 5 giorni) del periodo di incubazione la concentrazione dell’ossigeno disciolto. L’impoverimento di ossigeno corrisponde alla misura del BOD5. • Il risultato si esprime in mg-1 O2 che equivalgono alla quantità di ossigeno ossidante per la reazione.”
- 68. Luca Marescotti 68 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA • TEST BOD • Il test del BOD viene effettuato diluendo un campione dell'acqua da analizzare con acqua deionizzata satura di O2, inoculando in esso una quantità fissata di microrganismi, sigillando il campione (per impedire che altro O2 passi in soluzione) e quindi conservandolo al buio (per impedire che si sviluppino processi fotosintetici che generino O2). Il campione è mantenuto al buio alla temperatura di 20 °C per tutta la durata del test (solitamente 5 giorni) e al termine di questo periodo viene analizzato l'O2 disciolto residuo. • (A) BODn campione analizzato (mg/l) = O2 disciolto inizio - O2 disciolto fine • (B) BODn bianco (mg/l) = O2 disciolto inizio - O2 disciolto fine • BODn campione originale (mg/l) = (A) x FD - (B) dove FD = Fattore di diluizione del campione [Fonte Wikipedia]
- 69. Luca Marescotti 69 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA BOD • Un fiume incontaminato ha solitamente valori di BOD5 minori di 1 mg/l. • Un fiume moderatamente inquinato avrà valori di BOD5 fra i 2 e gli 8 mg/l. • L'acqua di scarico trattata efficacemente da un impianto di depurazione acque reflue avrà valori di BOD5 di circa 20 mg/l. • L'acqua di scarico non trattata ha valori variabili, mediamente attorno ai 600 mg/l, ma spesso anche maggiori come nel caso degli scarichi di industrie casearie (2.000 mg/l) o delle acque di vegetazione degli oleifici (>5.000 mg/l). • Il valore di BOD5 medio degli scarichi influenti in un impianto di depurazione per liquami urbani è all'incirca di 200 mg/l. [Fonte Wikipedia]
- 70. Luca Marescotti 70 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA BOD L'analisi del BOD su scarichi industriali può portare a errori di valutazione, poiché in essi possono essere presenti sostanze tossiche che inibiscono l'azione batterica, o possono essere insufficienti i nutrienti minerali quali fosforo e azoto, o possono non essere presenti i ceppi batterici idonei alla metabolizzazione delle sostanze organiche presenti. Nonostante questi limiti, il BOD in campo industriale viene utilizzato perché consente di confrontare le sostanze biodegradabili dovute soprattutto alle attività domestiche, con le sostanze non biodegradabili dovute alle attività commerciali e produttive industriali. [Fonte Wikipedia]
- 71. Luca Marescotti 71 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA • COD (chemical oxygen demand) richiesta chimica di ossigeno • “Il COD misura l’ossigeno consumato per ossidazione chimica da un campione d’acqua inquinata da sostanze organiche (sia biodegradabile che non biodegradabili) e eventuali inorganiche, sotto specifiche condizioni di temperatura e di tempo, da parte di un energico ossidante, quale il bicromato di potassio in soluzione fortemente acida per acido solforico. • Il risultato si esprime in mg-1 O2 che equivalgono alla quantità di ossigeno ossidante per la reazione.”
- 72. Luca Marescotti 72 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA • BOD/COD • BOD/COD • Il rapporto BOD/COD è un indice che identifica la biodegradabilità di un refluo. Nelle acque reflue di origine urbana dove prevalgono le sostanze organiche biodegradabili, il valore COD/BOD è pari a 1,9/2,5 ciò vale anche per molti effluenti industriali provenienti da lavorazioni alimentari. • Il rapporto COD/BOD risulta più alto negli scarichi industriali nei quali prevalgono le sostanze organiche non biodegradabili. [Fonte Wikipedia]
- 73. Luca Marescotti 73 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA • TOC (total organic carbon) carbonio organico totale • “Il TOC, previa eliminazione del carbonio inorganico, misura il carbonio organico (espresso in mg-1) presente in un’acqua superficiale, (…) • La quantità di CO2 risultante (…) è proporzionale alla concentrazione del carbonio organico presente nel campione.” • Sostanze organiche possono essere presenti nell'acqua di alimentazione, possono esser originate da lisciviazione o da versamento di vari componenti all'interno del sistema di purificazione o distribuzione dell'acqua. Le sostanze organiche possono avere origine dalla formazione di biofilm (batteri) nel sistema idrico
- 74. Luca Marescotti 74 / 100 MISURARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA La determinazione del carbonio come indice di sostanza organica non dipende dallo stato di ossidazione di quest’ultima, né comprende specie inorganiche (possibile contributo alla richiesta di ossigeno espressa dal BOD e dal COD). Il valore riscontrato è una misura aspecifica, cioè non identifica la natura chimica delle sostanze presenti.
- 75. Luca Marescotti 75 / 100 URBANISTICA E IMPATTI SUL SUOLO RIPENSARE L'URBANISTICA INQUINAMENTI: IMPATTI UMANI SULL'ACQUA NON SOLO INQUINAMENTO, MA CONSUMI ECCESSIVI, TRASFORMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA, COSTRUZIONI IN ZONE DI RISCHIO ...
- 76. Luca Marescotti 76 / 100 Per la gestione dei rischi occorre conoscere anche ● Interventi sui fiumi e corsi d'acqua ● Conoscenze della storia delle piene (piene quinquennali, decennali, secolari) ● Analisi del regime idraulico delle piene in un bacino idrografico e conseguenti rischi idraulici (esondazioni) RISCHI, non solo la qualità
- 77. Luca Marescotti 77 / 100 interventi possibili sul corso dei fiumi in diversi ambiti funzionali e progettuali e di competenze a) Analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua: monitoraggio delle portate in sezioni fisse e confronto tra i dati; individuazione e analisi delle Unità ecosistemiche (processi, qualità e criticità ecologiche) b) Archivio e gestione delle informazioni sugli interventi e sui soggetti operatori: archivio dei soggetti coinvolti in progetti e programmi di recupero ambientale; controllo dei processi ambientali tramite un sistema informativo RISCHI, non solo la qualità
- 78. Luca Marescotti 78 / 100 c) Ammodernamento delle reti fognarie e depurazione degli scarichi: separazione delle acque bianche dalle acque nere; collettamento, trattamento e scarico dei reflui; impianti di depurazione delle acque reflue; impianti di lagunaggio e di fitodepurazione; impianti di finissaggio degli scarichi trattati con le tecniche di lagunaggio e di fitodepurazione d) Controllo delle piene: rinaturazione degli argini; lavori di manutenzione e di ripristino; ricollocamento e ridestinazione dei volumi idrici; realizzazione di vasche di volano per ottenere una sufficiente laminazione della portata di piena e) Controllo delle risorse per irrigazione o servizi di acque potabili: riduzione delle perdite di acquedotto; valutazione dei progetti e delle politiche possibilmente tramite analisi multicriteri RISCHI, non solo la qualità
- 79. Luca Marescotti 79 / 100 URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE RIPENSARE L'URBANISTICA PIANIFICARE I BACINI IDROGRAFICI interventi strutturali interventi non strutturali
- 80. Luca Marescotti 80 / 100 CHE COS'È L'AUTORITÀ DI BACINO (ricordate la Carta Europea dell'Acqua, § 11? ) La Legge 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istituisce le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale (art.12). L'Autorità è un organismo misto, costituito da Stato e Regioni, operante in conformità agli obiettivi della legge, sui bacini idrografici, considerati come sistemi unitari. URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino
- 81. Luca Marescotti 81 / 100 CHE COS'È L'AUTORITÀ DI BACINO (ricordate la Carta Europea dell'Acqua, § 11? ) La Legge 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istituisce le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale (art.12). L'Autorità è un organismo misto, costituito da Stato e Regioni, operante in conformità agli obiettivi della legge, sui bacini idrografici, considerati come sistemi unitari. URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino
- 82. Luca Marescotti 82 / 100 URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino L'Autorità di bacino è luogo di intesa unitaria e sinergia operativa fra tutti gli organi istituzionali interessati alla salvaguardia e allo sviluppo del bacino padano, caratterizzato da complesse problematiche ambientali. L'Autorità di bacino è luogo di intesa unitaria e sinergia operativa fra tutti gli organi istituzionali interessati alla salvaguardia e allo sviluppo del bacino idrografico, caratterizzato da complesse problematiche ambientali. “La pianificazione territoriale e paesistica regionale e provinciale ruota intorno ai meccanismi delle leggi 431/85, 394/91, 142/90. In ognuno di questi strumenti sono presenti elementi di integrazione e correlazione tra pianificazione territoriale e paesistico-ambientale”
- 83. Luca Marescotti 83 / 100 URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino La Legge 431/1985 equipara i piani paesistici ai piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, demandandone la redazione alle Regioni al fine di sottoporre a specifica normativa d'uso e valorizzazione ambientale il territorio di competenza (art. 1- bis) La legge quadro sulle aree protette (L n. 394 del 1991) riconosce al piano del parco il valore di piano paesistico e di piano urbanistico La legge di riforma delle autonomie locali (L n. 142 del 1990) demanda alle Province la redazione del piano territoriale di coordinamento, con particolare riferimento alla materia economica, ambientale e urbanistica … eccetera eccetera eccetera ...
- 84. Luca Marescotti 84 / 100 URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino 1. Undici bacini di rilevanza nazionale Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchione, Adige, Po, Arno, Tevere, Liri – Garigliano, Volturno. 2. Diciotto bacini di rilevanza interregionale Lemene, Tartaro – C. Bianco, Reno, Marecchia, Conca, Tronto, Sangro, Trigno, Saccione, Fortore, Ofanto, Bradano, Sinni, Magra, Fiora, Sele, Noce, Lao. 3. Diciotto bacini in aree a elevato rischio di crisi ambientale (dichiarati o con aperta l’istruttoria di dichiarazione): Lambro, Olona e Seveso, Bormida, Burana – Po di Volano Polesine, Taro, Parma, Enza, Crostolo, Secchia e Panaro, Frigido, Sarno, Regi Lagni, Candelaro, Neto, Gela, Anapo, Flumentepido, Rio di Palmas. 4. Quattro bacini con sperimentazione di risanamento ambientale Leogra-Timonchio, Serchio, Aterno-Pescara e Basento.
- 85. Luca Marescotti 85 / 100 URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO sede a Parma Autorità di Bacino del fiume Po = livello superiore di governo territoriale missione istituzionale = piano territoriale Il bacino del Po si estende su sette regioni e raccoglie le acque di un territorio che va dal Monviso al Delta del Po
- 86. Luca Marescotti 86 / 100 URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino
- 87. Luca Marescotti 87 / 100 URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino misure non strutturali obiettivi di difesa del rischio idraulico, di mantenimento e recupero dell’ambiente fluviale, di conservazione dei valori paesaggistici, storici, artistici e culturali all’interno delle regioni fluviali delimitazione della regione fluviale, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli e direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (a fini insediati, agricoli e industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali. definizione e delimitazione cartografica delle fasce fluviali dei corsi d’acqua principali piemontesi, del fiume Po e dei corsi d’acqua emiliani e lombardi, limitatamente ai tratti arginati a monte della confluenza in Po Fascia A = deflusso della piena - Fascia B = esondazione Fascia C = inondazione per piena catastrofica
- 88. Luca Marescotti 88 / 100 URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino Il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” rappresenta l’atto di pianificazione, per la difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico, conclusivo e unificante dei due strumenti di pianificazione precedentemente approvati • il “Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione” (PS 45), realizzato a seguito della piena del novembre 1994; • il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (PSFF), relativo alla rete idrografica principale del sottobacino del Po sotteso alla confluenza del Tanaro (territorio della Regione Piemonte e Valle d’Aosta) e, per la restante parte del bacino, all’asta del Po e agli affluenti emiliani e lombardi, limitatamente ai tratti arginati.
- 89. Luca Marescotti 89 / 100 URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino • il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo, sui versanti e sui corsi d’acqua, rispetto a quelli individuati nel PS 45 e che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle leggi collegate (leggi 22/95, 35/95, 185/92) e negli Schemi Previsionali e Programmatici citati; • l’individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo; • la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti principalmente dagli indirizzi e dalle limitazioni d’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico (delimitazione delle fasce fluviali ai rimanenti corsi d’acqua principali del bacino; regolamentazione degli usi del suolo e degli interventi; individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico)
- 90. Luca Marescotti 90 / 100 URBANISTICA, OPERE IDRAULICHE, PREVENZIONE, PRECAUZIONE : Le Autorità di bacino
- 91. Luca Marescotti 91 / 100 DISCUSSIONI E DOMANDE? IL CUSCINETTO A SFERA LA VOLTA SCORSA 13 APRILE 2016
- 92. Luca Marescotti 92 / 100 M etodo del cuscinetto a sfere/Ball Bearing/Kugellager
- 93. Luca Marescotti 93 / 100 DISCUSSIONE APERTA (A) squadre da 3/4 persone (B) Discutere per 10 minuti sui tre punti preparati (domande, giudizio concetti chiave). Spiegare e accordarsi. (C) Ruotare: UNA persona del 1 gruppo passa al 2 gruppo e così via. Ridiscutere per 10 minuti Spiegare e accordarsi. (D) Ripetere (fino a che si torna all'inizio) Tutti discutono con tutti, prendendo appunti. TEMPO INTERCORSO 30-60 MINUTI (a seconda dei gruppi) (E) TUTTI INSIEME – cosiddetta “PAUSA CAFFÈ”: 15 MINUTI Si scelgono i rappresentanti per spiegare i risultati anche al docente ESPOSIZIONE RISULTATI – 20-40 MINUTI (5-10 MINUTI PER RAPPRESENTANTE e risposte del docente)
- 94. Luca Marescotti 94 / 100 M etodo del cuscinetto a sfere/Ball Bearing/Kugellager
- 95. Luca Marescotti 95 / 100 MA NON PUÒ FINIRE QUI ….
- 96. Luca Marescotti 96 / 100 DISCUSSIONI E DOMANDE? QUALI SONO I RAPPORTI TRA I DUE CORSI INTEGRATI (geologia applicata e progettazione ecologica per la qualità ambientale)? CHE DIFFERENZE TRA QUESTO CORSO E ALTRI CORSI? QUALI APPORTI? SONO EMERSI QUESTI ELEMENTI
- 97. Luca Marescotti 97 / 100 DISCUSSIONI E DOMANDE? SONO EMERSI QUESTI ELEMENTI Approccio teorico generale (uno teorico e generale, tentativo di offrire una visione sistematica della disciplina) e approccio puntuale di dettaglio (dall'osservazione del mondo fisico all'interno di un quadro disciplinare consolidato) Diversi corsi con offerte complementari Importanza del lavoro di gruppo (più punti di vista, che vuol dire anche più discipline) e della strategia (dalla mente collettiva di Cattaneo all'intelligenza collettiva)
- 98. Luca Marescotti 98 / 100 DISCUSSIONI E DOMANDE Urbanistica, territorio e il sistema aria-acqua-suolo Regione urbana pianificazione territoriale
- 99. Luca Marescotti 99 / 100 DISCUSSIONI E DOMANDE? SONO EMERSI QUESTI ELEMENTI La frammentazione dei decisori, le diversità dei linguaggi: una babele urbanistica? La presenza di troppi decisori (in Italia gli 8000 comuni) e l'incapacità di una pianificazione territoriale regionale e di indirizzi forti (cogenti?) dello stato. Occorre armonizzare le leggi urbanistiche regionali e tutti gli strumenti urbanistici. Individuare strategie territoriali e rafforzare i livelli superiori di pianificazione. E POI ….
- 100. Luca Marescotti 100 / 100 DISCUSSIONI E DOMANDE? ... E QUESTI ALTRI E la Legge Urbanistica nazionale? Non andrebbe rivista? (a) una questione costituzionale da mettere a posto: le competenze. (b) Colmare le lacune senza stravolgere l'impianto di legge generale: per esempio: (b1) l'assoluta mancanza nella 1150/1942 dell'ambiente: questa sarebbe la modernizzazione della legge urbanistica (e poi che cosa mancherebbe?); (b2) gli aspetti economici (oneri di urbanizzazione e altro); (b3) le opere pubbliche. Tutto questo rimette in discussione l'assenza (o la latitanza?) dello Stato: un effetto dell'arretramento dello stato richiesto dal liberalismo mondiale.
