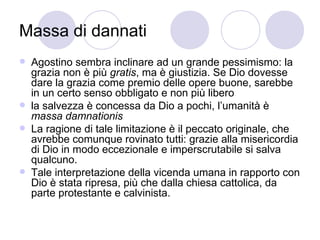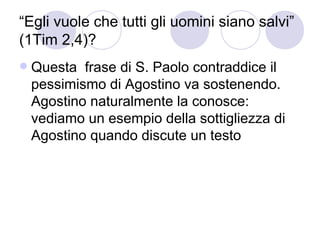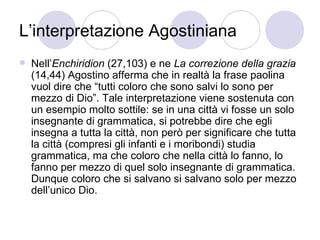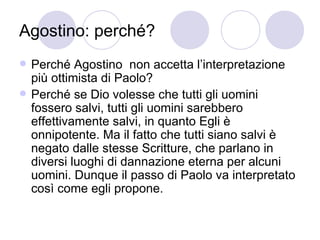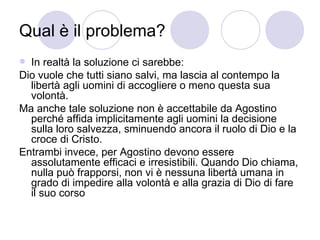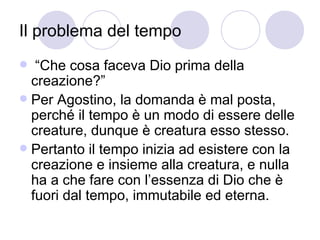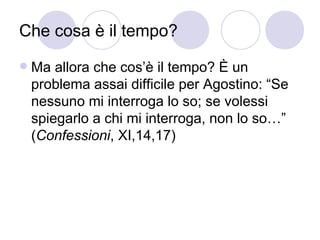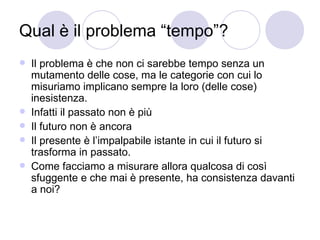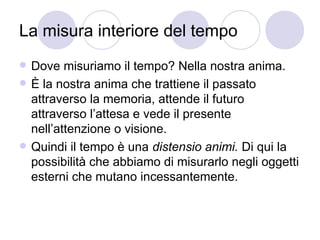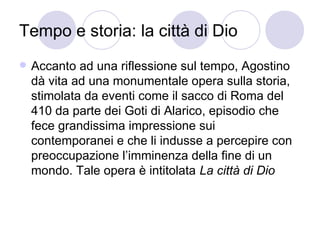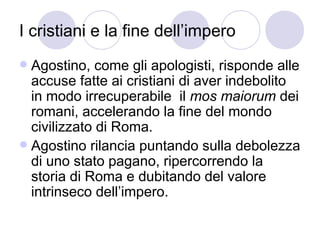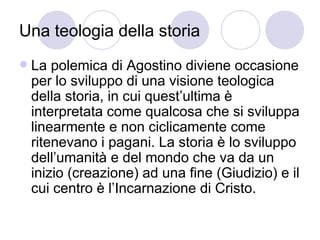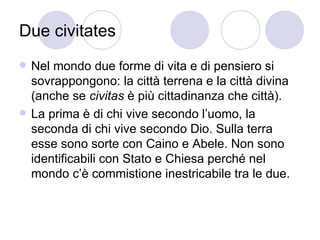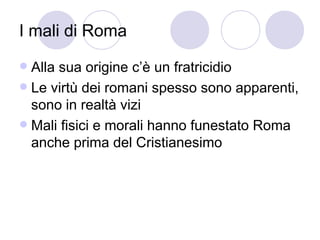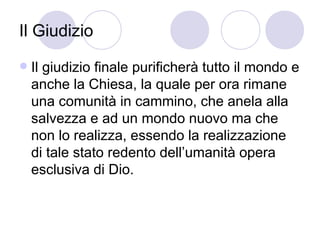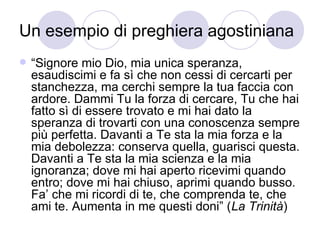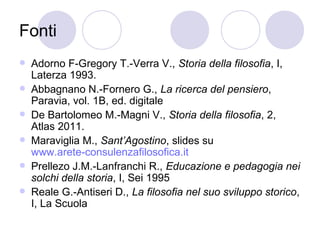Agostino, nato ad Tagaste nel 354, si convertì al cristianesimo dopo un periodo nel manicheismo, influenzato dalle prediche di Ambrogio a Milano e dalla sua madre Monica. Divenne vescovo di Ippona e combatté contro le eresie donatista e pelagiana, sostenendo che l'efficacia dei sacramenti non dipende dalla moralità del ministro. Le sue opere principali, come 'Le Confessioni' e 'La Città di Dio', esplorano la relazione tra fede e ragione, l'interiorità umana, e la ricerca della verità come un percorso verso Dio.
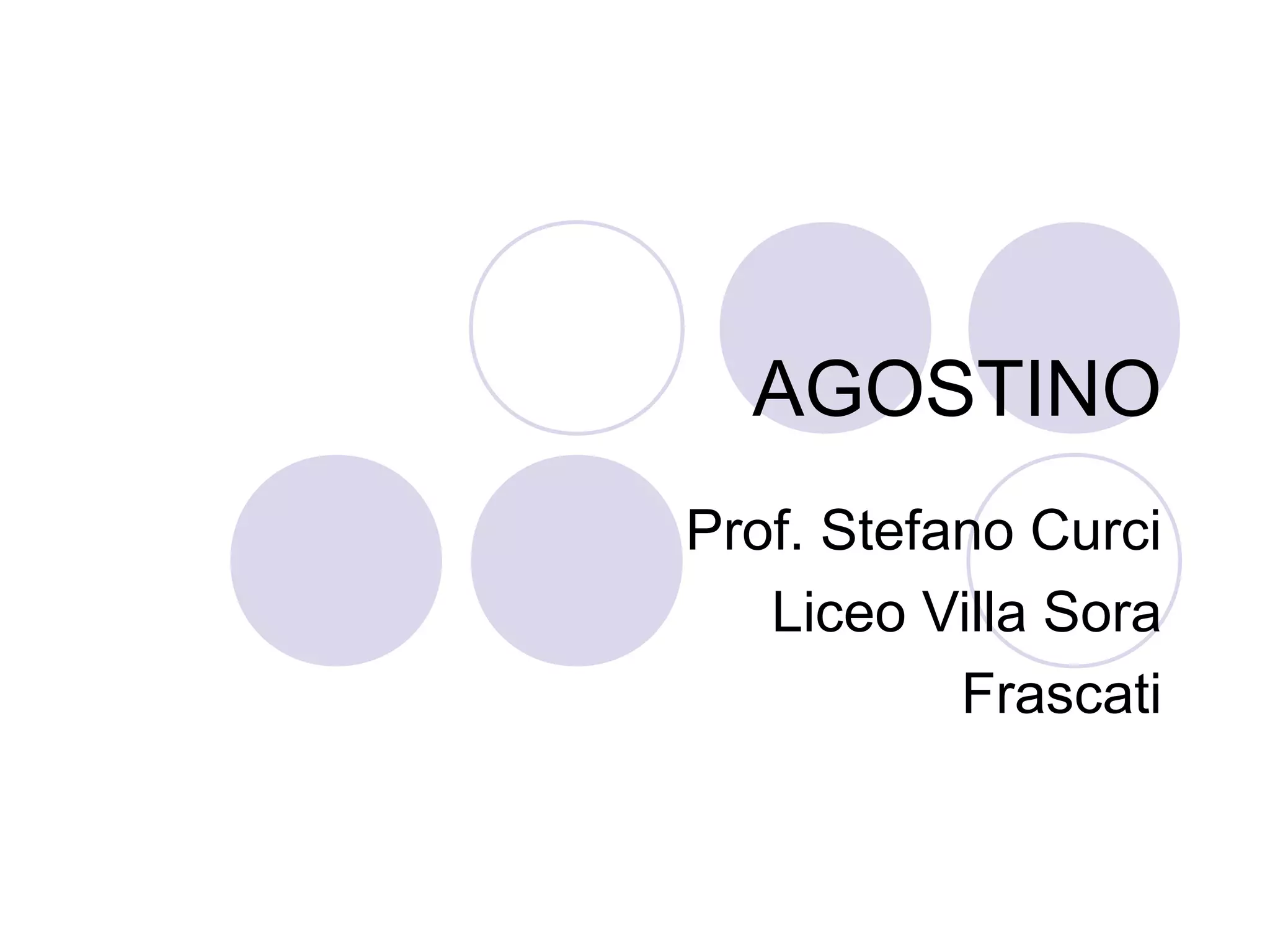
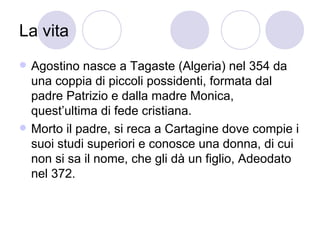
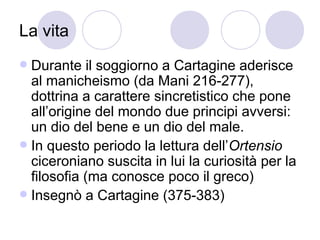
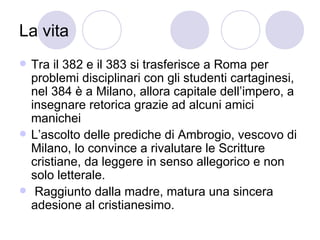
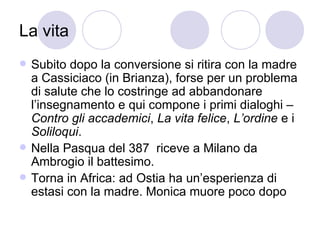
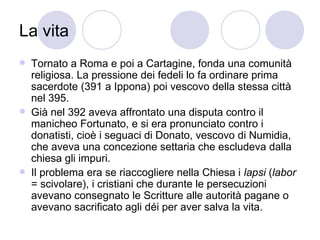
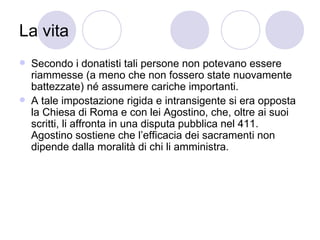
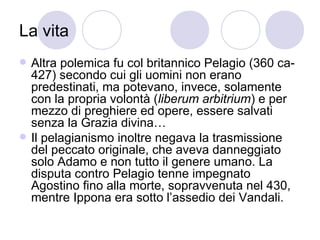
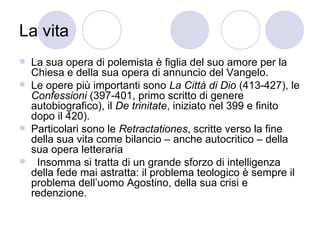
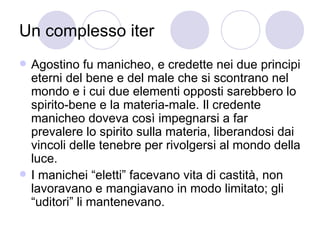
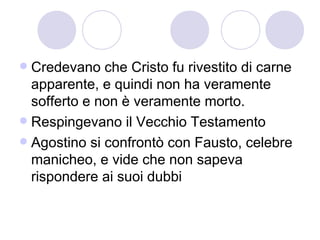
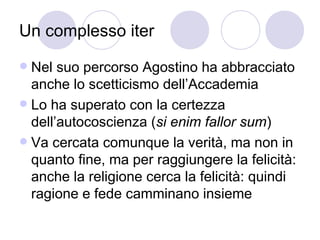
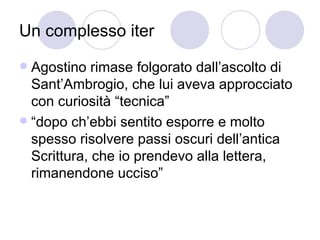
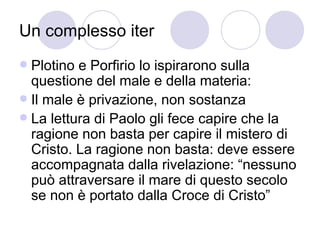
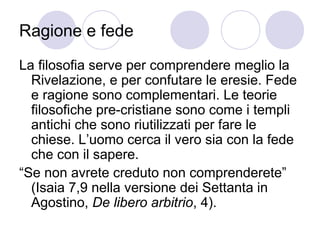
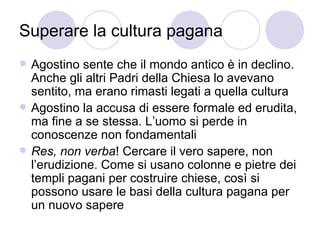
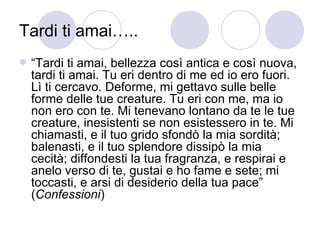
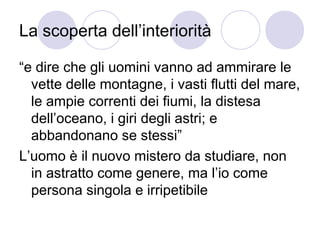
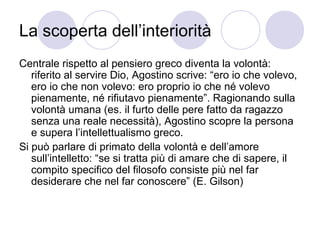
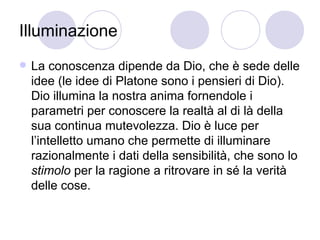
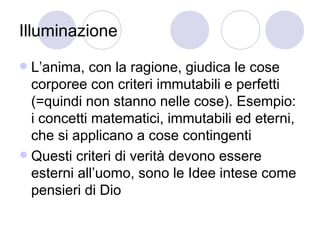
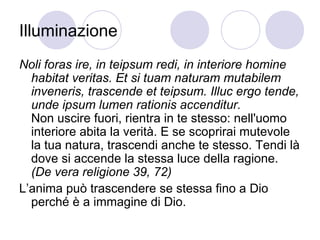
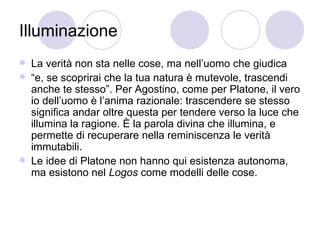
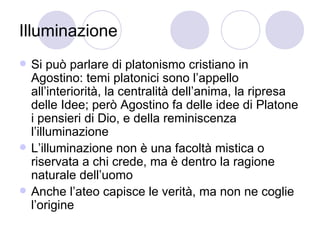
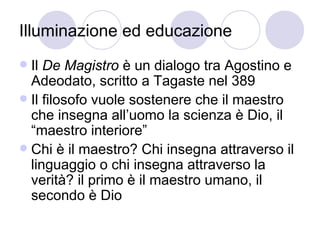
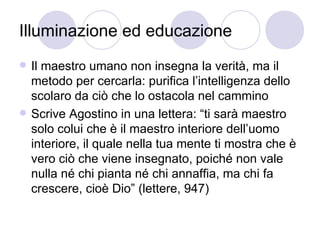
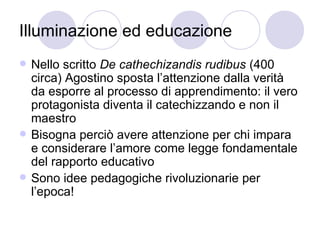
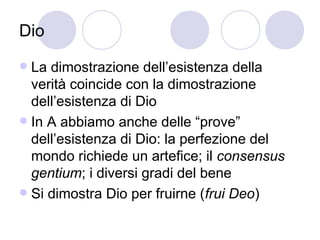
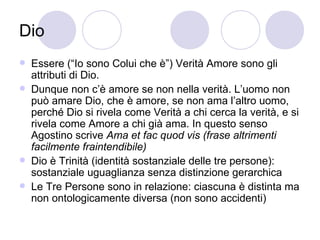
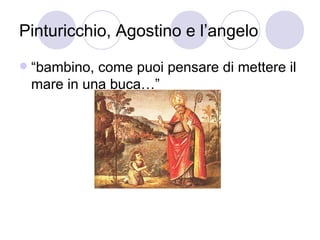
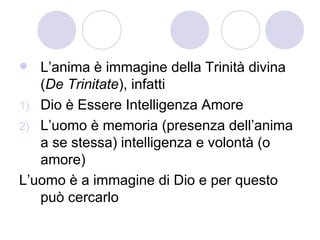
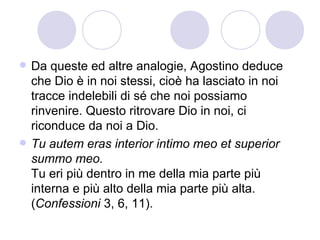
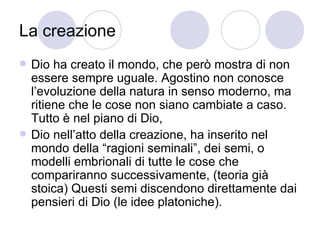
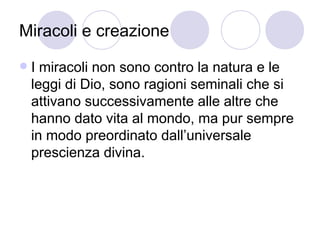
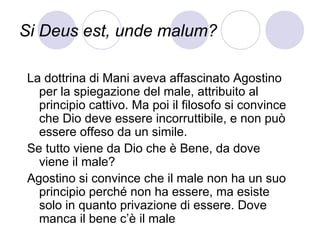
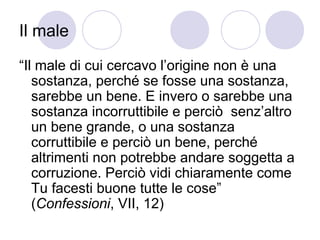
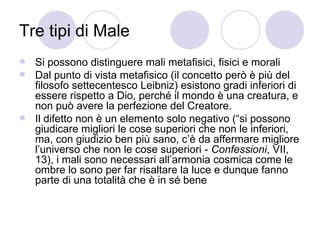
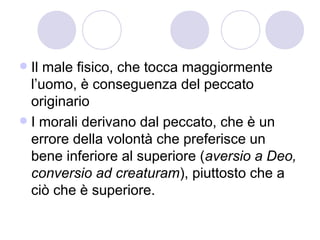
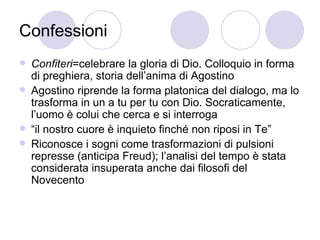
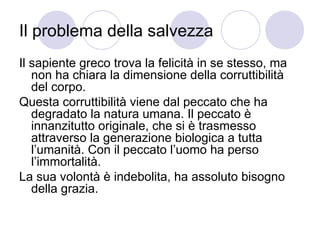
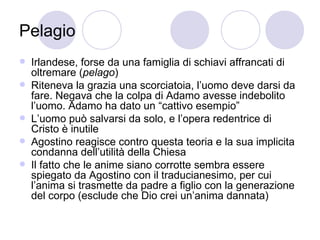
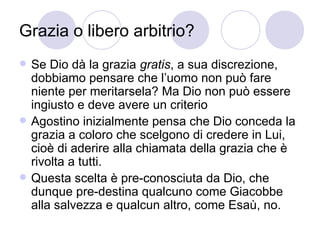
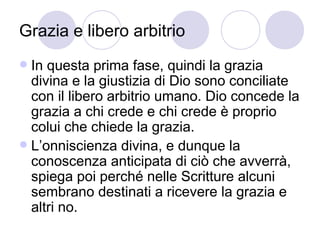
![Il cambio di rotta del 396-7: le Questioni a
Simpliciano
C’è però una tendenza di Agostino a radicalizzare il
discorso verso una scelta divina inaccessibile all’uomo:
“Nessuno infatti crede se non è chiamato. Ora, è Dio
nella sua misericordia a chiamare, e lo fa
indipendentemente dai meriti della fede, perché i meriti
della fede seguono e non precedono la chiamata […] Se
la misericordia non precede chiamando, nessuno può
credere per iniziare da qui ad essere giustificato e
ottenere la facoltà di bene operare. Dunque la grazia
viene prima di qualunque merito” (Questioni a Simpl., I,
2,7)](https://image.slidesharecdn.com/agostino2015-150420113014-conversion-gate01/85/Agostino-2015-44-320.jpg)