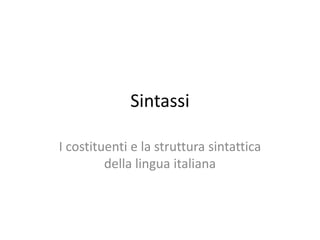
014 Costituenti e Struttura sintattica
- 1. Sintassi I costituenti e la struttura sintattica della lingua italiana
- 2. Costituenti Le unità sintattiche che a diversi livelli compongono la frase sono dette costituenti. • Parola → è l’unità minima della sintassi. Ciascuna parola appartiene ad una delle classi grammaticali o parti del discorso. • Sintagma → è il costituente intermedio tra parola e proposizione, e consiste in un gruppo sintattico di parole che ricopre particolari “posizioni” e funzioni all’interno della frase. • Proposizione → è l’unità di base del discorso. Comprende un soggetto, un predicato e, facoltativamente, dei complementi. • Frase → è l’unità di massima estensione grammaticale composta di unità inferiori (parole, sintagmi, proposizioni), dotata di senso compiuto e costruita secondo regole sintattiche. Può essere semplice, se costituita da un’unica proposizione, o complessa (periodo), se costituita da due o più proposizioni. • Enunciato → è l’unità testuale e pragmatica delimitata da pause-silenzi nel parlato e dal punto fermo nello scritto. Può essere costituito da una singola parola, da una frase semplice o da una frase complessa. Tutte le frasi sono enunciati, ma non viceversa (Ehi tu! in un particolare contesto è un enunciato, ma non costituisce una frase).
- 3. Sintagmi Il sintagma è il costituente intermedio tra parola e proposizione, e consiste in un gruppo sintattico di parole che può essere “spostato” da un punto all’altro della frase (mentre una sequenza arbitraria non potrebbe). es. Alberto / ha incontrato / un collega / in pizzeria / dopo il concerto. *Collega in, Alberto ha incontrato un ___ pizzeria dopo il concerto. I sintagmi si distinguono a seconda della categoria grammaticale a cui appartiene la loro parola principale (detta testa). Per esempio… • Sintagma Verbale (Noun Phrase) → ha per testa un verbo • Sintagma Nominale (Verb Phrase) → ha per testa un nome o un pronome • Sintagma Preposizionale (Prepositional Phrase) → ha per testa una preposizione che ne determina dipendenza sintattica e funzione es. [FRASE[SvHai svolto bene [SNl’esercizio [SPdi matematica]]]].
- 4. Teoria X-barra Il componente della grammatica che regola la struttura interna dei sintagmi è noto come teoria X-barra. Tale teoria vuole che in tutti i sintagmi venga realizzato un elemento che funge da testa (che determina la categoria d’appartenenza del sintagma stesso). Ogni sintagma è visto come la proiezione della propria testa e può combinarsi con altri costituenti per formare in modo ricorsivo un’ulteriore proiezione. Nel diagramma a fianco le teste X° si combinano con i loro complementi e specificatori per formare le proiezioni intermedie X’, che si combinano a loro volta con altri complementi e specificatori sino a formare la proiezione massimale SX. SP P° dietro N’ A l’ N° angolo P’ P°+A della N strada SINTAGMA PREPOSIZIONALE: [dietro l’angolo della strada]
- 5. Frase La frase è sempre una struttura predicativa: comunica attraverso un predicato lo stato o l’azione di un soggetto ed eventualmente altre informazioni circostanziali. I due elementi sempre coinvolti nella predicazione sono infatti il soggetto e il predicato. Le frasi sono articolare in costituenti che a loro volta possono essere scomposti in altri costituenti fino ad arrivare ai costituenti minimi, le parole. [FRASE[SNLa segretaria][SV[Vcomunicò][SNquella notizia][SPad un collega]].] Le frasi quindi non hanno solo una struttura lineare, ma anche una struttura gerarchica.
- 6. Indicatori sintagmatici Le rappresentazioni grafiche della struttura gerarchica di una frase vengono definite indicatori sintagmatici. Il sistema di rappresentazione più frequentemente utilizzato è il diagramma ad albero. FRASE: La segretaria comunicò quelle notizie ad un collega. FRASE SOGGETTO SN DETERMINANTE La NOME segretaria PREDICATO VERBALE SV VERBO comunicò TEMA SN DETERMINANTE quelle NOME notizie DESTINATARIO SP FUNZIONALE ad DETERMINANTE un NOME collega
- 7. Frase minima La frase minima è sempre composta da almeno due elementi: il predicato e il soggetto. Vi sono però alcune eccezioni: • Le frasi ellittiche con il soggetto o il verbo impliciti, ovvero non espressi da una particolare parola della frase, perché già presenti nelle frasi precedenti del contesto. • Le frasi con i verbi impersonali, ovvero quei verbi, sempre declinati alla III persona singolare, che non hanno un preciso soggetto (per es. alcuni verbi che esprimono condizioni atmosferiche come piove, nevica, grandina…). • Le frasi nominali, ovvero quelle frasi in cui il predicato non è espresso da nessun verbo (per es. alcuni titoli di giornale).
- 8. Predicato e soggetto • Predicato → è costituito da un sintagma verbale ed è l’elemento principale della frase poiché ha la funzione di predicare, ovvero di comunicare lo stato o l’azione di un soggetto. Il predicato può essere distinto in verbale, ovvero costituito dai verbi che predicano autonomamente, e nominale, ovvero costituito da verbi copulativi (come essere, sembrare, parere, diventare, …) che predicano collegando il soggetto ad un nome o ad un aggettivo. • Soggetto → è costituito da un sintagma nominale ed è il principale elemento che completa la predicazione del verbo e concorda grammaticalmente con esso. In ogni frase la posizione di soggetto deve essere sempre realizzata da un costituente. Quando quest’ultimo non è un sintagma nominale il suo ruolo può essere rivestito da un’intera proposizione (subordinata soggettiva).
- 9. Complementi diretti Oltre al soggetto altri elementi della frase costituiti da sintagmi nominali sono legati al verbo in modo diretto (ovvero senza preposizioni). La grammatica tradizionale li classifica in: • Complemento oggetto → riceve l’azione espressa da un verbo transitivo e compiuta dal suo soggetto. • Nome del predicato → completa la predicazione del verbo essere. • Complemento predicativo → completa la predicazione di un verbo copulativo, appellativo, estimativo, elettivo. • Complemento di vocazione → richiama l’attenzione di un destinatario della comunicazione.
- 10. Complementi indiretti I complementi costituiti da sintagmi preposizionali (complementi indiretti) arricchiscono ulteriormente il significato della predicazione verbale. Il loro numero e le loro definizioni dipendono in gran parte dalle scelte classificatorie dei singoli grammatici. Questi sono alcuni dei complementi principali classificati tradizionalmente nelle grammatiche: • di specificazione • di termine • di luogo • di tempo • di causa • di fine • di modo • di compagnia e unione • d’agente e di causa efficiente • partitivo …
- 11. Valenza verbale Nella seconda metà del ‘900 la linguistica strutturalista, in particolare il francese Lucien Tesnière, ha elaborato, mutuandolo dalla chimica, il modello della grammatica valenziale: • Il verbo è il nucleo della frase. Per esprimere pienamente il suo significato, il verbo attira a sé un numero di argomenti (il soggetto e i complementi) dettato dalla propria valenza. I verbi possono così essere classificati in base agli elementi che si legano direttamente a loro (dunque alla loro valenza, che è relativa anche alla frase in cui si trovano): • verbi zerovalenti → verbi impersonali come piove, nevica, grandina… • verbi monovalenti → verbi intransitivi che ammettono solo il soggetto. • verbi bivalenti → verbi che ammettono soggetto e un secondo complemento. • verbi trivalenti → ammettono soggetto e due complementi. • verbi tetravalenti → ammettono soggetto e tre complementi.
- 12. Modello valenziale VERBO TRIVALENTE (Predicato: dà) 1° ARGOMENTO (Soggetto: Luca) 2° ARGOMENTO (Compl. oggetto: una mela) 3° ARGOMENTO (Compl. di termine: a Maria) Luca dà una mela a Maria.
- 13. Argomenti e circostanti Gli argomenti sono gli costituenti che saturano la valenza di un verbo, sono tendenzialmente obbligatori ed indicano le entità direttamente coinvolte nella predicazione del verbo. I circostanti (o circostanziali) sono costituenti che, rispetto alla predicazione verbale, possono essere opzionalmente realizzati e forniscono informazioni aggiuntive relative al contesto. La combinazione dei verbi con altre parole non è data solo dalla valenza, ma anche dalla selezione, ovvero dai tratti semantici che il verbo richiede ai suoi argomenti. *Gianni ha invitato il piatto. (il verbo invitare non implica solo un complemento oggetto diretto, ma anche che il referente di quest’ultimo sia umano o perlomeno animato).
- 14. Teoria tematica Ogni predicato ha una struttura argomentale, richiede cioè un certo numero di argomenti che indicano il numero minimo di partecipanti coinvolti nell’attività o nello stato espressi dal verbo stesso. Rispetto agli argomenti richiesti, i verbi si possono classificare in: • Transitivi → richiedono almeno un partecipante che compie (soggetto) e uno che riceve l’azione (un complemento oggetto) (adorare, amare, odiare, aprire…). • Ditransitivi → richiedono almeno un partecipante che compie (soggetto), uno che subisce (complemento oggetto o oggetto diretto) e uno che riceve l’azione (complemento di termine o oggetto indiretto) (dare, consegnare, inviare, dire…). • Intransitivi propri/inergativi → sono intransitivi con l’ausiliare avere ai tempi composti come lavorare, camminare, ridere, dormire… • Intransitivi inaccusativi → sono intransitivi con l’ausiliare essere ai tempi composti come arrivare, cadere, scoppiare, sparire… • Ergativi → verbi che hanno sia una forma intransitiva con l’ausiliare essere alla forma composta, che una forma transitiva con l’ausiliare avere alla forma composta (La nave è affondata. I pirati hanno affondato la nave. I prezzi sono aumentati. I produttori hanno aumentato i prezzi.).
- 15. Ruolo tematico La specifica relazione semantica tra il verbo e suoi argomenti viene definita ruolo tematico. I ruoli tematici degli argomenti generalmente riconosciuti sono… Agente Entità che intenzionalmente dà inizio all’azione Paolo ha corso. Mio fratello ha telefonato a Giorgio Tema/paziente Entità che subisce l’azione Loro hanno invitato Carlo. Il gatto è stato investivo dall’auto. Esperiente Entità che sperimenta uno stato psicologico Maria desidera un divano nuovo. A mia madre piacciono i gatti Beneficiario Entità che trae beneficio dall’azione Ha regalato un libro al suo amico. Questa situazione ha aiutato Anna. Destinatario/m eta Entità/luogo verso cui è diretta l’azione Lei ha spedito la lettera a Gianni. Sono andato in campagna Provenienza Entità/luogo dalla quale qualcosa si muove. Maria arriva dalla stazione. Abbiamo preso il libro dalla biblioteca. Locativo Entità/luogo in cui si situa l’azione. Ho messo il libro sul tavolo. I miei cugini abitano in Svizzera. Comitativo Entità che entra in interazione con l’agente. Il direttore ha preso accordi con loro. Ho litigato con Luigi. Strumentale Entità attraverso cui si realizza l’azione. L’incendio è stato spento con l’idrante. Con l’argilla si creano molte cose.
- 16. Struttura argomentale La struttura argomentale di un predicato stabilisce quali siano i componenti minimi della frase e i loro temi. Ciascuno di questi componenti è normalmente rappresentato da un particolare tipo di sintagma, ma può essere anche rappresentato da costituenti intermedi diversi (formati da costituenti minimi con funzioni grammaticali diverse). invitare: <agente SN, paziente SN> → Giovanni invita Lucia. desiderare: <esperiente SN, tema SN/F> → Luca desidera una moto/acquistare una moto. regalare: <agente SN, tema SN, beneficiario SP> → I colleghi regalarono a Luca una moto. rimanere: <tema SN, locativo SP> → La zia rimase al mare. accordarsi: <agente SN, comitativo SP> → Il sindacato si accordò con l’azienda. Quando ciascun ruolo tematico è stato assegnato a un argomento il verbo si dice saturato.
Editor's Notes
- Frase e proposizione sono categorie della struttura astratta del linguaggio, come la parola. Dunque “frase” non coincide esattamente con “proposizione” perché può indicare una singola proposizione, ma anche un insieme di proposizioni coordinate o subordinate tra loro. Invece la distinzione tra “frase” ed “enunciato” si basa sull’opposizione tra unità grammaticale (la frase), dunque astratta, significativa anche al di fuori di un testo e di una situazione comunicativa, e un’unità testuale (l’enunciato), dunque legata a un determinato parlante un determinato momento e un determinato luogo. Una frase non può realizzarsi concretamente che in un enunciato, ovvero in un'espressione concreta, fisica. Mentre un enunciato può essere agrammaticale e dunque non identificabile con una frase.
- Alcune grammatiche distinguono anche il sintagma aggettivale o il sintagma avverbiale. Un’unità sintattica è un gruppo tipico di parole che hanno tra loro legami di reggenza o concordanza e che tendono ad essere unite in eventuali spostamenti all’interno della frase, per esempio l’articolo e l’aggettivo sono sempre legati a un nome o a un pronome, l’avverbio è spesso legato a un verbo, una preposizione introduce un nome o un pronome, ecc…
- Gli elementi X°, le singole parole (o verbi composti o locuzioni), sono detti nodi terminali, poiché non possono ramificare ulteriormente.
- Mentre il soggetto è uno dei termini del rapporto di predicazione, dunque esterno al predicato, l’oggetto è parte integrante della predicazione sul soggetto.
- Il nodo radice dell’albero è rappresentato dalla F che rappresenta la FRASE. Essa si scompone in soggetto, rappresentato da un sintagma nominale e predicato (in questo caso verbale). Questi si ramificano nei vari livelli dei loro costituenti sino ad arrivare ai costituenti minimi che sono le parole.
- Nelle frasi con soggetto implicito, la parola che dovrebbe indicare il soggetto è normalmente omessa per evitare inutili ripetizioni di termini già espressi nelle frasi precedenti, dunque per ragioni di economia ed eleganza della frase. I verbi impersonali si possono formare anche con il pronome “si” con valore di soggetto indefinito (per es. Si ritiene opportuno questo provvedimento.). Le frasi nominali si possono trovare in titoli di giornale (“Rapina in banca!”), in altre tipologie di titoli, in contesti informali o letterari.
- In latino il soggetto era sempre declinato con il caso del nominativo. Il soggetto non è mai introdotto da preposizione. In ogni frase la posizione di soggetto deve essere realizzata da un costituente (che deve essere almeno un nome o un pronome, ma può arrivare ad essere costituita da intere proposizioni).
- In latino il complemento oggetto si declinava col caso accusativo, il complemento di vocazione con il caso vocativo. I verbi copulativi sono quei verbi intransitivi di significato affine a quello del verbo essere come sembrare, parere, diventare, … Gli appellativi sono quei verbi di significato affine a quello del verbo chiamare, come definire, soprannominare, denominare… Gli estimativi sono quei verbi di significato affine a quello del verbo stimare, come giudicare, considerare, ritenere… Gli elettivi sono quei verbi di significato affine a quello del verbo eleggere, come proclamare, nominare, designare… Il complemento di vocazione è sempre inserito in un inciso o, se a inizio frase, seguito da una virgola. Occorre sottolineare che il destinatario della comunicazione e il soggetto grammaticale rappresentano due elementi ben distinti (anche quando significano lo stesso essere)!
- Altri complementi classici sono quelli di materia, colpa, argomento, qualità, età, paragone… In latino il complemento di specificazione si declinava col caso genitivo e quello di termine col caso dativo; i casi dell’accusativo e dell’ablativo, introdotti da preposizioni traducevano i vari complementi indiretti.
- I verbi trivalenti sono perlopiù quelli ditansitivi (dare, regalare, consegnare) I verbi tetravalenti sono pochissimi, perlopiù quelli transitivi col prefisso latino trans- che indica un passaggio (trasportare, trasferire, travasare).
- Oltre agli elementi legati al nucleo, nella frase possono esserci degli elementi extranucleari non riferiti al verbo, ma a uno dei suoi argomenti (costituenti) o all’intera frase.
- Mentre la valenza è puramente sintattica, la selezione è invece semantica.
- In inglese i verbi ditransitivi che reggono il doppio oggetto He gave ten dollars to Mary. Jean read the books to/for him. si possono dire anche con il doppio oggetto senza usare preposizioni He gave Mary ten dollars to Mary. Jean read him the books. Alcune caratteristiche che distinguono i verbi intransitivi inergativi dagli inaccusativi sono: la ripresa pronominale col pronome ne partitivo (Ne sono arrivati molti., ma non Ne hanno telefonato molti) oppure l’uso del participio passato come aggettivo o come nucleo di proposizioni implicite (Lo studente arrivato ieri. ma non Lo studente telefonato ieri. oppure Arrivato Pietro, siamo usciti. e non Telefonato Pietro, siamo usciti.).