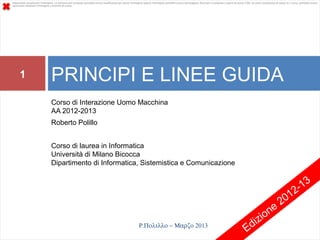
16. Principi e linee guida
- 1. Corso di Interazione Uomo Macchina AA 2012-2013 Roberto Polillo Corso di laurea in Informatica Università di Milano Bicocca Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione PRINCIPI E LINEE GUIDA1 Ρ.Πολιλλο − Μαρζο 2013 Edizione 2012-13
- 2. Indicazioni per il design: tipologia R.Polillo - Marzo 2013 4 coercitività generalità standard regole di progetto linee guida principi bassa bassa alta alta
- 3. Indicazioni per il design: autorevolezza 4 livelli: A: Completamente supportate da risultati di ricerca e dati empirici B: Basate su pratica generalmente accettata (in modo documentato) C:Non ben documentate, ma supportate dall’opinione di professionisti D: Opinione individuale Standard: solo livelli A e B R.Polillo - Marzo 2013 6
- 4. Gli standard per la usabilità 7 Situazione complessa: gli standard sono in continua evoluzione (www.iso.org; www.uninfo.it) Ci sono standard di prodotto e standard di processo I principali: ISO 13047 “Human centred design processes for interactive system” ISO 9241 ““Ergonomic requirements for office work with visual display terminals” ISO 14915 “Software ergonomics for multimedia user- interfaces” R.Polillo - Marzo 2013
- 5. Part 1: General introduction Part 2: Guidance on task requirements Part 4: Keyboard requirements Part 5: Workstation layout and postural requirements Part 6: Guidance on the work environment Part 9: Requirements for non-keyboard input devices Part 11: Guidance on usability Part 12: Presentation of information Part 13: User guidance Part 14: Menu dialogues Part 15: Command dialogues Part 16: Direct manipulation dialogues Part 17: Form filling dialogues Part 20: Accessibility guidelines for ICT equipment and services Part 100: Introduction to standards related to software ergonomics Part 110: Dialogue principles Part 129: (DIS) Guidance on software individualization Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces Part 171: Guidance on software accessibility Part 210: Human-centred design for interactive systems Part 300: Introduction to electronic visual display requirements Part 302: Terminology for electronic visual displays Part 303: Requirements for electronic visual displays Part 304: User performance test methods for electronic visual displays Part 305: Optical laboratory test methods for electronic visual displays Part 306: Field assessment methods for electronic visual displays Part 307: Analysis and compliance test methods for electronic visual displays Part 308: Surface-conduction electron-emitter displays (SED) Part 309: Organic light-emitting diode (OLED) displays Part 400: Principles and requirements for physical input devices Part 410: Design criteria for physical input devices Part 420: (DIS) Selection procedures for physical input devices Part 910: (DIS) Framework for tactile and haptic interaction Part 920: Guidance on tactile and haptic interactions ISO 9241: Standard pubblicati (marzo 2010) 8 R.Polillo - Marzo 2013
- 6. Principi 9 Possono essere formulati in molti modi Nel seguito, esamineremo i sette principi del dialogo secondo lo standard ISO 9241 (Parte 110) R.Polillo - Marzo 2013
- 7. I 7 principi del dialogo secondo la ISO 9241-110:2006 10 1. Adeguatezza al compito 2. Autodescrizione 3. Conformità alle aspettative dell’utente 4. Adeguatezza all’apprendimento 5. Controllabilità 6. Tolleranza verso gli errori 7. Adeguatezza alla individualizzazione R.Polillo - Marzo 2013
- 8. Un “modello di qualità” 11 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Adeguatezza al compito Auto-descrizione Conformità alle aspettative dell’utente Adeguatezza all’apprendimento Controllabilità Tolleranza verso gli errori Adeguatezza alla individualizzazione R.Polillo - Marzo 2013
- 9. Confronto 12 R.Polillo - Marzo 2013
- 10. I 7 principi del dialogo secondo la ISO 9241-110:2006 13 1. Adeguatezza al compito 2. Autodescrizione 3. Conformità alle aspettative dell’utente 4. Adeguatezza all’apprendimento 5. Controllabilità 6. Tolleranza verso gli errori 7. Adeguatezza alla individualizzazione R.Polillo - Marzo 2013 La funzionalità del sistema e il dialogo sono basati sulle caratteristiche del compito, piuttosto che sulla tecnologia scelta per effettuarlo
- 11. Adeguatezza al compito: esempio 14 R.Polillo - Marzo 2013
- 12. Adeguatezza al compito: raccomandazioni 15 Passi Informazioni Dispositivi di I/O Formati di input Dialogo essenziale Default tipici Compatibilità con i documenti R.Polillo - Marzo 2013 adeguati al compito
- 13. Passi adeguati al compito 16 R.Polillo - Marzo 2013
- 14. Dialogo essenziale R.Polillo - Marzo 2013 17
- 15. I 7 principi del dialogo secondo la ISO 9241-110:2006 18 1. Adeguatezza al compito 2. Autodescrizione 3. Conformità alle aspettative dell’utente 4. Adeguatezza all’apprendimento 5. Controllabilità 6. Tolleranza verso gli errori 7. Adeguatezza alla individualizzazione R.Polillo - Marzo 2013 Agli utenti risulta evidente, in ogni momento, in che dialogo si trovano, a che punto si trovano all’interno del dialogo, quali azioni possono compiere e come queste possono essere effettuate
- 16. Autodescrizione: raccomandazioni 19 Guida all’utente Interazione evidente Manualistica minima Stato visibile Descrizione dell’input atteso Formati descritti R.Polillo - Marzo 2013
- 17. Interazione evidente: esempio R.Polillo - Marzo 2013 20 Pagina web con menu le cui scritte appaiono come roll-over: da evitare!
- 18. R.Polillo - Marzo 2013
- 19. R.Polillo - Marzo 2013 http://www.brigaderia.com.br
- 20. R.Polillo - Marzo 2013 23
- 21. 7° giornata Inter-Lazio Milan-Atalanta Juventus-Parma Bari-lecce Udinese-Roma Indietro Ok 24 R.Polillo - Marzo 2013
- 22. I 7 principi del dialogo secondo la ISO 9241-110:2006 25 1. Adeguatezza al compito 2. Autodescrizione 3. Conformità alle aspettative dell’utente 4. Adeguatezza all’apprendimento 5. Controllabilità 6. Tolleranza verso gli errori 7. Adeguatezza alla individualizzazione R.Polillo - Marzo 2013 Il dialogo corrisponde alle necessità dell’utente, prevedibili in base al contesto e a convenzioni comunemente accettate
- 23. Conformità alle aspettative dell’utente 26 Linguaggio familiare Aderenza alle convenzioni Organizzazione abituale Dialogo consistente Tempi di risposta conformi alle aspettative Feedback conforme alle aspettative Messaggi adeguati al contesto Output in posizione appropriata Input in posizione attesa Stile dei messaggi coerente R.Polillo - Marzo 2013
- 24. Aderenza alle convenzioni 27 R.Polillo - Marzo 2013
- 25. 28 Link interni al sito Link esterni al sito Link alla home page Search engine interna Banners pubblicitari Login /registrazione Shopping cart Help Links ai prodotti Bernard, 2001 Organizzazione abituale R.Polillo - Marzo 2013
- 26. Dialogo consistente 29 R.Polillo - Marzo 2013
- 27. 30 R.Polillo - Marzo 2013
- 28. 31 R.Polillo - Marzo 2013
- 29. 32 R.Polillo - Marzo 2013
- 30. 33 R.Polillo - Marzo 2013
- 31. Es. di incoerenza: menu che si trasformano 34 R.Polillo - Marzo 2013
- 32. 1. PowerPoint 2007 2. Word 2007 3. Excel 2007 21 3 35 R.Polillo - Marzo 2013
- 33. Tempi di risposta conformi alle aspettative 36 R.Polillo - Marzo 2013
- 34. Messaggi in posizione appropriata 37 R.Polillo - Marzo 2013
- 35. 38 R.Polillo - Marzo 2013
- 36. Input in posizione attesa 39 Da Word 2007 R.Polillo - Marzo 2013
- 37. Stile dei messaggi coerente: esempio 40 R.Polillo - Marzo 2013
- 38. R.Polillo - Marzo 2013
- 39. R.Polillo - Marzo 2013
- 40. I 7 principi del dialogo secondo la ISO 9241-110:2006 43 1. Adeguatezza al compito 2. Autodescrizione 3. Conformità alle aspettative dell’utente 4. Adeguatezza all’apprendimento 5. Controllabilità 6. Tolleranza verso gli errori 7. Adeguatezza alla individualizzazione R.Polillo - Marzo 2013 Il dialogo supporta e guida l’utente nell’apprendiment o del sistema
- 41. Adeguatezza all’apprendimento: raccomandazioni Aiuto alla familiarizzazione Bassa soglia di apprendimento Feedback intermedi Sperimentazione sicura Modello concettuale evidente Riapprendimento facilitato R.Polillo - Marzo 2013 44
- 42. Bassa soglia di apprendimento R.Polillo - Marzo 2013 45
- 43. Α Β Χ R.Polillo - Marzo 2013 Da PowerPoint 2007
- 44. Aiuto alla familiarizzazione R.Polillo - Marzo 2013 47
- 45. Aiuto alla familiarizzazione R.Polillo - Marzo 2013 48
- 46. R.Polillo - Marzo 2013
- 47. R.Polillo - Marzo 2013
- 48. Feedback intermedi: esempio 51 www.trenitalia.itR.Polillo - Marzo 2013
- 49. Aiuto online R.Polillo - Marzo 2013 52 Da PowerPoint 2007
- 50. Modello concettuale evidente R.Polillo - Marzo 2013 53
- 51. I 7 principi del dialogo secondo la ISO 9241-110:2006 54 1. Adeguatezza al compito 2. Autodescrizione 3. Conformità alle aspettative dell’utente 4. Adeguatezza all’apprendimento 5. Controllabilità 6. Tolleranza verso gli errori 7. Adeguatezza alla individualizzazione R.Polillo - Marzo 2013 L’utente è in grado di iniziare e tenere sotto controllare la direzione e i tempi dell’interazione fino al raggiungimento dell’obbiettivo
- 52. Controllabilità: esempio di dialogo non controllabile R.Polillo - Marzo 2013 55 (1) Patient’s name: (first-last) **FRED SMITH (2) Sex: **MALE (3) Age: **55 (4) Have you been able to obtain positive cultures from a site at which Fred Smith has an infection? **YES (5) What is the infection? **PRIMARY-BACTEREMIA (6) Please give the date and approximate time when signs of symptoms first appeared (Mycin)
- 53. Controllabilità: raccomandazioni 56 Tempi dell’interazione controllati dall’utente Proseguimento del dialogo controllato dall’utente Punto di ripartenza controllato dall’utente Disponibilità di undo Disponibilità dei dati originali Modalità di visualizzazione dei dati controllata dall’utente Dispositivo d’interazione controllato dall’utente Personalizzazione dei valori di default R.Polillo - Marzo 2013
- 54. Punto di ripartenza controllato dall’utente R.Polillo - Marzo 2013 57
- 55. I 7 principi del dialogo secondo la ISO 9241-110:2006 58 1. Adeguatezza al compito 2. Autodescrizione 3. Conformità alle aspettative dell’utente 4. Adeguatezza all’apprendimento 5. Controllabilità 6. Tolleranza verso gli errori 7. Adeguatezza alla individualizzazione R.Polillo - Marzo 2013 Nonostante evidenti errori negli input, i risultati desiderati possono essere ottenuti senza o con minime azioni correttive
- 56. I 7 principi del dialogo secondo la ISO 9241-110:2006 60 1. Adeguatezza al compito 2. Autodescrizione 3. Conformità alle aspettative dell’utente 4. Adeguatezza all’apprendimento 5. Controllabilità 6. Tolleranza verso gli errori 7. Adeguatezza alla individualizzazione R.Polillo - Marzo 2013 L'utente può modificare l’interazione e la presentazione dell’informazione per adattarle alle proprie necessità e capacità individuali
- 57. Adeguatezza alla individualizzazione: raccomandazioni Adattamento al profilo dell’utente Scelta di rappresentazioni alternative Scelta del livello delle spiegazioni Vocabolario personalizzabile Personalizzazione dei tempi di risposta Scelta del metodo di interazione Personalizzazione del dialogo Ripristinabilità dei valori precedenti R.Polillo - Marzo 2013 61
- 58. Scelta di rappresentazioni alternative R.Polillo - Marzo 2013 62 MacOS Finder 10.6
- 59. R.Polillo - Marzo 2013 63 MacOS Finder 10.6 Scelta di rappresentazioni alternative
- 60. Vocabolario personalizzabile R.Polillo - Marzo 2013 64 Ning, 2009
- 61. Scelta del metodo d’interazione R.Polillo - Marzo 2013 65
- 62. 66 Microsoft Word 2008 per Mac R.Polillo - Marzo 2013
- 63. Personalizzazione dei tempi di risposta R.Polillo - Marzo 2013 67 MacOS Finder 10.6
- 64. Personalizzazione del dialogo 68 Microsoft Word 2008 per Mac R.Polillo - Marzo 2013
- 65. 69 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Adeguatezza al compito Auto-descrizione Conformità alle aspettative dell’utente Adeguatezza all’apprendimento Controllabilità Tolleranza verso gli errori Adeguatezza alla individualizzazione R.Polillo - Marzo 2013
- 66. Le euristiche di Nielsen 1. Visibilità dello stato del sistema 2. Corrispondenza fra il mondo reale e il sistema 3. Libertà e controllo da parte degli utenti 4. Consistenza e standard 5. Prevenzione degli errori 6. Riconoscere piuttosto che ricordare 7. Flessibilità ed efficienza d’uso 8. Design minimalista ed estetico 9. Aiutare gli utenti a riconoscere gli errori, diagnosticarli e correggerli 10. Guida e documentazione (Vedi J.Nielsen, How to conduct a Heuristi Evaluation, in http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html ) 70
Editor's Notes
- R.Polillo, Interazione uomo macchina - Parte prima, 8
- www.ccjensen.com Dalla home page si sceglie APPLICATIONS, e viene fuori questo, che è il menu delle applicazioni! R.Polillo, Interazione uomo macchina - Parte prima, 8
- R.Polillo, Interazione uomo macchina - Parte prima, 8
- Sito ufficiale del film “The Story of Us”, ottobre 1999 R.Polillo, Interazione uomo macchina - Parte prima, 8
- Sito ufficiale del film “The Story of Us”, ottobre 1999 La struttura di navigazione trasversale presenta molti problemi. Infatti: Il menù (rappresentato dal “ mazzo ” di fotografie, cambia forma e contenuti nei vari contesti (nella home page sono 5 foto, nelle pagine di livello 1 sono 4 foto, mancando quella della pagina corrente. Inoltre in due pagine manca il menu. Perchè?) Il titolo cambia passando dalla home page alle pagine di primo livello. Es.: “ The Marriage ” diventa “ Story – The Marriage ” . Il secondo titolo si vede, sulla home page, passando il mouse sulla fotografia relativa. R.Polillo, Interazione uomo macchina - Parte prima, 8
- R.Polillo, Interazione uomo macchina - Parte prima, 8
