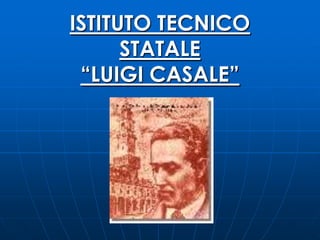
Funzione di domanda
- 1. ISTITUTO TECNICO STATALE “LUIGI CASALE”
- 2. LE FUNZIONI ECONOMICHE DI UNA VARIABILE - FUNZIONE DI DOMANDA Franchini Deborah Valentini Rita Classe IV A IGEA
- 3. Che cos’è l economia? L’economia è una scienza che studia il modo con cui i soggetti economici prendono le decisioni per utilizzare al meglio le loro risorse Le decisioni dei soggetti economici devono essere razionali quindi si affidano ai modelli e alle regole della matematica al fine di: Minimizzare i costi; Massimizzare i ricavi
- 4. Cos’è una funzione economica? Le funzioni economiche sono funzioni che rappresentano l’andamento economico di un bene sul mercato: esse sono le funzioni di domanda, offerta, costo totale, costo marginale,ricavo e utile.
- 5. IL MODELLO MATEMATICO Il modello matematico è un modello che rappresenta la realtà attraverso una funzione matematica che dovrà essere massimizzata o minimizzata e che dovrà rispettare vincoli di segno, tutte le funzioni sono studiate nell’intervallo x >= 0, e dei vincoli tecnici, come ad esempio la massima capacitò produttiva o le ore di lavoro ecc..
- 6. LA FUNZIONE DI DOMANDA La domanda di una merce è la quantità che viene richiesta ad un dato prezzo dagli acquirenti. La funzione di domanda è decrescente rispetto al prezzo, cio’ significa che all’ aumento del prezzo corrisponde una diminuzione della domanda. La domanda puo’ essere: INDIVIDUALE: indica la quantità di merce che il singolo è disposto a chiedere ad un determinato prezzo, in un dato momento, in un dato mercato GLOBALE: indica la quantità di merce che il complesso degli acquirenti in un mercato è disposto a chiedere ad un determinato prezzo, in un dato momento. In matematica la domanda è rappresentata da questa funzione x = f(P) X = quantità di merce richiesta p=prezzo Tale funzione è definita anche funzione di vendita perché mette in evidenza il prezzo al quale il produttore può vendere la quantità q della propria merce a seconda della domanda presente sul mercato
- 7. DEFINIZIONI.. Bisogno L'esistenza umana è caratterizzata da stati di insoddisfazione e di necessità chiamati quot;bisogniquot;. Sono esempi di bisogni quello del mangiare, dettato da esigenze di natura fisica(nutrirsi) oppure quello di doversi spostare da una città all'altra, dettato dal fatto che una persona abita in luogo diverso da quello in cui lavora. Bene Si definisce quot;benequot; il mezzo idoneo a soddisfare un bisogno. Sono pertanto beni il cibo consumato per soddisfare il bisogno di nutrirsi oppure il mezzo di trasporto utilizzato per recarsi da una città all'altra. I beni si dicono economici quando sono presenti in misura limitata rispetto ai bisogni che devono soddisfare. Prezzo di mercato Dalla interazione tra il comportamento dell'acquirente e del venditore, domanda e offerta necessariamente si incontrano: in corrispondenza ad un determinato prezzo e per determinate quantità sono soddisfatte le aspettative di entrambi gli agenti sul mercato. Tale situazione viene definita quot;punto di equilibrioquot;, in corrispondenza del quale si determina il prezzo di mercato o prezzo di equilibrio. Trasparenza di mercato e di libero ingresso Per effetto della trasparenza di mercato abbiamo che: TUTTE LE UNITA' DEL BENE CONTRATTATE NEL MERCATO VENGONO VENDUTE (ACQUISTATE) ALLO STESSO PREZZO. Infatti, come conseguenza della trasparenza di mercato, accade che: -il produttore che volesse vendere ad un prezzo più alto di quello corrente rischierebbe di perdere la clientela: nessun consumatore sarebbe disposto a pagare un prezzo più alto di quello corrente; -il compratore che volesse acquistare ad un prezzo più basso di quello corrente rischierebbe di non acquisire alcuna dose del bene considerato in quanto nessun produttore sarebbe disposto a cedergli il bene richiesto a prezzo più basso di quello praticato da tutti gli altri. Quando operiamo matematicamente su queste grandezze consideriamo sempre che il prezzo vigente in un dato momento è unico.
- 8. CASO 1 d=(a-p)/b a>0, b>0 è una funzione di domanda di 1 grado, cioè lineare. Si ha: p=0, d=a/b d=0, p=a graficamente è rappresentata da un segmento di retta.
- 9. CASO 2 d=(a-p2)/b a>0, b>0 è una funzione di secondo grado, cioè parabolica. Infatti si può scrivere come segue: quest'ultima, come facilmente si riscontra, è una parabola avente le seguenti caratteristiche: volge la concavità verso il basso; ha il vertice nel punto V(0,a/b); interseca il semiasse positivo delle ascisse in p=a. Si ha cioè: p=0 d=0 Graficamente quindi la funzione di domanda considerata è rappresentata dall'arco di parabola passante per i punti (0,a/b) e (a,0); in proposito si osservi la figura seguente.
- 10. CASO 3 La funzione d= a/p con a>0 è una iperbole equilatera perciò si verifica che: quando il prezzo p si avvicina a zero la domanda d cresce indefinitamente quando il prezzo p cresce indefinitamente la domanda d tende ad annullarsi Graficamente quindi la funzione di domanda considerata è rappresentata da un ramo di iperbole equilatera (1 quadrante) come si può osservare nella figura seguente
- 11. CASO 4 La funzione domanda del tipo: d=a/(p+c)+b con a>0, b>0, c>0, è una funzione di tipo iperbolico. Inizialmente per p=0 si ha d=a /c+b quindi al crescere di p la domanda d decresce indefinitamente e tende a b. Infatti occorre notare che crescendo p, il rapporto decresce e tende a zero perciò d tende a b. Graficamente la funzione di domanda considerata e rappresentata come segue: Osserviamo che per p che cresce indefinitamente la d tende a b pertanto la curva di domanda iperbolica ha come asintoto la retta di equazione d=b, parallela all'asse delle ascisse in questo caso specifico, mentre nel caso 3 ha come asintoto l'asse delle x, cioè d=0. La curva di domanda iperbolica è l'unica che abbia la seguente caratteristica: per quanto alto possa essere il prezzo esiste un minimo di quantità domandata.
- 12. IL MODELLO LINEARE Uno dei modelli matematici che usiamo per descrivere la variabilità di una funzione del suo prezzo è il modello lineare d = mp + q. In questo caso la funzione è rappresentata da un segmento di retta. Non consideriamo tutta la retta perché sia p che q non possono assumere valori negativi.
- 13. IL MODELLO PARABOLICO d = ap2 + bp + c Ricordando che la funzione deve essere decrescente, se poniamo a<0 la rappresentazione grafica è dei seguenti tipi.
- 14. IL MODELLO ESPONENZIALE d = a * e -bp In questo caso, per avere la funzione della domanda positiva e decrescente per p ≥ 0 deve essere a>0 e b>0. d tende a 0, se p tende a +∞. GRAFICO
- 15. L’ELASTICITA’ DELLA DOMANDA Al variare del prezzo p varia anche la domanda d. Il modo di variazione del prezzo è diverso a seconda della merce. Chiamiamo elasticità della domanda la capacità della domanda a reagire alla variazione del prezzo. Per misurare l’elasticità si utilizza il coefficiente di elasticità. Per definirlo, dati due prezzi p1 e p2 di uno stesso bene, consideriamo la variazione relativa del prezzo (p2-p1) / p1 = ∆p / p1 e, analogamente, per le corrispondenti domande d1 e d2, la variazione della domanda (d2-d1) / d1 = ∆d/d1.
- 16. DOMANDA RIGIDA Se |εd| < 1, si dice che la domanda è rigida (o non elastica). Alla variazione di 1 punto percentuale del prezzo, corrisponde una variazione della domanda inferiore a 1. Ciò significa che all’aumento del prezzo, la domanda cala lentamente. Questo succede ai beni di prima necessità; anche se il prezzo aumenta, i consumatori continuano ugualmente a farne uso.
- 17. DOMANDA ELASTICA Se |εd| > 1, si dice che la domanda è elastica. Alla variazione di un punto percentuale del prezzo, corrisponde una variazione della domanda inferiore a 1. Ciò significa che all’aumentare del prezzo, cala fortemente la sua richiesta. Questo succede per i beni voluttuari. Se il prezzo aumenta molto, i consumatori cercano di farne a meno.
- 18. DOMANDA ANELASTICA Se |εd| = 1, si dice che la domanda è anaelastica (o unitaria). Alla variazione di 1 punto percentuale del prezzo, corrisponde una variazione della domanda anch’essa di 1.
