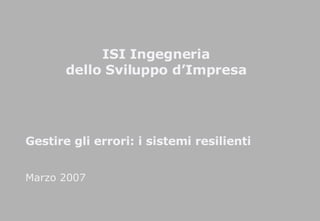
i sistemi resilienti
- 1. Gestire gli errori: i sistemi resilienti Marzo 2007 ISI Ingegneria dello Sviluppo d’Impresa
- 6. CLASSIFICAZIONE SISTEMICA DEGLI ERRORI CAUSE DI ERRORE LIVELLI DI CONTROLLO Difficoltà di ragionamento, per via della scarsità di notizie, risorse o di tempo. Difficoltà alla memorizzazione delle regole Carenze individuali in termini di velocità, precisione o forza fisica. Mancanza e/o scarsità di risorse Variabilità dovuta al caso Interferenze tra strutture di controllo Effetti dell’apprendimento e dell’adattamento False analogie o interferenze tra i mezzi a disposizione e gli scopi. Adesione routinaria alle regole più familiari. Cattura di schemi motori che vengono usati con maggiore frequenza. Errori di memoria nei modelli mentali già sperimentati. Ricordo errato dei dati e dei parametri contenuti nelle regole Disattenzione transitoria o non coordinamento motorio. Difettosità nella ricerca delle informazioni e nella formulazione delle ipotesi. Applicazione delle regole del minimo sforzo (genericità e superficialità) dei controlli. Imperfezione delle procedure per ottimizzare l’accuratezza e la velocità richiesta dall’operazione. Conoscenza Regole Abilità
- 7. I MODELLI LINEARI: L’APPROCCIO ACCUSATORIO Gli errori o gli incidenti possono essere affrontati con diversi tipi di approcci: uno mirato alla persona, e uno mirato sistema. L’approccio alla persona si focalizza sugli errori che gli individui possono commettere e quindi l’attenzione è fondamentalmente rivolta alle persone in prima linea (front-line). Si tratta del margine più esterno del sistema, coloro che operano in stretto contatto con l’ambiente, con gli altri sistemi, coloro che sono più prossimi all’errore o all’incidente. Questo tipo di approccio focalizza l’attenzione sui limiti cognitivi degli individui (colpevoli di disattenzione, approssimazione, imperizia, etc.) e prevedono normalmente contromisure di tipo disciplinare e punitivo, confondendo errori e violazioni intenzionali, ineliminabili limiti cognitivi e sabotaggi. Il modello, di tipo lineare (di tipo causa-effetto), non va però ad eliminare le condizioni organizzative che portano all’errore e non permette al sistema e al contesto in cui esso si trova di migliorare, di apprendere dai propri errori e di aumentare la propria capacità di essere resiliente.
- 8. I MODELLI SISTEMICI L’approccio sistemico è di tipo funzionale, esso infatti estende i fattori causali a tutta l’organizzazione e quindi alle dinamiche relazionali, gestionali, organizzative tipiche del sistema. Gli errori e gli incidenti in questa prospettiva non frutto di una sequenza collegata di mancanza di numerose difese, di salvaguardia, di barriere e controlli messi in opera per proteggere ed evitare eventi rischiosi conosciuti. E’ la soluzione che dà maggiori garanzie per attuare il miglioramento e l’apprendimento organizzativo. Nel 1990 James Reason propose un modello di analisi degli errori e degli incidenti proposto come il modello del formaggio svizzero (Swiss Cheese Model, pag.5) Ciò che rende il modello particolarmente utile nelle investigazioni è che obbliga alla ricerca delle condizioni latenti (latent conditions) all’interno della sequenza causale degli eventi. Sotto l’etichetta di condizioni latenti sono individuabili una serie di diversi tipi di prestazione umana (pag.6).
- 9. IL MODELLO SWISS CHEESE APPLICATO DA REASON (1990) Il presupposto di base in questo approccio, che si è sviluppato dopo i primi anni '70, risiede nella convinzione che gli incidenti e gli errori siano solo la punta dell'iceberg, che per un incidente che ha avuto luogo ce ne siano stati molti altri che non sono avvenuti solo perché l'operatore, un controllo, hanno impedito che accadesse, i cosiddetti “ near miss events ” Da questa visione sistemica, nasce l'idea che il verificarsi di un incidente o di un errorie sia frutto di una concatenazione d'eventi che hanno superato tutte le difese che erano state messe in atto. Reason ha chiarito in maniera più precisa il significato d'errore latente, attraverso il modello del formaggio svizzero
- 10. OLTRE LA LINEARITA’: LA RESILIENZA Il modello di Reason presenta però il limite di non considerare l’errore o l’incidente come non-lineare, cioè non dipende dall’azione negativa di un entità ben definita (il buco nel sistema nel modello del formaggio svizzero), ma dalla concomitanza ed interazione di fattori che non sono negativi di principio. Il sistema organizzativo è cioè per sua natura soggetto al cambiamento. La variabilità non deve pertanto essere vista come un fattore di disturbo di una situazione altrimenti stabile e sicura. I sistemi sono invece sempre in equilibro dinamico, cercano varietà perché solo con la varietà evolvono. Il sistema incontra spesso varietà, talvolta è positiva (informazione “buona” che fa avere successo al sistema), altre volte sarà negativa (l’errore ) e potrà essere tale da fare collassare il sistema o farlo cambiare (crescere attraverso le “lesson learned”). Un sistema organizzativo con elevate capacità adattive fa tesoro anche delle informazioni negative (gli errori) perché la varietà aumenta la capacità resiliente del sistema stesso. Questa capacità si vede negli operatori che notano e riportano i propri errori e le situazioni anomale e di non nasconderli sotto la cultura della colpa.
- 13. GEMS (Generic Error Modeling System) Procedure di routine Problema Analisi informazioni Funzionano? Situazione familiare? Cercare analogie (modelli mentali del problema) Diagnosi Formulazione di alternative Scelta azioni correttive Applicazione regole Problema risolto? Soluzione Sì No No Sì Skill based Rule based Knowledge based (Reason, 1990)
- 15. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Rasmussen, J., Svedung, I. (2000). Proactive Risk Management in a DynamicSociety. Swedish Rescue Services Agency. Reason, J. T. (1990). Human error. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. Resilience Engineering Network http://www.resilience-engineering.org/proceedings.htm Rasmussen, J., Brehmer B,ì., Leplat J., Distributed Decision Making, Wiley, Chichester 1991 Reason J,, L’errore umano, Il Mulino, Bologna 1994 Weick K.E., Senso e significato nell’organizzazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 1997 Grassani E., L’errore come causa di infortunio, Utet, Milano 2003 Catino M., Da Chernobyl a Linate, Incidenti tecnologici o errori organizzativi ?, Carrocci, Roma 2002
