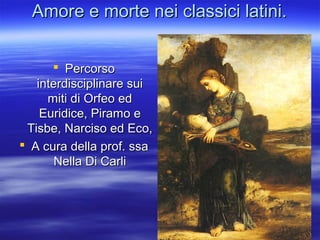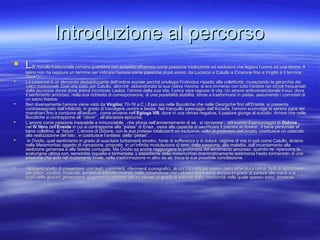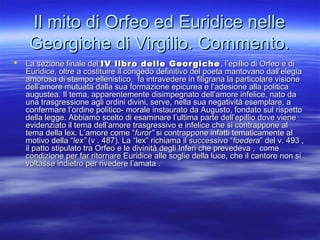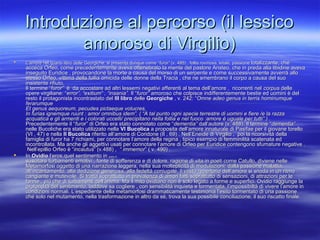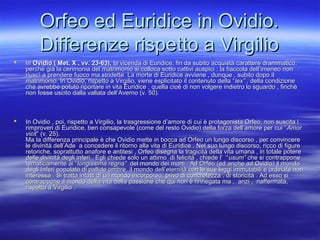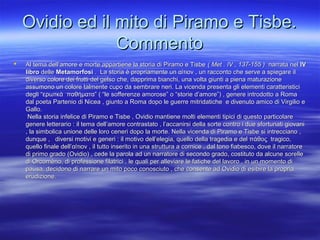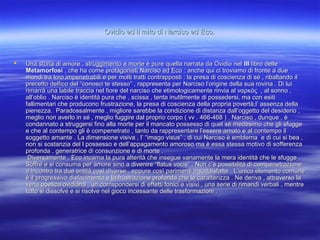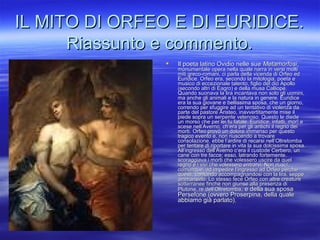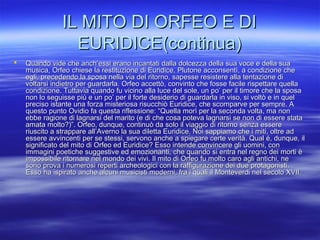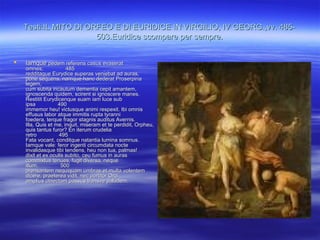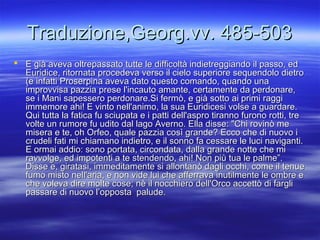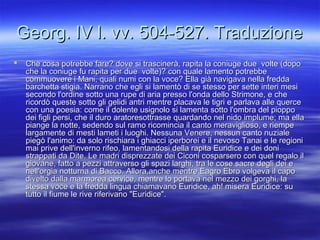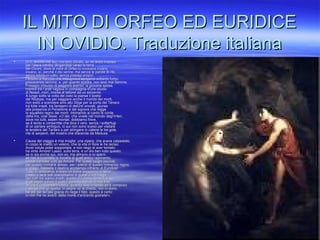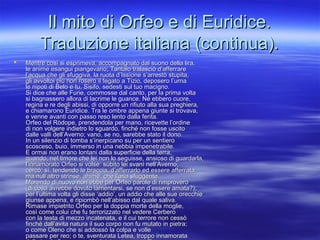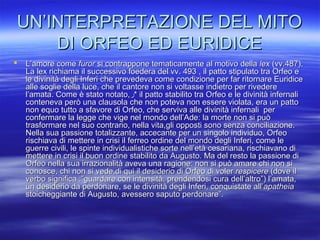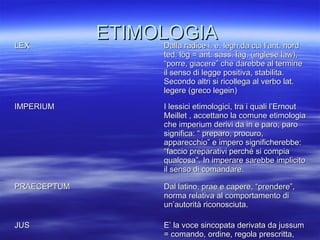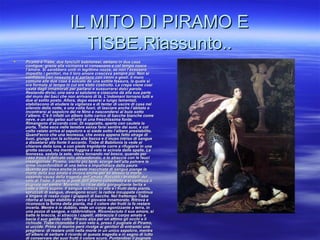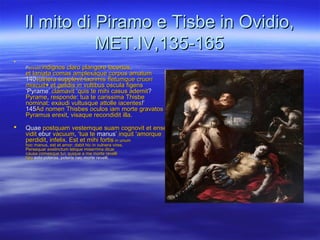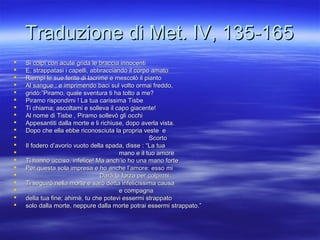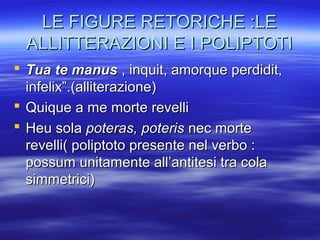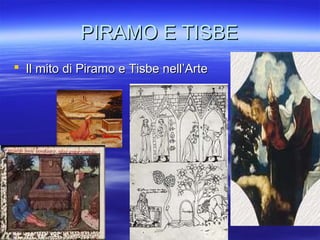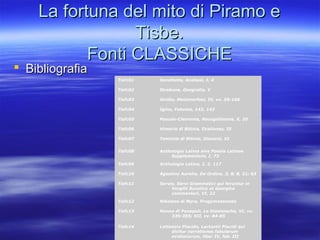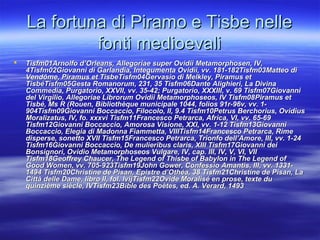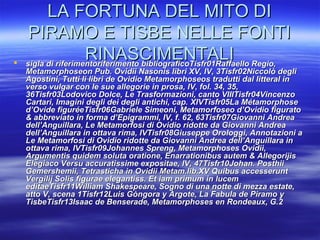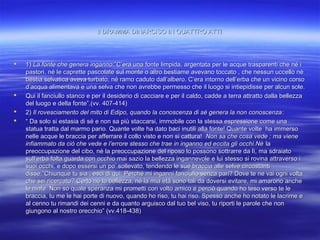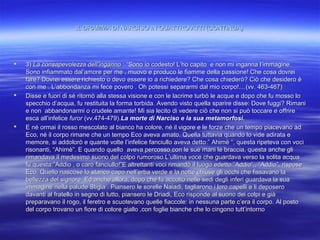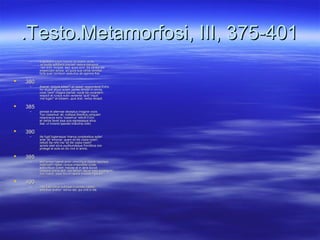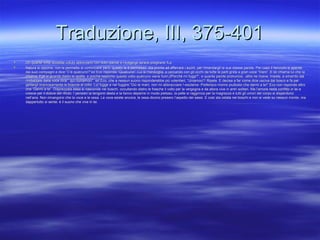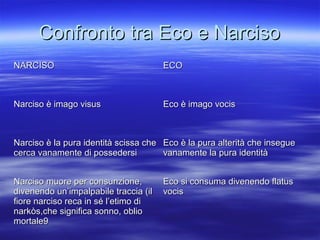Il documento esplora la rappresentazione dell'amore e della morte nella letteratura latina, evidenziando miti come Orfeo ed Euridice. Si discute la visione romana tradizionale dell'amore come passione destabilizzante e nelle opere di autori come Catullo, Virgilio e Ovidio, mostrando come queste relazioni si traducono in sofferenza e conflitto con le norme sociali. Inoltre, il testo sottolinea l'importanza dei classici latini come fonte di ispirazione per le generazioni future.