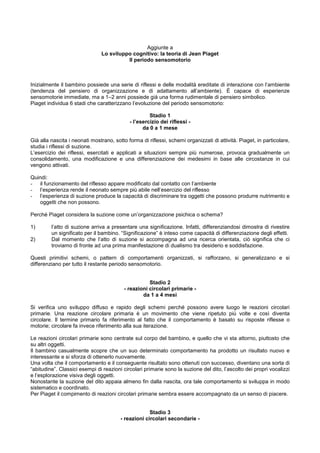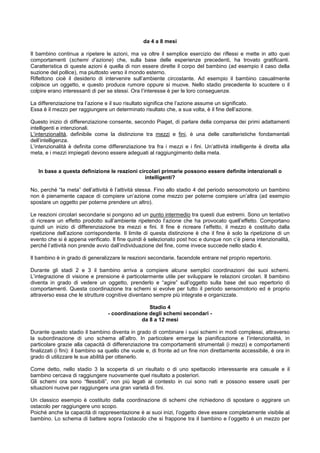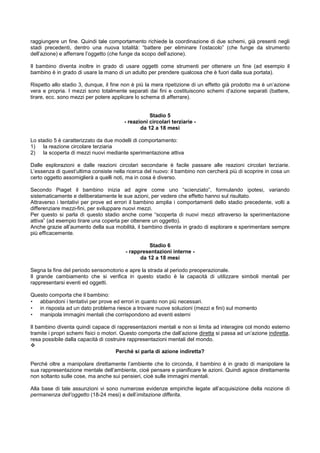Il documento analizza lo sviluppo cognitivo del bambino secondo la teoria di Jean Piaget, descrivendo i sei stadi del periodo sensomotorio, dal riconoscimento dei riflessi all'emergere della pianificazione e delle rappresentazioni interne. Ogni stadio mostra un progresso nell'intenzionalità e nella comprensione dei mezzi e dei fini, culminando nella capacità di utilizzare simboli mentali. Inoltre, viene discussa la preferenza innata dei neonati per i volti umani, evidenziando meccanismi specifici e generali nell'elaborazione visiva.