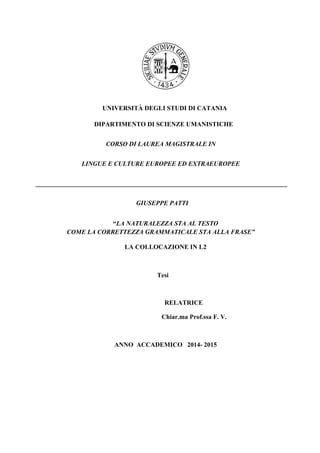
PATTI Giuseppe. Tesi: la collocazione in L2 .pdf
- 1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE ______________________________________________________________________________ GIUSEPPE PATTI “LA NATURALEZZA STA AL TESTO COME LA CORRETTEZZA GRAMMATICALE STA ALLA FRASE” LA COLLOCAZIONE IN L2 Tesi RELATRICE Chiar.ma Prof.ssa F. V. ANNO ACCADEMICO 2014- 2015
- 2. 1 Indice Abstract 4 Abstract 6 Resumen 8 Introduzione 10 Capitolo I 27 Quando i bambini fanno “boh!” L’apprendimento della L1 Capitolo II 60 … E quando i «grandi» fanno “boh!”? L’apprendimento della L2 Capitolo III 88 “Parole, parole, parole” Il lessico della L2: quantità e qualità.
- 3. 2 Capitolo IV 109 “These are words that go together well” La collocazione. Capitolo V 135 Quid prodest? A che serve conoscere le collocazioni? Capitolo VI 164 Modus operandi Come testare la competenza collocazionale Capitolo VII 197 “Adesso quello che voglio sono i Fatti… Servono solo i Fatti nella vita.” Risultati
- 4. 3 Capitolo VIII 231 Pars construens Come favorire nell’immediato lo sviluppo della competenza collocazionale Capitolo IX 246 “Con la cultura non si mangia” Ipotetiche iniziative editoriali finalizzate allo sviluppo della competenza collocazionale. Bibliografia 252 Webgrafia 272 Dediche e ringraziamenti 276
- 5. 4 Abstract Nello studio delle lingue straniere, specie nelle fasi iniziali, a chi non è mai capitato di porsi quesiti come “si può dire do a mistake in inglese?”, o “come si dice apparecchiare la tavola in tedesco?”, o ancora “è giusto dire feu jaune (semaforo giallo) in francese?”, “è possibile dire empezar con (iniziare con) in spagnolo?” ? Quante volte all’insegnante che ci aveva appena risposto si è chiesto disorientati “perché si dice make a mistake?”, “Perché si dice Tisch decken che letteralmente significa coprire la tavola?”, “Perché si dice feu orange (letteralmente semaforo arancione)? “Perché si dice empezar por?”? E quante volte quest’ultimo non ha potuto fare altro che replicare con un laconico e deludente “perché si dice così.”?
- 6. 5 Ciò che si cela dietro questo trito “perché si dice così” è la collocazione. La collocazione è la combinazione di due o più parole che tendono a presentarsi insieme nello stesso enunciato o tra enunciati prossimi. Tuttavia, ogni lingua ha per ogni parola un diverso repertorio di collocazioni. Queste differenze tra collocazioni rendono più complicato di quanto si pensi la padronanza di una lingua straniera. Anche se è vero che gli scambi comunicativi possono concludersi con successo nonostante l’uso di espressioni linguistiche inusuali per un madrelingua, la glottodidattica dovrebbe favorire lo sviluppo di una maggiore accuratezza linguistica nell’apprendente. Perché, come scriveva Sinclair in Corpus, Concordance, Collocation “la naturalezza sta al testo come la correttezza grammaticale sta alla frase”. Questa tesi si propone di descrivere in dettaglio il fenomeno linguistico della collocazione; avanzare delle proposte finalizzate all’introduzione del concetto di collocazione nell’insegnamento delle lingue straniere;
- 7. 6 ed, infine, testare la competenza collocazionale di studenti di lingua inglese dal differente grado di competenza linguistica. Abstract In the study of foreign languages, especially initially, who has never wondered “Can you say lui ha problemi finanziari (he has financial problems) in Italian?” Or, “How do you say blue jokes in Spanish?”, or “Is it correct to say le feu est jaune (the traffic light is yellow) in French?”, or “Is it possible to say Hausaufgaben tun (do the homework) in German?”? How many times, after being corrected by the teacher, have you asked, disoriented, “Why do you say lui ha problemi economici (economic problems)?”, “Why do you say bromas verdes (green jokes)?” “Why do you say le feu est orange (the traffic light is orange)?, “Why do you say Hausaufgaben machen ?”? Furthermore, how many times has the teacher had to reply with a brief and disappointing “It’s just like that”?
- 8. 7 What lies behind this hackneyed “It’s just like that” is collocation. Collocation constitutes a subset of formulaic sequences and can be described as a syntagmatic unit made up of frequently recurring words. Unfortunately, each word (node) in each language has a different set of collocates. Collocational differences between languages make it harder than commonly thought for learners to master a foreign language. Even if communicative exchanges can come to a successful end despite the use of linguistic expressions that do not sound natural to a native speaker, foreign language teaching should encourage the development of linguistic accuracy by the learner. Because, as Sinclair wrote in Corpus, Concordance, Collocation, “Naturalness is to text what grammatical correctness is to sentence”. This dissertation aims to describe in detail the linguistc phenomenon of collocation; to put forward some suggestions to introduce the concept
- 9. 8 of collocation in foreign language teaching; and, finally, to test some different proficiency level students on their collocational knowledge. Resumen En el estudio de las lenguas extranjeras, sobre todo en las fases iniciales, quién no se ha planteado nunca interrogantes como: “¿se puede decir do a mistake en inglés?”, o “¿cómo se dice CD vírgen en alemán?”, o aun “¿es correcto decir feu jaune (semáforo amarillo) en francés?”, “es posible decir iniziare per (empezar por) en italiano? ¿Cuántas veces, a causa de la desorientación provocada por la corrección del docente, se ha preguntado “¿por qué se dice make a mistake?”, “¿por qué no se puede traducir CD vírgen como jungfräuliche CD, sino solo como leere /unbespielte CD? “¿Por qué se dice feu orange (literalmente semáforo naranja)?” “Por qué se dice iniziare con?
- 10. 9 Y, ¿cuántas veces el docente no pudo más que contestar con un lacónico y decepcionante “porque se dice así”? Detrás de este trillado “porque se dice así” está la colocación. La colocación es la combinación compuesta por dos o más palabras que se distinguen por su alta frecuencia de uso. Y cada lengua tiene, para cada palabra, un diferente conjunto de colocaciones. Estas diferencias hacen más complicado de lo que se suele pensar el dominio de una lengua extranjera. Aunque es verdad que los intercambios comunicativos pueden concluirse con éxito a pesar del uso de expresiones lingüísticas inusuales por parte de un hablante nativo, la glotodidáctica debería favorecer en el estudiante el desarrollo de una mayor precisión lingüística. Porque, como escribía Sinclair en Corpus, Concordance, Collocation “la naturalidad es al texto, lo que la corrección gramatical es a la frase”. Esta tesis se propone describir en detalle el fenómeno lingüístico de la colocación; plantear propuestas para introducir el concepto de colocación en la enseñanza de las lenguas extranjeras; y, por último,
- 11. 10 averiguar la competencia colocacional en estudiantes de lengua inglesa pertenecientes a niveles diferentes. Introduzione “Michelle, ma belle, These are words that go together well, my Michelle. Michelle, ma belle, Sont des mots qui vont très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way I will say the only words I know that You'll understand.” The Beatles, Michelle. “… Il lettore capisce quello che sta succedendo solo se si dice siamo a un muro contro muro, il governo annuncia lagrime e sangue, la strada è tutta in salita, il Quirinale è pronto alla
- 12. 11 guerra, Craxi spara alzo zero, il tempo stringe, non va demonizzato, non c’è spazio per i mal di pancia, siamo con l’acqua alla gola, ovvero siamo nell’occhio del ciclone. E il politico non dice o afferma con energia, ma tuona. E le forze dell’ordine hanno agito con professionalità1 ” Umberto Eco, Numero zero. L’idea di realizzare questo lavoro deriva non solo dalla curiosità instillatami dalla professoressa Vigo nel corso di un ciclo di lezioni sulla lingua inglese durante il mio primo anno accademico, ma anche dalle mie esperienze di studente, traduttore amatoriale, tirocinante e di tutor. Stando a contatto con gli studenti del liceo scientifico-linguistico e con i miei colleghi iscritti al primo anno del corso di laurea triennale mi sono accorto che la fase di produzione presentava dei grossi ostacoli. Infatti, sebbene gli studenti e i colleghi conoscessero e riconoscessero i termini presenti nei testi, faticavano ad associare le parole per 1 Grassetto e sottolineato dello scrivente.
- 13. 12 produrre dei discorsi articolati e personali. Molto spesso le studentesse e gli studenti si rifugiavano in frasi scarne o estratte dal libro di testo2 , sacrificando il proprio pensiero. Oppure, quando erano determinati nell’esprimere la propria opinione, si limitavano a tradurre in inglese parola per parola delle espressioni tipicamente italiane3 (*do a picture, *strong rain, etc… ). A questo problema di fluenza e appropriatezza linguistica se ne accompagnava un altro, di natura psicologica, ben descritto da Morgan Lewis: “[…] students become frustrated when they are unable to talk or Gli studenti sviluppano un sentimento di frustrazione 2 Casi di cosiddetti ‘lexical teddy bears’. Termine coniato da Hasselgren Angela in Hassalgren Angela, 1994, “Lexical teddy bears and advanced learners: A study into the ways Norwegian students cope with English vocabulary”. International Journal of Applied Linguistics, 4(2), 237-258. 3 Come anche notato da Nadja Nesselhauf. Nadja Nesselhauf, 2003, “The Use of Collocations by Advanced Learners of English and Some Implications for Teaching”, Applied Linguistics 24 (2), 223-242. Traduzione dello scrivente.
- 14. 13 write about ideas which they can comfortably talk or talk about in their mother tongue.4 ” quando non sono in grado di parlare o scrivere di idee di cui riescono a scrivere o parlare facilmente nella propria lingua madre. La scarsa consapevolezza del fenomeno linguistico della collocation non l’ho riscontrata solo negli studenti e nei colleghi con cui ho avuto modo di collaborare, ma anche nella traduzione inglese del sito ufficiale di EXPO 2015. “[…] in homepage si legge il titolo «Albanese looks backstage at the communication campaign of Expo Milano 2015». Il riferimento è alla campagna di comunicazione di Expo, la cui voce sarà l’attore Antonio Albanese, ma nessuno conosce l’espressione <looks backstage>, 4 Morgan Lewis, “There is nothing as practical as a good theory” in Michael Lewis (ed.), 2000, Teaching Collocation: Further Developments in Lexical Approach, Thomson Heinle Language Teaching.
- 15. 14 semplicemente perché non esiste.5 ” Passando in rassegna i casi che avevo raccolto, mi accorsi che quegli enunciati soddisfacevano quasi tutte le proprietà che, secondo Laufer6 , sono indice della conoscenza di un termine (ricorrevano in una forma e una struttura morfologica corretta, rispettavano il pattern sintattico della frase, avevano un significato comprensibile), tranne una: le collocazioni privilegiate. Le collocazioni si riscontrano dappertutto in ogni lingua e sono fondamentali nella comunicazione. 5 Giacomo Valtolina, Quegli strafalcioni (in lingua straniera) sul sito di Expo, Corriere della Sera, domenica 1 febbraio 2015, p. 27. Consultabile anche alla pagina web: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_febbraio_01/sito-web-expo-strafalcioni-lingua- straniera-b1aeddd4-a9ee-11e4-a06a-ec27919eedf1.shtml Ultimo accesso: 18/06/2015. 6 Bettoni, Camilla, 2002, Imparare un’altra lingua. Lezioni di linguistica applicata, Roma – Bari, Editori Laterza.
- 16. 15 Tuttavia, poiché, in gran parte, differiscono da una lingua all’altra, esse costituiscono un ostacolo per chi studia un’altra lingua. Soprattutto ai livelli più avanzati, gli apprendenti di una lingua straniera vengono immediatamente riconosciuti come tali perché dimostrano incertezze nell’uso delle collocazioni. Mentre i parlanti di L1 memorizzano le collocazioni fin dall’infanzia e le usano intuitivamente in modo appropriato e non le percepiscono come nulla di particolare, per gli stranieri esse rappresentano delle espressioni “particolari” da imparare a memoria. Per esempio, un apprendente d’inglese dovrebbe essere reso consapevole del fatto che in questo idioma, per riferirsi all’azione di cattura di un’istantanea, si devono combinare al sostantivo <picture> i verbi <get>, <snap>, <take> (take a picture), che il sostantivo <rain> è solitamente preceduto dagli aggettivi <drenching>, <heavy>, <pouring>, <torrential>, etc…, che il verbo <look>, nell’accezione di <guardare>, è seguito da <at>, <toward> o <towards>. Chi ha a che fare con una lingua straniera dovrebbe essere reso consapevole. Dovrebbe. Ma spesso non lo è, perché, come hanno constatato anche Balboni e Bettoni, l’apprendimento del lessico è
- 17. 16 trascurato o affidato alla libera iniziativa degli studenti. “[…] i manuali sorvolano (troppo) su questa componente della competenza linguistica, affidandosi ad una miracolosa acquisizione spontanea del lessico incluso nei dialoghi, nelle letture, nei materiali autentici riprodotti.7 ” “Nelle tradizionali dicotomie forma vs contenuto e accuratezza vs fluenza, l’attenzione, l’attenzione è stata finora rivolta più all’evoluzione degli elementi formali della lingua, e molto meno all’evoluzione dell’abilità del comunicare, di come si diventi più fluenti nell’uso della L2. E tutto questo nonostante la ormai indiscussa convinzione che lo scopo primario dell’apprendimento linguistico (anche scolastico) sia oggi quello comunicativo pratico. Per quanto riguarda i livelli di analisi, è stato certamente privilegiato quello grammaticale. Oggi si tenta di rimediare, soprattutto con la 7 Balboni, Paolo Emilio, 2012, “Etica e glottotecnologie” in Caon Fabio & Graziano Serraggiotto (a cura di), 2012, Tecnologie e didattica delle lingue, Torino, Utet università, p. 41.
- 18. 17 fonologia e la pragmatica, ma rimane ancora trascurato il lessico.8 ” Da queste due citazioni risulta evidente come il lessico non goda di un’adeguata considerazione nei corsi d’inglese. Se al lessico non viene dedicato lo spazio che merita, al concetto di collocazione non viene riservato neanche questo spazio di nicchia. Infatti, la collocazione è un fenomeno linguistico su cui, solo a partire dai primi anni Ottanta, è cominciata a convergere l’attenzione dei linguisti9 . Di seguito vengono riportati dei dati illustrati da Celia Shalom, dell’Università di Liverpool, in un articolo apparso su Modern English Teacher e che danno un’idea di quanto sia limitata la consapevolezza di questo fondamentale fenomeno linguistico: 8 Camilla Bettoni, 2002, Imparare un’altra lingua. Lezioni di linguistica applicata, Roma – Bari, Editori Laterza, p.18. 9 Krishnamurthy Ramesh, John Sinclair, Robert Daley & Susan Jones (eds.), 2004, English Collocation Studies : the OSTI report: Research in Corpus and Discourse, London, Continuum.
- 19. 18 “[Some recent] research on collocational awareness found that half of a sample of English teachers in Switzerland talked about collocation to their students while only 8% taught it explicitly.10 ” Un recente studio riguardante la consapevolezza del concetto di collocation ha dimostrato che metà degli insegnanti d’inglese in Svizzera menziona il concetto di collocation e solo l’8% lo tratta in maniera esplicita. Questo lavoro può idealmente considerarsi in continuità con la mia precedente analisi dei neologismi che hanno fatto il loro ingresso nella lingua inglese lungo il corso del decennio 1997-2007. Tuttavia, in questo caso, la parola non rappresenta il centro unico dell’attenzione. Qui siamo in presenza di due fuochi. Di questi, uno è occupato dalla 10 Michael Lewis, “Materials and resources for teaching collocation” in Michael Lewis (ed.), 2000, Teaching Collocation: Further Developments in Lexical Approach, Thomson Heinle Language Teaching, p. 202-203. Traduzione dello scrivente.
- 20. 19 parola, o, ad essere più precisi, dalle sequenze di parole. Infatti, come possono confermare gli studi della linguistica dei corpora (corpus linguistics) rinvigoriti dai moderni e computerizzati corpora concodancer, le parole non ricorrono quasi mai da sole nei testi (siano essi scritti o orali), ma, piuttosto, in sequenze frequenti e prevedibili. L'altro fuoco del presente lavoro è occupato da un’indagine statistica sulla conoscenza delle 68 collocazioni inglesi più frequenti in studenti universitari divisi per anno accademico e distinti in tre livelli di competenza: B1+, B2 e C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. A margine e a conclusione di questa introduzione, mi preme chiarire perché abbia deciso di adoperare la lingua italiana per l’illustrazione di questo studio. Ho deciso di ricorrere alla “lingua del sì”, piuttosto che cimentarmi in un esercizio di scrittura in inglese perché, in primo luogo, il fenomeno della collocazione gode di poca attenzione nell’ambito degli studi linguistici e glottodidattici italiani. Le pubblicazioni, rispetto a quelle
- 21. 20 in inglese, sono poco numerose. In più, nelle sue rare apparizioni, alla collocazione sono dedicate solo poche righe. • Dizionario delle combinazioni lessicali di Francesco Urzì (Edizioni Convivium Lussemburgo, 2009); • MdD. Modi di dire. Lessico italiano delle collocazioni di Domenico Russo (ARACNE editrice S.r.l, 2010) • Dizionario delle collocazioni. Le combinazioni delle parole in italiano di Paola Tiberii (Zanichelli, 2012). In ritardo di quasi ventisette anni rispetto al primo dizionario inglese di collocazioni. Il Selected English Collocations, a cura di Christian Douglas Kozłowska e Halina Dzierżanowska, apparve per la prima volta nel 198211 . Verrebbe da chiedersi, inoltre, se sia da imputare alla mancanza di consapevolezza di questo fenomeno linguistico l’abuso in italiano del 11 Cowie, A.P., 1999, English Dictionary for Foreign Learners: A History, Oxford, OUP.
- 22. 21 verbo <fare>, o la fiducia cieca riposta in strumenti di traduzione automatica; comportamento, quest’ultimo, che danneggia i traduttori professionisti, gli esperti della lingua in cui il messaggio verrà tradotto e, molto spesso, il contenuto stesso del messaggio. Sebbene la collocazione possa essere sconosciuta agli utenti di questi software, il fenomeno non può che essere stato presente nei pensieri degli sviluppatori dei traduttori automatici di nuova generazione. Consideriamo il caso di Google Translate. A differenza di tutti gli altri progetti fallimentari di traduzione automatica che lo hanno preceduto, il traduttore elettronico sviluppato da Big G presenta una novità rivoluzionaria. Come spiega chiaramente David Bellos nel suo Is That a Fish in Your Ear?, le traduzioni prodotte da Google Translate sono il frutto di un processo di ricerca di corrispondenze tra espressioni equivalenti nei testi presenti sulla rete che si avvale, anche, delle conoscenze
- 23. 22 linguistico-traduttive degli internauti12 . Attraverso questo ingegnosissimo sistema che combina l’intelligenza del web e dell’uomo la traduzione viene resa più affidabile. Più affidabile, ma non perfetta ed applicabile a qualsiasi enunciato e a qualsiasi contesto. Insomma, nonostante gli sforzi encomiabili dei tecnici di Google, allo stato attuale delle cose, Google Translate produce ancora delle traduzioni imbarazzanti (a volte degne di essere paragonate alla memorabile supercazzola Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano) semplicemente perché ripropone la traduzione di quanto sia stato già tradotto. In secondo luogo, ho scelto di scrivere questo lavoro in lingua italiana 12 Bellos, David, 2011, Is That a Fish in Your Ear? The Amazing Adventure of Translation, London, Penguin.
- 24. 23 perché, come sostengono tanto Michael Lewis13 quanto Nadja Nesselhauf14 , un approccio che tenga in considerazione la L1 13 “The two traditional ideas which rather fell out of favour while the Communicative Approach began to dominate teacher training and classroom practice – translation and interference – turn out to be surprisingly fruitful when seen in the context of a lexical view of language.” Le due idee tradizionali che hanno piuttosto perso il favore di cui godevano quando l’approccio comunicativo ha iniziato a prevalere nella formazione degli studenti e nella pratica didattica- traduzione e interferenza – sono risultate sorprendentemente proficue, se viste nel contesto di una analisi lessicale del linguaggio. Lewis, Michael, 1997, Implementing the Lexical Approach. Putting the Theory into Practice, Heinle CENGAGE Learning, p. 60. Traduzione dello scrivente. 14 “Of the possible combinations, then, only the frequent and acceptable ones sas well as the non-congruent ones should be taught […] In those many cases where it is possible […] an L1-based approach to the teaching of collocations seems highly desirable” Delle possibili combinazioni, quindi, dovrebbero essere insegnate solo quelle frequenti e accettabili così come quelle non- equivalenti […] In quei molti casi in cui sia possibile […] sembra altamente desiderabile un approccio all’insegnamento delle collocazioni basato sulla L1.
- 25. 24 dell’apprendente costituisce un’opzione estremamente valida, sia dal punto di vista didattico che economico. Inoltre, le teorie e i dati presenti in questo lavoro potrebbero risultare utili in ulteriori lavori sul medesimo argomento, o sulla comparazione tra le collocazioni italiane e quelle straniere, o su delle tecniche mnemoniche innovative finalizzate all’acquisizione delle collocation15 , Nesselhauf, Nadia, 2003, “The Use of Collocations by Advanced Learners of English and Some Implications for Teaching”, Applied Linguistics, 24 (2), pp. 223-242, p. 239-240 . Traduzione dello scrivente. 15 Si potrebbe colmare così una delle lacune riscontrate da Frank Boers all’interno del Lexical Approach proposto da Michael Lewis: “In this approach, learners are systematically encouraged to notice recurring lexical chunks in the authentic L2 language they are exposed to. Lewis does not propose many mnemonic strategies to help learners to commit those chunks to memory, but seems to rely mostly on the power of awareness-raising to trigger acquisition through imitation of sequences In questo approccio, gli apprendenti sono sistematicamente incoraggiati a notare delle sequenze lessicali ricorrenti in materiale autentico della L2 a cui sono esposti. Lewis non propone molte strategie mnemoniche per aiutare gli apprendenti a vincolare queste sequenze alla memoria, ma sembra affidarsi soprattutto alla potenza dello sviluppo di una consapevolezza linguistica che, attraverso l’imitazione, attivi
- 26. 25 etc... Infine, l’ultima motivazione che mi ha spinto a scrivere in italiano è che, nella malaugurata ipotesi che il mio studio dovesse prestarsi a delle critiche che ne minassero il valore, si saranno, per lo meno, rese disponibili ad un/a qualsiasi lettore/trice italiano/a i contenuti e i risultati dell’attuale ricerca glottodidattica riconducibile al lexical approach. Indipendentemente dalle critiche che possa subire, sono fermamente convinto che questo giovane (anche se redivivo. L’indiscutibile padre encountered either inside or outside the classroom. To our knowledge, no ‘hard’ empirical evidence of the effectiveness of ‘chunk- noticing’ has been published yet […] and […] no supporting statistical evidence.” l’acquisizione di sequenze incontrate sia fuori che dentro la classe. Per quanto ne sappiamo, fino ad ora non è stata pubblicata nessuna vera prova empirica dell’efficacia di questa osservazione sistematica, […]e […] nessun dato statistico a sostegno del Lexical Approach. Boers, Frank et al., 2006, “Formulaic sequences and perceived oral proficiency: putting a Lexical Approach to the test”, Language Teaching Research, Vol. 10, No. 3, 245 - 261 doi:10.1191/1362168806lr195oa, p. 248.Traduzione dello scrivente.
- 27. 26 fondatore è Harold Edward Palmer16 ), settore della linguistica applicata meriti più attenzione. Infatti, secondo il mio modestissimo punto di vista, lo studio e l’introduzione della collocazione nell’insegnamento delle lingue straniere (e materne) potrebbero risultare estremamente preziosi sia per l’apprendimento che per la padronanza di qualsiasi idioma. Parafrasando Oscar Wilde; parlatene bene, parlatene male, ma purché se ne parli17 . 16 Palmer, Harold, Edward, 1933, Second Interim Report on English Collocations, A New Classification of English Tones, Tokyo, Kaitakusha. 17 “There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about” in Wilde, Oscar, 1890, The Picture of Dorian Grey. Capitolo 1.
- 28. 27 Capitolo I Quando i bambini fanno “boh!” L’apprendimento della L1 La psicolinguistica, disciplina che si occupa dell’acquisizione del linguaggio e dei meccanismi di codifica e decodifica, si trova concorde nell’affermare che esista una facoltà di linguaggio propria della nostra specie, che essa sia innata e, di conseguenza, trasmessa geneticamente. A sostegno di tale ipotesi ci si avvale di tre considerazioni: 1. Lo sviluppo del linguaggio dei bambini si svolge secondo percorsi simili a prescindere dal contesto socio-culturale in cui cresce: per ogni lingua, almeno per i primi 36 mesi, l’acquisizione linguistica segue tappe prevedibili. 2. La linguistica acquisizionale mostra l’esistenza di un «ordine naturale» applicabile non solo all’acquisizione della/e
- 29. 28 madrelingua/e ma anche all’acquisizione di altre lingue, indipendentemente dall’età. 3. L’analisi delle lingue esistenti al mondo sembra suggerire l’esistenza di una «grammatica universale», cioè di meccanismi che accomunano tutte le lingue. Tale fenomeno è spiegabile solo ricorrendo all’ipotesi di una facoltà di linguaggio innata18 . Insomma, nella costituzione degli esseri umani esiste qualcosa che permette loro di acquisire la prima e le seconde lingue. Chomsky19 parla, a questo proposito, di un meccanismo di acquisizione linguistica (Language Acquisition Device, LAD in sigla) e lo considera come un vero e proprio organo del linguaggio, innato e indistinto da tutte le altre facoltà mentali. Krashen propende, invece, per un altro termine: organizzatore. 18 Balboni, Paolo, Emilio, 2013, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse. Terza edizione, Torino, Utet università. 19 Balboni, Paolo, Emilio, 2013, Cit.
- 30. 29 Di sicuro, c’è che, di questo meccanismo, conosciamo poco, al momento. È una sorta di scatola near che sembra responsabile dell’elaborazione delle informazioni presenti nell’input per produrre un sistema linguistico. Che questo ‘organizzatore’ sia il cervello è ormai abbastanza ovvio20 . Considerata questa unità di fondo dell’acquisizione linguistica, è utile, concentrarsi sulle differenze eistenti tra l’apprendimento della L1 e quello della L2. Un’acuta e dettagliata descrizione di come si svolga l’apprendimento linguistico della L1 da parte dei bambini è stata condotta da Jean Aitchinson nei capitoli diciottesimo e diciannovesimo della quarta edizione di Words in the Mind: An introduction to the Mental Lexicon. 20 Pallotti, Gabriele, 2012, La seconda lingua, Bompiani.
- 31. 30 Secondo la professoressa emerita di Lingua e Comunicazione presso la prestigiosa università di Oxford, le menti gli esseri umani, nei primi anni di vita, inglobano parole con un’efficienza ed una facilità tali da essere paragonate a delle calamite. Le stime di Aitchinson21 , che si discostano lievemente da quelle di Chomsky (12)22 e Miller e Gildea (13)23 , dicono che un bambino acquisisce circa 10 vocaboli al giorno. In media, all’età di 2 anni, i bambini adoperano attivamente circa 500 parole; intorno ai 3 più di 1000 e, all’età di 5, fino a 3000. Dal computo sono esclusi i termini che fanno parte del lessico passivo. Quest’ultimo, 21 Aitchinson, Jean, 2012, Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon,Fourth Edition, Wiley-Blackwell. 22 Chomsky, Noam, 1998, Language and Problems of Knowledge: The Managua Lectures. Cambridge, MA, MIT Press. 23 Miller, G.A. & P.M. Gildea, 1987, “How children learn words”, Scientific American, 257, 86-91.
- 32. 31 secondo uno studio condotto da Carrey24 , arriverebbe a comprendere 14000 elementi nei soggetti aventi 6 anni. Tuttavia, considerare l’apprendimento della L1 come una semplice memorizzazione di parole sarebbe estremamente riduttivo. Lo sviluppo della L1 implica la comprensione dell’input (visivo e sonoro), la formulazione e la verifica di ipotesi sugli stimoli provenienti dall’esterno, la catalogazione, la contestualizzazione e i tentativi di riproduzione degli stessi. Prima di esprimersi con la consapevolezza tipica di un parlante adulto, un bambino deve adempiere a tre compiti di fondamentale importanza: 1/3 La nomenclatura degli enti, degli oggetti o dei concetti che circondano il bambino (labelling task, in termini Aitchinsoniani). 2/3 La catalogazione del repertorio lessicale raccolto (packaging task). 24 Carey Susan, 1978, “The child as a word learner”. In M. Halle, J. Bresnan, and G.A. Miller (eds.), Linguistic Theary and Psychological Reality, Cambridge, MA, MIT Press.
- 33. 32 3/3 La costruzione di una rete di associazioni (enciclopediche, grammaticali, semantiche e collocazionali25 ) per i termini presenti nel proprio lessicale mentale (network-building task).26 1/3 Il processo che conduce alla nomenclatura Per i bambini, il processo di attribuzione dei nomi agli oggetti, alle entità e ai concetti che costituiscono la realtà in cui è immerso è meno semplice e diretto di quanto si è soliti credere27 . È troppo semplicistico pensare che, per insegnare una parola ad un neonato, basti indicare un oggetto o una persona e pronunciarne il nome corrispondente scandendo le lettere che lo compongono. La capacità di simbolizzazione, ossia la consapevole associazione di una combinazione di suoni a un preciso significato, richiede tempo e, normalmente, non emerge fino al compimento del primo anno di età. 25 Personalissimo neologismo utilizzato per facilità d’esposizione e creato tramite calco dell’aggettivo inglese collocational (= relativo alle collocazioni). 26 Aitchinson, Jean, 2012, Cit. 27 Aitchinson, Jean, 2012, Cit.
- 34. 33 Quei <mamma> e <papà>, pronunciati prima del compimento dell’anno di età e che inorgogliscono i genitori, sono solo degli esercizi articolatori28 . Essendo suoni articolati con la parte anteriore della bocca (si noti che la /m/ e la /p/ sono entrambe delle consonanti bilabiali), queste sequenze foniche risultano facilmente riproducibili per un bambino. Figura 1 – Esercizi articolatori nei bambini29 28 Aitchinson, Jean, 2012, Cit. 29 Immagine adattata da un fotogramma del video "10 Minuti con..." Ca' Foscari: Video lezione di Didattica Lingue Moderne – BALBONI. Disponibile all’indirizzo:
- 35. 34 Prima che un bambino acquisisca la capacità di simbolizzazione, le sue espressioni vocali sono o dei semplici esercizi articolatori o una specie di rito che accompagna le azioni quotidiane. Per chiarezza d’esposizione, mi affiderò alla traduzione di un caso riportato da Aitchinson e che ha come protagonista un bambino di nome Adam. “Dut” (“duck”) shriecked this 12-month-old child excitedly each evening at bathtime as he knocked a yellow toy duck off the edge of the bathtub. Adam said “Dut” only when Adam himself knocked the duck off. And never said “Dut” when the duck was /dʌt/ (paperella, papeèlla nel probabile italiano incerto di un bimbo della stessa età) gridava entusiasta questo bambino di 12 mesi ogni sera durante il bagnetto quando buttava giù dal bordo della vasca un giocattolo https://www.youtube.com/watch?v=WP1hDnco-Qw Ultimo accesso: 24/06/2015
- 36. 35 swimming in the bath. So dut seems to be an unanalysed cry uttered as Adam swiped at the duck. It was a ritualized accompaniment to a whole scenario, and could perhaps be best translated as “Whoopee” or “Here goes.”30 giallo dalle sembianze di una papera. Ma non ha mai detto /dʌt/ “papeèlla”quando la papera galleggiava nella vasca. Quindi /dʌt/ “papeèlla” sembra essere uno strillo privo di significato che Adam pronunciava ogniqualvolta colpisse la paperella. Era una formula rituale che accompagnava l’intera situazione, traducibile come “Sìììì!” o “Evvai!” Come ulteriori prove di quanto sostenuto, Aitchinson descrive altre due situazioni che vedono coinvolto Adam. 30 Aitchinson, Jean, 2012, Cit., p. 212. Traduzione dello scrivente.
- 37. 36 “He said “Chuff-chuff” only when he, Adam, was pushing his toy train cross the floor. He did not say “Chuff-chuff” when the train was still. And he said “Dog” only when his father, and no one else, pointed to a picture of a dog on his bib he was wearing and said, “What’s that?”31 [Adam] diceva “ciuf-ciuf” solo quando lui stesso spingeva il trenino per il pavimento. Cosa che non faceva quando il trenino era fermo. E diceva “cane” solo quando suo padre, e nessun altro, indicando la figura di un cane sul suo bavaglino, gli chiedeva “Che cos’è?”. Insomma, in un primo momento, i bambini non sono consapevoli del fatto che le parole possano servire per indicare un singolo elemento all’interno della situazione che stanno sperimentando. Come abbiamo visto, Adam, solo al tocco della paperella o del trenino, diceva /dʌt/ (“dut” = papeèlla) o “ciuff-ciuff”; inoltre, solo nella 31 Aitchinson, Jean, 2012, Cit. p. 212. Traduzione dello scrivente.
- 38. 37 circostanza in cui fosse stato il padre a chiedergli cosa ci fosse sul suo bavaglino, rispondeva “dog”. Una volta raggiunta la consapevolezza di un legame tra un suono vocale e un singolo elemento di una situazione rituale, i bambini iniziano ad estendere l’insieme delle situazioni in cui adoperare tali sequenze vocali rituali. “For example, he began to use the word dog not only when his father pointed to the dog on his bib and said, “What’s that?” but also when his mother or he himself did so.”32 Per esempio, [Adam] iniziò a usare la parola cane non solo quando il padre, indicando il cane raffigurato sul suo bavaglino, diceva “che cos’è?”, ma anche quando lo faceva la madre o lui stesso. 32 Aitchinson, Jean, 2012, Cit. , p. 212. Traduzione dello scrivente.
- 39. 38 A questa fase ne segue un’altra in cui gli infanti riescono finalmente a spezzare il legame tra una parola e la situazione in cui è stata memorizzata. E incominciano a ricorrere ad una determinata parola per nominare gli oggetti. Col tempo, inoltre, le parole apprese attraverso le rappresentazioni verranno applicate anche agli oggetti o alle entità vere. In pratica, il piccolo Adam userà la parola “duck” (paperella) anche per indicare delle papere vere. Adam, così come tutti i bambini, nel periodo compreso tra gli uno e i due anni, entrano nella cosiddetta fase di nomenclatura (labelling stage, espressione ancora una volta tratta da Aitchinson); fase in cui apprendono i nomi delle cose e che si sovrappone con il processo di catalogazione delle parole.
- 40. 39 Figura 2 - Fase di nomenclatura33 2/3 Il processo di catalogazione Questo processo ha come scopo finale non solo la sistemazione delle varie parole in categorie (tanto un husky quanto un dalmata meritano di essere considerati cani), ma anche la ridefinizione dei significati di alcune parole precedentemente apprese (la parola freddo non denota 33 Immagine adattata da un fotogramma del video "10 Minuti con..." Ca' Foscari: Video lezione di Didattica Lingue Moderne – BALBONI. Disponibile all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=WP1hDnco-Qw Ultimo accesso: 24/06/2015
- 41. 40 esclusivamente lo stato fisico di un cibo, di una bevanda o di un oggetto, ma anche il temperamento di una persona). Figura 3 - Processo di catalogazione34 Nel corso di tale processo, il bambino può andare incontro a due errori opposti: la sottoestensione (underextension) e la sovraestensione (overextension). 34Immagine adattata da un fotogramma del video "10 Minuti con..." Ca' Foscari: Video lezione di Didattica Lingue Moderne – BALBONI. Disponibile all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=WP1hDnco-Qw Ultimo accesso: 24/06/2015
- 42. 41 Tra i due, il fenomeno di gran lunga più frequente è la sottoestensione. Questo errore consiste nella convinzione che un vocabolo si riferisca ad un numero più ristretto di concetti di quanto sia realmente. La letteratura psicologica è ricca di esempi chiarificatori. In uno studio pubblicato da Leopold nel 1947, si documenta il caso di Hildegard, una bimba di appena 20 mesi che si rifiutava di accettare di adoperare il termine bianco per indicare un foglio vuoto, semplicemente perché lei aveva associato questa parola sempre e solo alla neve35 . Un situazione simile è stata registrata da Asch e Nerlove. Nell’esperimento i bambini coinvolti dimostravano di sapere che il latte potesse essere definito freddo o che l’acqua potesse essere 35 Leopold W.F., 1947, Speech Development of a Bilingual Child, vol. 2: Sound-learning in the First Two Years, Evanston, IL, Northwestern University Press.
- 43. 42 descritta come profonda, ma ignoravano che questi aggettivi potessero essere applicati anche per la descrizione delle persone36 . La sottoestensione è un errore piuttosto normale e viene superato con la graduale ridefinizione dei significati delle parole apprese. L’altro ostacolo in cui possono imbattersi i piccoli apprendenti della L1 è la sovraestensione. Con sovraestensione (il fenomeno opposto della sottoestensione) si intende l’errore che induce il bambino a inserire in una categoria elementi che ne sono estranei. Esistono tre ipotesi sull’origine di questo tipo di errore: l’aggiramento di un ostacolo (gap-filling) (che sia la riproduzione di un fono ritenuto complicato o la scarsità di vocaboli nel lessico mentale per indicare cose, persone o situazioni sconosciute fino ad un certo momento); la confusione (mental fog) dovuta alla scarsa esperienza del bambino; e 36 Asch, S.E. & H. Nerlove, 1960, “The development of double-function terms in children: An exploratory investigation” in B. Kaplan & S. Wapner, 1967, Perspectives in Psycological Theory, New Your, International Universities Press.
- 44. 43 un errore di valutazione (wrong analysis) nella fase di catalogazione di alcune parole. Secondo lo psicologo russo Vygotsky, i responsabili di tali sviste sarebbero le associazioni a catena (chain-complex). I bambini, già perfettamente capaci di fare deduzioni, tenderebbero a focalizzare la propria attenzione su un singolo elemento alla volta per poi fare delle generalizzazioni troppo ampie. Vygotsky, all’interno di Thought and Language37 , documenta il caso di bambino che apparentemente inspiegabilmente diceva “quac” per riferirsi ad una papera in uno stagno, ad un bicchiere di latte, ad una moneta raffigurante un’aquila e agli occhi di un orsacchiotto. Per Vygotsky, la spiegazione è da trovare nella generalizzazione di proprietà condivise dalle situazioni e dagli oggetti percepite dai bambini: infatti, tanto lo stagno in cui nuotava la papera quanto il latte all’interno del bicchiere condividono lo stato liquido; sia la papera che 37 Vygotsky, L.S., 1962, Thought and Language, trans. E.Hanfmann & G: Vakar. Cambridge, MA, MIT Press.
- 45. 44 l’aquila raffigurata sulla moneta sono due uccelli; infine, tanto la moneta quanto gli occhi dell’orsacchiotto hanno una forma circolare. Figura 4 - Esempio di associazione a catena (chain-complex) Bowerman ritiene, invece, che questi sbagli siano dovuti all’adozione di prototipi inappropriati. Questi prototipi vengono utilizzati per condurre un’analisi contrastiva di quanto venga percepito. La differenza tra il punto di vista dei bambini e quello degli adulti ( e, conseguentemente, di prototipi) si ripercuote nelle scelte lessicali.
- 46. 45 In The structure and origin of semantic categories in the language learning child38 , la linguista statunitense riporta alcune considerazioni su una bambina rispondente al nome di Eva. Eva, nel periodo compreso tra i 16 mesi e i due ani di età, ricorreva al termine <luna> non solo per indicare il satellite che orbita intorno alla Terra, ma anche per riferirsi ad una fetta di limone, a una foglia verde luccicante, ad un foglio a forma di mezzaluna, alle corna delle mucche e ai legumi gialli e verdi con forma ricurva. Secondo Bowerman, Eva non faceva altro che assegnare la stessa etichetta a tutti gli oggetti che condividessero quella che, per lei, era la caratteristica essenziale della luna: la forma. 38 Bowerman, Melissa, 1980, “The structure and origin of semantica categories in the language learning child” in D. Foster e S.Brandes (eds.), 1980, Symbol as Sense: New Approches to the Analysis of Meaning, New York, Accademic Press.
- 47. 46 Figura 5 - Usi di <luna> secondo Eva39 Per mezzo della teoria dei prototipi, che permette di inglobare anche quella della catena di associazioni elaborata da Vygotsky, si possono spiegare sia la sovraestensione che i processi che guidano il modo di catalogare degli adulti. Infatti, per catalogare, tanto i bambini quanto gli adulti confrontano le caratteristiche rilevate nei propri prototipi mentali con quelle percepite nei nuovi stimoli. 39 Immagine adattata da Aitchinson, Jean, 2012, Cit. p. 216
- 48. 47 Tuttavia, come dimostrano gli studi di Landau40 , Baldwin41 e Merriman42 , durante l’infanzia, l’aspetto, e soprattutto la forma delle cose, ha un’influenza determinante. 40 Landau, B., L.B. Smith & S. Jones, 1988, The importance of shape in early lexical learning., Cognitive Development, 3, 299-321. Landau B., 1992, “Syntactic context and the sahpe biasin children’s and adults’ lexical learning”, Journal of Memory and Language, 31, 807-25. 41 Baldwin, D.A., 1992, Clarifying the role of the shape assumption, Journal of Experimental Child Psycology, 54, 392-416. 42 Merriman, W.F., P.D. Scott & J. Marazita, 1993, An appearance-function shift in children’s object naming. Journal of Child Language, 20 101-18.
- 49. 48 3/3 La creazione di una rete di associazioni Figura 6 – Associazioni mentali43 La creazione di reti di associazioni è un processo che si svolge lentamente. Solo col tempo, si giungerà all’instaurazione di quegli stessi legami tra parole esistenti nella mente di un adulto. 43 Immagine adattata da un fotogramma del video "10 Minuti con..." Ca' Foscari: Video lezione di Didattica Lingue Moderne – BALBONI. Disponibile all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=WP1hDnco-Qw Ultimo accesso: 24/06/2015
- 50. 49 Questa lentezza è facilmente spiegabile alla luce del suddetto fenomeno della sottoestensione e del fatto che i bambini imparano le parole in un determinato contesto per poi, solo gradualmente, applicarle ad altre situazioni. Durante questa fase associativa, il bambino stabilisce tra le parole connessioni di natura enciclopedica, grammaticale e collocazionale. Ci si concentri, innanzitutto, sulle connessioni di natura enciclopedica.
- 51. 50 Come emerge chiaramente da numerosi studi44 , compresi quelli di Piaget45 e di Macnamara46 , nelle fasi iniziali della crescita (intorno ai due anni), vige una tendenza molto comune a far corrispondere, ad un oggetto, uno ed un solo nome: un maialino è solo un maialino, e non, anche, un animale. Successivamente, attraverso l’apprendimento, intorno al prototipo di una certa idea si coaguleranno tutti gli altri concetti collegati. 44 La preferenza per l’uso di una sola parola è stato definito in vari modi “principio di contrasto” (principle of contrast) in Clark E.V., 1987, “The principle of contrast: A constraint on language acquisition”, in B. MacWhinne, 1987, Mechanisms of Language Acquisition Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. “Esclusività reciproca” (mutual exclusitiy) in Merriman W.E. & L.L. Bowman, 1989, “The Mutual Exclusivity Bias in Children’s Word Learning”, Monograpphs of the Society for Research in Child Development, 54. Tuttavia si dibatte ancora se questa preferenza per un’unica parola influisca a tutte le età. 45 Macnamara, J., 1982, Names for Things. Cambridge, MA, MIT Press. 46 Inhelder B., & J. Piaget, 1964, The Early Growth of Logic in the Child, London, Routledge and Kegan Paul.
- 52. 51 A tal proposito, è particolarmente significativo un esperimento condotto da White47 su bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni. I bambini si mostravano concordi nel inserire tanto i passeri quanto i pettirossi nella categoria composta dagli uccelli; tuttavia, si mostravano contrari nel fare la stessa cosa con galline e papere. Il motivo? Ai loro occhi, galline e papere non erano uccelli, ma semplicemente galline e papere e, come tali, indegne di essere considerate uccelli. Nei bambini, il processo di creazione di reti di associazioni investe anche la grammatica. Apparenti involuzioni nell’uso della lingua possono essere il sintomo di una possibile sistematizzazione dei concetti in fieri. 47 White, T.G., 1982, “Naming practices, tipicality, and underextension in child language”, Journal of Experimental Child Psychology, 33, 324-46.
- 53. 52 Questa sistemazione dei concetti attraverso errori è riscontrabile anche nell’interlingua48 tipica l’apprendimento della L2. Bowerman in Systematizing semantic knowledge: Changes over time in the child’s organization of meaning49 riporta il caso di Christie, una bambina anglofona di 2 anni. “Christie used the words put and give appropriately, as in “I put it somewhere,” “Gimme more gum.” Then, when she was 3, she started to use them interchangeably: “You put (“give”) me bread and butter,” “Whenever Eva Christie usava le parole mettere e dare appropriatamente, come in “lo metto da qualche parte”, “dammi un’altra chewing-gum”. Poi, all’età di 3 anni, ha iniziato a usarli in maniera intercambiabile: “Metti (dai) a me pane e burro”, “Ogni volta che Eva non ha bisogno del 48 “Chiaramente non più L1 e non ancora pienamente L2, l’interlingua è una lingua in continua evoluzione verso la L2 man mano che l’apprendimento avanza.” Bettoni, Camilla, 2002, Imparare un’altra lingua. Lezioni di linguistica applicata. Roma – Bari. Editori Laterza. 49 Bowerman, Melissa, 1978, Systematizing semantic knowledge: Changes over time in the child’s organization of meaning. Child Development, 49, 977-87.
- 54. 53 doesn’t need her towel, she gives (“puts”) it on my table”. Perhaps, suggested Chriestie’s mother, she had suddenly discovered that put and give had very similar meanings, but had not yet realized that one puts something on to a thing, but gives something to a person. Two more years elapsed before Christie used put and give correctly by adult standards50 ”. fazzoletto, lo dà (mette) sul mio tavolo”. Forse, suggeriva la madre di Christie, lei ha scoperto improvvisamente che dare e mettere hanno significati molto simili, ma non ha ancora compreso che si mette qualcosa su una cosa, ma si dà qualcosa a una persona. Sono trascorsi altri due anni prima che Christie usasse mettere e dare in maniera grammaticalmente corretta. Un altro tipo di legame lessicale che si forma durante l’infanzia è un legame cui gli esseri umani, inconsciamente, molto legati, soprattutto, 50 Aitchinson, Jean, 2012, Cit. p. 218 – 219. Taduzione dello scrivente.
- 55. 54 nel parlato51 : le collocazioni, ossia “la regolare cooccorrenza di due o più parole di solito una vicina all’altra in un enunciato o in enunciati prossima52 ”. Si pensi, per esempio, allo stile formulare di quelle opere letterarie e non che in origine erano destinate all’oralità come i poemi epici o i libri sacri (il pelide Achille, Achille piè veloce, la glaucopide Atena, Dio Onnipotente, i 99 epiteti per Allah contenuti nel Corano, etc…). Le collocazioni costituiscono una tale attrazione per la mente dei bambini che Gropen53 è riuscito a riscontrare delle collocazioni di origine visiva nella produzione linguistica di bambini non vedenti. Emblematico è il caso di Kelli, una bimba non vedente: “Kelli apparently started off by learning the names for various objects, like many sighted Kelli apparentemente aveva incominciato ad imparare i nomi dei vari oggetti, come molti 51 Shin, Dongkwang, 2007, The High Frequency Collocations of Spoken and Written English. English Teaching, Vol. 62, No. 1, Spring 2007. 52 Beccaria, Gian Luigi (ed.), 2008, “collocazione” in Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, Torino, Einaudi, p. 155. 53 Gropen, J., S. Pinker, W.E. Hollander, & R. Goldberg, 1991, “Affectedness and direct speech” Cognition, 41, 153-96.
- 56. 55 children. Then she noticed which words could co-occur, again like other children. She had heard people talk about blue cars, brown dogs and yellow flowers, so she knew that colors things could be […].”54 bambini normodotati. Quindi ha notato quali parole ricorrevano insieme, ancora una volta come altri bambini. Avendo sentito gli altri parlare di macchine blu, cani marroni e fiori gialli, sapeva di che colore fossero le cose. Tuttavia, come dimostrano gli studi di Entwisle55 , R. Brown e Berko56 , pare che esista una ma a differenza tra le collocazioni abituali dei bambini e quelle degli adulti. 54 Aitchinson, Jean, 2012, Cit., p. 217. Traduzione dello scrivente. 55 Entwisle, D.R., 1966, Word-associations of Young Children, Baltimore, MD, John Hopkins Press. 56 Brown, R., & J. Berko, 1960, “Word association and the acquisition of grammar”, Child Development, 31, 1-14.
- 57. 56 Sembra, infatti, che nella scelta delle collocazioni degli adulti pesi la consapevolezza dell’organizzazione del lessico in parti del discorso57 : la sintassi. La creazione di legami tra parole non può che trarre un ulteriore rafforzamento dal procedimento attraverso il quale i bambini apprendono a separare i singoli elementi presenti nella catena fonica. Per raggiungere tale scopo, i piccoli apprendenti, in una prima fase, memorizzano e ripetono per intero le stringhe sonore (chunks) che accompagnano dei gesti e/o delle situazioni rituali. 57 Brown, R., & J. Berko, 1960, Cit.
- 58. 57 Figura 758 Aitchinson, a tal proposito, illustra i casi di due bambini, di cui uno apprezzabile e comprensibile anche se in traduzione: “Fourteen-month-old Minh said Obedie apparently in imitation of adult “Open the door,” when he was pounding on a closed door and shouting Minh, un bimbo di appena 14 mesi, mentre stava battendo i pugni contro una porta chiusa e urlava a suo fratello che si trovava dall’altro lato, ha detto /ˈəʊbədi:/ (cioè apri la 58 Immagine adattata da Aitchinson, Jean, 2012, Cit. p.228.
- 59. 58 to his older brother on the other side. […] Both these utterances seem to be unanalyzed wholes, not yet divided into words.”59 porta; apipòdda, nel probabile italiano stentato di un bimbo) nell’intento di imitare la frase “Open the door” (apri la porta) pronunciata da un adulto,. […] Entrambi questi enunciati sembrano delle sequenze foniche non ancora suddivise in parole né, tantomeno, analizzate. A partire da questa collezione di pezzi non analizzati, gli infanti non solo rafforzano la rete di legami esistenti tra le parole, ma, inoltre, sono grado di: 1. Ricavare informazioni sull’accentazione delle parole 2. Trarre informazioni sul prosodia degli enunciati. 59 Aitchinson, Jean, 2012, Cit. p. 228. Traduzione dello scrivente.
- 60. 59 3. Porre i presupposti necessari per la produzione orale tramite l’associazione delle immagini sonore memorizzate con il movimento dei muscoli coinvolti nella fonazione. 4. Costruirsi un piccolo repertorio lessicale60 pronto per l’uso con l’indubbio vantaggio di ridurre i tempi di comprensione ed elaborazione dei messaggi. Conclusasi questa breve descrizione delle fasi iniziali di acquisizione della L1, si può rivolgere l’attenzione alle dinamiche con cui si è svolto e si svolge l’apprendimento della L2. 60 Aitchinson, Jean, 2012, Cit.
- 61. 60 Capitolo II … E quando i «grandi» fanno “boh!”? L’apprendimento della L261 Come scriveva il filosofo greco Aristotele (IV secolo a.C.) in la “Politica”, l’essere umano è un animale sociale; e, in quanto tale, tende ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società. Tuttavia, i rapporti tra gli esseri umani, nel corso dei millenni, non si sono limitati a quelli tra membri di piccole comunità isolate tra loro, ma hanno anche visto il coinvolgimento di membri di comunità più o meno vicine per scambi commerciali o guerre. Altre volte, invece, sono stati i processi migratori a mettere in contatto popolazioni molto diverse tra loro. In queste occasioni di contatto, la comunicazione ha, ovviamente, rappresentato un ostacolo considerevole. 61 In questo lavoro, L2 indica qualsiasi lingua un individuo impari dopo che si sia stabilizzata la sua prima lingua (L1). Pertanto, con L2 si intende anche una terza lingua, una quarta, ecc.…
- 62. 61 Tra le soluzioni adottate dagli esseri umani per venire a capo di questo problema non c’è stata solo la creazione di lingue ibride destinate all’espletamento di una determinata funzione (le lingue pidgin), ma anche l’apprendimento delle lingue straniere. Renzo Titone, nel suo Cinque millenni di insegnamento delle lingue62 , ci ricorda che le prime tavolette bilingui ittite-sumere risalgono al 2600 a.C.. Se l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue straniere costituiva una necessità più di 4000 anni fa, figuriamoci in un’epoca in cui i mezzi di trasporto e le telecomunicazioni hanno trasformato il mondo in un villaggio globale. La scienza che studia l’insegnamento delle lingue è la glottodidattica. Questa scienza, chiamata anche, a seconda dei vari universi epistemologici di riferimento, pedagogia delle lingue, linguistica 62 Titone, R., 1986, Cinque millenni di insegnamento delle lingue, Brescia, La Scuola.
- 63. 62 applicata, linguistica educativa, didattologia delle lingue –culture e didattica delle lingue moderne, ha registrato, nell’ un notevole sviluppo che ha condotto ad un susseguirsi di innovazioni teoriche e pratiche63 . Questo capitolo si propone di passarle in rassegna per capire in che modo si sia evoluto l’insegnamento della L2. Nel mondo romano, nel Medioevo e nel corso del Rinascimento, l’insegnamento delle lingue si svolgeva attraverso l’interazione con un parlante nativo (ad esempio, uno schiavo ellenico al servizio di una famiglia romana, o un intellettuale ospite presso una corte straniera). Poste queste condizioni, l’insegnamento non poteva che essere finalizzato alla comunicazione. L’attenzione all’uso prevaleva sulla forma ed, inoltre, i modelli da imitare e le regole da rispettare erano tratti dai testi classici. 63 Balboni, Paolo Emilio, 2012, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, Utet università.
- 64. 63 A partire dal Seicento fino quasi ai nostri giorni (in Italia è entrato in crisi negli anni Settanta-Ottanta), la didattica delle lingue assunse il cosiddetto approccio64 formalistico. Tale scelta fu dovuta alla pesantissima eredità lasciata dall’insegnamento del latino e alla compilazione dei primi dizionari e grammatiche da parte di quelle istituzioni nate per studiare e normare le varie lingue volgari (l’Accademia della Crusca in Italia, Port Royal in Francia, la Royal Society in Inghilterra). L’approccio formalistico si basava sulla convinzione che la lingua fosse un’entità priva di vita strettamente conforme alle regole fissate dalla grammatica. Le pratiche didattiche che discendevano da questo approccio si limitavano alla lettura e alla traduzione di testi (a volte privi di un fine concreto), rivolgevano la massima attenzione alla grammatica (concepita come unione di morfologia e sintassi) e richiedevano la 64 Come in Balboni (2012), Cit. anche qui il termine «approccio» si riferisce alla “filosofia di fondo” cui possono essere ricondotti i vari modelli d’insegnamento delle lingue straniere, mentre con «metodo» si intende “l’insieme degli strumenti di organizzazione dell’educazione linguistica”, non le tecniche di classe.
- 65. 64 memorizzazione di singoli vocaboli per mezzo di liste (i paradigmi dei verbi irregolari, la famiglia, i numeri ecc…). Dopo due secoli di dominio incontrastato, il primo attacco all’approccio formalistico venne sferrato dagli Stati Uniti. E non poteva essere altrimenti. Gli Stati Uniti d’America, a seguito dalle molteplici ondate migratorie, erano diventati una società multiculturale ed, inoltre, la conoscenza delle lingue non era considerata un semplice ornamento culturale, ma un sapere indispensabile negli scambi commerciali e nei rapporti internazionali. Fu in questo contesto che ebbe inizio la storia delle scuole Berlitz. La prima venne fondata nel 1872 in Rhode Island da Maximillian Berlitz, un emigrato tedesco. Sotto la gestione dell’omonimo nipote del fondatore, l’attività didattica di questa scuola, adottò un approccio naturale: un insegnante madrelingua, servendosi anche di materiali autentici, impartiva delle lezioni tematiche e interattive in lingua straniera. Fu così che l’attenzione alla grammatica passò in secondo
- 66. 65 piano rispetto allo sviluppo delle abilità comunicative e della capacità di comprendere un testo pur non conoscendo ogni parola. La rivoluzione operata da questo approccio è evidente: la lingua era ritenuta viva e al parlato veniva riconosciuta una sua importanza. Tuttavia, va ricordato che l’impatto di questo approccio rimase limitato alle scuole private a causa dei suoi costi elevati. La linguistica applicata subì una brusca involuzione nel secondo decennio del XX secolo. I conflitti europei, l’isolazionismo statunitense, i nazionalismi e la chiusura dei regimi dittatoriali dividono il mondo. Le libertà si riducono; tra queste, anche quella di movimento delle persone. Le lingue cessano di essere vive e si limitano a veicolare informazioni da testi scritti (opere scientifiche, letterarie, ecc.…). Per rispondere a questa esigenza nacque l’approccio della sola lettura o «Reading Method». La pratica didattica dell’approccio della sola lettura prevedeva la lettura, la comprensione e l’analisi di testi; in un primo momento, intuitivamente graduati e, successivamente, autentici.
- 67. 66 Tutto si svolgeva sotto la guida di un docente forniva agli alunni qualche schema grammaticale e li erudiva su come decifrare al meglio i materiali forniti. Nei casi in cui le parole costituivano un ostacolo alla comprensione si ricorreva a un dizionario bilingue. Agli inizi degli anni Quaranta del XX secolo, gli Stati Uniti d’America diedero un ulteriore contributo alla didattica delle lingue con lo sviluppo dell’approccio strutturalistico. Questa innovazione delle pratiche dell’insegnamento linguistico deve le sue origini più che alla maturazione di teorie glottodidattiche, alla necessità di formare, nel più breve tempo possibile, le truppe statunitensi (Army Specialised Training Program) a causa della tanto improvvisa quanto indesiderata partecipazione alla seconda guerra mondiale. L’approccio strutturalistico, la cui parabola si concluse alla fine degli anni Cinquanta, poggiava su due capisaldi teorici:
- 68. 67 1. L’ipotesi di matrice neocomportamentistica per cui l’apprendimento è il prodotto di una serie di stimoli e risposte seguite da conferme o correzioni; 2. La teoria bloomfieldiana secondo la quale la lingua possa essere ridotta in microstrutture. A livello pratico, l’interazione tra la psicologia neocomportamentistica e la linguistica tassonomica si tradusse nei cosiddetti pattern drills, o esercizi strutturali. Tali esercizi, supportati dall’impiego del registratore prima e dal laboratorio linguistico poi, avevano come obiettivo la memorizzazione robotica di campioni di lingua autentica (strutture, lessico, ecc.…) a partire dai quali, in via del tutto ipotetica, si sarebbe riusciti a generare lingua spontaneamente. Negli anni Sessanta l’approccio strutturalistico era in piena parabola discendente. A ciò avevano contribuito vari fattori: le obiezioni mosse da Chomsky al modello d’apprendimento skinneriano; l’idea di matrice sociolinguistica, secondo la quale le microstrutture linguistiche assumono un determinato significato solo all’interno di un preciso
- 69. 68 contesto sociale; e il nuovo ordine economico-politico mondiale che, rendendo nuovamente possibile la circolazione di merci e persone, aveva fatto riemergere la necessità di un insegnamento finalizzato alla comunicazione. Il modello glottodidattico elaborato negli anni Sessanta, che Balboni definisce approccio (proto)comunicativo65 e su cui si basano ancora molti corsi di lingua, non gettò il bambino con l’acqua sporca. Gli esercizi struttutali (pattern drills), tipici dell’approccio strutturalistico, non furono esclusi dalle pratiche didattiche, ma limitati alla fase di esercitazione. Le strutture e il lessico, da adesso, orientati al raggiungimento di uno scopo, vennero distribuiti tra le varie unità didattiche dei libri di testo e calati in situazioni verosimili. Queste situazioni, inoltre, venivano ricreate in classe con l’ausilio del registrazioni e delle illustrazioni (quest’ultimo elemento spiega la denominazione di «metodo situazionale»). 65 Balboni, Paolo Emilio, 2012, Cit.
- 70. 69 Altri approcci che vennero recuperati da questo modello d’insegnamento furono l’approccio della sola lettura attraverso l’introduzione di letture sulla civiltà e l’approccio formalistico grazie all’inserimento di sezioni dedicate alla spiegazione ed esercitazione grammaticale Le procedure operative per mezzo delle quali l’approccio (proto)comunicativo ha trovato attuazione prevedevano un percorso scandito dalla sequenza delle 3 P, ossia presentazione (presentation), pratica (practice) e produzione (production). Il docente, prima di affrontare l’unità didattica, esplorava il paratesto che la accompagnava al fine di attivare nella mente degli studenti le parole chiave utili alla comprensione del dialogo, successivamente riproduceva il dialogo registrato attraverso una strumentazione acustica ed, infine, richiedeva agli alunni di completare gli esercizi di comprensione, di drammatizzare o ripetere coralmente gli scambi di battute per familiarizzare con pronuncia e prosodia. Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta l’attenzione dei linguisti si sposta convintamente dagli elementi costitutivi della lingua alle
- 71. 70 funzioni svolte dalla lingua. Le due pubblicazioni più influenti di questo periodo sono How to Do Things with Words (1962) scritto da John L. Austin e Speech Acts (1969) di John Searle. Lo spunto fornito dalle riflessioni dei due filosofi anglosassoni indusse Trim, Willkins, Widdowsin, Munby, Van Ek e altri studiosi ad elaborare un elenco di funzioni comunicative (salutare, presentarsi ecc.…) e a fissare dei livelli di competenza comunicativa applicabili a tutte le lingue. Tali iniziative, sostenute dal Consiglio d’Europa con tanta convinzione da farne la base per la creazione il Quadro Comune Europeo di Riferimento, hanno dato ampia risonanza al cosiddetto approccio comunicativo. L’approccio comunicativo costituisce ancora oggi la tendenza dominante in glottodidattica e rappresenta una grande categoria che include molteplici punti di vista. Tuttavia, gli elementi comuni a tutti
- 72. 71 sono, oltre all’interesse per gli scopi comunicativi, il ruolo dei testi e l’attenzione rivolta all’apprendente66 . Mentre gli scopi comunicativi assicurano alle attività didattiche un senso pratico, i testi ricoprono il ruolo di oggetto di apprendimento. I testi (non più le frasi), tanto in fase ricettiva quanto in quella produttiva, hanno il compito di avviare quei processi che dovranno culminare nella comprensione e nella produzione all’interno delle situazioni comunicative in cui si troverà l’apprendente. Quest’ultimo, alla luce delle teorie sull’interlingua e sul suo sviluppo, assume una centralità mai avuta in qualsiasi altro approccio precedente: si punta all’individualizzazione dell’istruzione, si presta molto più interesse alle sue motivazioni, ai suoi bisogni linguistici e ai suoi stili cognitivi di apprendimento; infine, gli errori commessi vengono considerati solo degli stadi intermedi dell’interlingua destinati a 66 Treccani.it – Glottodidattica. A cura di Wanda d’Addio Colosimo: http://www.treccani.it/enciclopedia/glottodidattica_res-9353c566-87ea-11dc-8e9d- 0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/ Ultimo accesso: 18/06/2015.
- 73. 72 scomparire una volta colmato lo scarto tra la competenza già acquisita e quella da raggiungere (i+167 ). Obiettivo realizzabile, secondo alcuni (Krashen) per mezzo di una maggiore esposizione all’input, mentre, secondo altri, attraverso la tradizionale esplicitazione delle regole. Tra le varie realizzazioni dell’approccio comunicativo meritano una particolare attenzione: 1. Il metodo funzionale-nozionale 2. Il metodo naturale di Krashen 3. I cosiddetti metodi «clinici» a. Total Physical Response b. Community Language Learning c. Silent Way d. La suggestopedia 67 Formula inventata da Krashen per rappresentare la condizione necessaria affinché l’input venga acquisito dall’apprendente. Nella formula, la lettera «i» sta per intaken e indica la competenza comunicativa gà acquisita, mentre la combinazione composta dall’operatore matematico «+» e dal numero «1» designa l’area di sviluppo potenziale dell’interlingua.
- 74. 73 1. Il metodo funzionale-nozionale è, senza dubbio, il metodo più diffuso di realizzazione dell’approccio comunicativo, e, di conseguenza, quello cui si ispirano la maggior parte dei manuali odierni. Questo metodo si caratterizza per la fusione dei concetti di «nozione» (intesa come forma linguistica) e di «atto comunicativo» (vale a dire il fine pragmatico) e, per lo svolgimento del percorso didattico, si serve della struttura metodologica delle 3 P: presentazione, pratica, produzione. 2. Il metodo naturale di Krashen. Il metodo elaborato dal neurolinguista statunitense ipotizza l’esistenza di un unico percorso sia per l’apprendimento della L1 che per l’apprendimento della L2. Conseguentemente, affinché lo studente apprenda un nuovo idioma, è necessario esporlo ad un input accuratamente graduato sulla base dell’ordine naturale e del livello di acquisizione dell’apprendente. 3. I metodi «clinici». Si tratta di una serie di proposte provenienti dalla psicologia umanistica e risalenti agli anni Sessanta e Settanta.
- 75. 74 A classificarli sotto l’etichetta di metodi «clinici» fu Renzo Titone nel suo volume Glottodidattica, un profilo storico (1982). La motivazione risiede nelle analogie tra il rapporto insegnante- studente e quello psicologo-paziente tipico delle sedute psicoterapeutiche: il docente parla poco, lo incoraggia a prendere la parola, lo sostiene con la mimica faciale, lo corregge servendosi del linguaggio del corpo. a. Total Physical Response, metodo messo a punto dall’accademico statunitense James Asher negli anni Sessanta. Il docente impartisce agli apprendenti, nel corso del tempo, degli ordini sempre più complessi ed articolati (prendi la penna, prendi la penna rossa, prendi la penna rossa e scrivi, ecc.…) fino al momento in cui saranno gli studenti a doversi servire del mezzo linguistico per eseguire l’ordine. b. Community Language Learning, ideato dallo psicologo gesuita Curran sul finire degli anni Sessanta, prevede l’adozione dei modelli della seduta psicoterapeutica all’interno
- 76. 75 del contesto didattico. Ne consegue un ridimensionamento della figura del docente che non guida più il processo d’apprendimento, ma si limita a consigliare, supportare e venire incontro ai ritmi e agli stili d’apprendimento di ciascun discente. c. Silent Way, metodo inventato dal pedagogista svizzero Gattegno. Il docente fornisce un modello agli studenti a cui viene richiesto di riapplicarlo. L’insegnante rimane in silenzio, supervisiona il lavoro degli studenti alle prese con l’applicazione modello e, in caso di errori, interviene servendosi solo di gesti. d. Nata tra gli anni Sessanta e Settanta per merito del medico e psicoterapeuta bulgaro Georgi Lozarov, la suggestopedia, nelle sue sperimentazioni, ha dimostrato un’efficacia sorprendente: alla fine di corsi tenuti secondo il metodo suggestopedico, gli apprendenti erano in grado di imparare una lingua straniera molto più velocemente ed, inoltre, riuscivano
- 77. 76 a conseguire risultati più duraturi nel tempo e con minore fatica rispetto ai metodi tradizionali. Il metodo suggestopedico, servendosi di tecniche tipiche della psicologia clinica, mira a costruire, intorno all’apprendente, un clima rilassato e pieno di stimoli gradevoli. Le lezioni non solo cominciano e finiscono con momenti di training autogeno, ma sono anche accompagnate da brani di musica barocca che fungono da sottofondo musicale68 . Anche l’impegno e l’intraprendenza dell’allievo rivestono un ruolo importante in questo metodo; infatti, i testi analizzati in classe devono essere visionati nuovamente sia prima di andare a dormire che non appena svegli. Nonostante il suo enorme potenziale, questo metodo non è mai riuscito ad imporsi e diffondersi. Perché? Perché la suggestopedia, per la sua realizzazione, richiede aule progettate ad hoc, gruppi ridotti di studenti e insegnanti con una formazione specifica. 68 Vignozzi, Letizia, 2013, “Esperimenti suggestopedici”, Didattica & Classe Plurilingue, n. 7, settembre-dicembre 2003.
- 78. 77 Nel corso del tempo, i vari approcci che si sono succeduti si sono proposti di fornire allo studente tanto un bagaglio grammaticale quanto uno lessicale, ma non si sono potuti mai porre il problema di ricreare nella mente dell’apprendente il processo di creazione di una rete di collocazioni; come, invece avviene nelle prime fasi dell’apprendimento della L1 (capitolo 1). La causa di ciò è stato il fatto che la collocazione ha costituito per la linguistica e la glottodidattica quello che l’antimateria ha rappresentato e rappresenta ancora per la fisica: un fenomeno ipotizzabile, ma difficilmente dimostrabile. Si è dovuto attendere lo sviluppo delle tecnologie informatiche e la successiva creazione di enormi banche dati di testi per poter realizzare le condizioni necessarie per un’analisi di come il lessico si comporti nella produzione linguistica69 . 69 Porcelli, Gianfranco, 2004, Comunicare in una lingua straniera: il lessico Torino, UTET- Libreria.
- 79. 78 E quindi, avere la prova evidente dell’esistenza della collocazione in ogni forma di comunicazione verbale, anche se più o meno frequente a seconda del canale utilizzato70 . A differenza di quanto si è portati a pensare comunemente, le parole non si dispongono a caso (un appello si può lanciare, ma non tirare, sebbene queste due parole siano sinonimi; si può realizzare un forte guadagno, non un guadagno potente71 ), ma, invece, si combinano secondo delle regole dettate dalla propria collocazione. Ma, purtroppo, le parole di ogni lingua, per ragioni arbitrarie (Micheal Lewis) o no (Dilin Liu), hanno collocazioni differenti. Se lo studente è ignaro di questo fenomeno linguistico non potrà che utilizzare le collocazioni della propria lingua (transfer negativo) e, nel 70 Shin, Dongkwang, 2007, The High Frequency Collocations of Spoken and Written English, English Teaching, Vol. 62, No. 1, Spring 2007. 71 Paola, Tiberii, 2012, “Introduzione” in Paola, Tiberii, 2012, Dizionario delle collocazioni. Le combinazioni delle parole in italiano, Zanichelli.
- 80. 79 caso di non coincidenza tra le collocazioni dei due idiomi, commettere un errore. Questa è la ragione per cui uno studente italiano è tentato dal dire *strong rain, anzichè heavy rain (forte pioggia); uno studente tedesco ha più probabilità di incorrere in un errore come *make homework72 (Hausaufgaben machen, in tedesco, fare i compiti in italiano), o uno studente coreano è più portato a parlare di *thick tea73 , piuttosto che di strong tea (tè forte). Uno studente che non ha sviluppato alcuna sensibilità per il fenomeno della collocazione non penserà mai che, sebbene aim e goal siano due sinonimi, solo goal possa combinarsi con il verbo reach74 (reach a goal, achieve a goal, achieve an aim, *reach an aim). 72 Nesselhauf, Nadja, 2003, “The Use of Collocations by Advanced Learners of English and Some Implications for Teaching”, Applied Linguistics 24 (2), 223-242. 73 Shin, Dongkwang, 2006 A Collocation Inventory for Beginners, Victoria University of Wellington. 74 Nasselhauf, Nadia, 2003, Cit.
- 81. 80 Tali osservazioni sono confermate dalle conclusioni di una pubblicazione accademica a firma di Bahns ed Eldaw75 (2003). Secondo i due studiosi, infatti, le probabilità che uno studente scelga una collocazione errata sono due volte superiori rispetto a quelle di utilizzare una parola inappropriata. L’esclusione della collocazione dall’insegnamento delle lingue straniere è stata all’origine di quella condizione definita da Morgan Lewis come l’«intermediate plateau» (la palude76 del B1-B2). What can you really do for those ‘intermediate plateau’ students who need a breakthrough? […] The reason why so many students Cosa si può fare per quegli studenti rimasti impantanati nella palude del B1-B2 che hanno bisogno di trarsi fuori? […] 75 Bahns, J. & M. Eldaw, 1993, “Should we teach EFL students collocations?”, System, 21 (1), 101 – 114. 76 Sebbene plateau significhi altopiano, qui si è deciso di tradurre «intermediate plateau» con «la palude del B1-B2» per cercare di trasferire al/lla lettore/trice la frustrazione che ì accompagna questa situazione e la difficoltà con la quale si cerca di uscirne.
- 82. 81 are not making any percieved progress is simply because they have not been trained to notice which words go with which. They may know quite a lot of individual words which they struggle to use, along with their grammatical knowledge, but they lack the ability to use those words in a range of collocations which pack more meaning into what they say or write77 . La ragione per cui così tanti studenti non compiono progressi apprezzabili è semplicemente perché non sono stati allenati a notare quali parole vanno insieme. Possono conoscere un bel po’ di singole parole, insieme con una buona conoscenza grammaticale, ma mancano della capacità di usare quelle parole in una varietà di collocazioni che infondano più senso a ciò che dicono o scrivono. 77 Lewis, Morgan, 2000, “There is Nothing as Practical as a Good Theory” in Lewis, Michael, 2000, Teaching Collocation: Further Developments in Lexical Approach, CENGAGE Learning,.
- 83. 82 Per trasmettere agli studenti di L2 la consapevolezza che le parole si combinano in sequenze e, di conseguenza, per facilitare la produzione linguistica, Michael Lewis ha concepito il cosiddetto approccio lessicale (Lexical Approach). L’approccio lessicale, elaborato per la prima volta da Michael Lewis nel 1993 (anno di pubblicazione de The Lexical Approach. The State of ELT and a Way Forward) non si propone di rivoluzionare la glottodidattica, ma di completarla. Infatti, il Lexical Approach non disdegna né bandisce lo studio della grammatica, ma tenta solamente di prestare maggiore attenzione ad un aspetto completamente ignorato negli approcci precedenti: la ‘grammatica della parole’, ossia la maniera in cui le parole si associano tra di loro nella lingua straniera. Secondo Lewis “la lingua non è composta da una grammatica lessicalizzata, ma da una un lessico grammaticalizzato78 ”. 78 Lewis, Michael, 1993, The Lexical Approach. The State of ELT and a Way Forward, Heinle CENGAGE Learning, p. vi.
- 84. 83 Pertanto, la lingua non può essere analizzata e studiata solo attraverso le sole categorie della grammatica (strutture) e del lessico (parole). L’apprendimento delle lingue deve includere anche lo studio delle sequenze prefabbricate di lingua (chunks), perché queste se accuratamente combinate, producono testi scorrevoli e coerenti. All’interno del lessico oltre alle parole, Lewis individua tre tipi di sequenze prefabbricate: le collocazioni, le espressioni fisse e le espressioni semi-fisse. Dal punto di vista della struttura metodologica, l’approccio lessicale si distingue dagli approcci che lo hanno preceduto perché si propone di sostituire la sequenza Presenta-Pratica-Produci con la procedura Osserva-Ipotizza-Sperimenta. All’interno di questo paradigma metodologico (Osserva-Ipotizza Sperimenta) vale la pena soffermarsi soprattutto sulla prima e sull’ultima fase. Per il teorico del Lexical Approach, l’osservazione dei fenomeni linguistici presenti all’interno dei testi riveste una grandissima
- 85. 84 importanza perché “tutto ciò che produciamo linguisticamente proviene da ciò che sta fuori di noi79 ”. L’inevitabile conseguenza di tale osservazione è che, fin dalle prime fasi dell’insegnamento linguistico, bisogna tentare di indirizzare l’attenzione degli/lle apprendenti sui fenomeni linguistici e sulla grammatica (awareness raising) in modo da indurre i/le discenti a scoprire la grammatica (Ipotesi) e ad interiorizzarne le regole. Un’abilità che riveste un’enorme importanza all’interno dell’approccio lessicale e che i docenti di lingua straniera devono affrettarsi a trasmettere è il chunking, ossia il riconoscimento nei testi delle sequenze semi-fisse che compongono la lingua. L’acquisizione di tale abilità non deve passare solo attraverso un atteggiamento di awareness raising da parte dell’insegnante (per Lewis, l’esposizione agli input scandita dalla domanda “avete notato che…?” dovrebbe sostituire l’insegnamento esplicito della grammatica) e del materiale didattico, ma anche attraverso la 79 Lewis, Michael, 1993, The Lexical Approach. The State of ELT and a Way Forward, Heinle CENGAGE Learning, p. 194.
- 86. 85 sistematica registrazione e consultazione di appositi taccuini da parte degli/lle apprendenti. Attraverso lo sviluppo dell’abilità di chunking e una lunga esposizione a input autentici accuratamente selezionati dal docente, l’apprendente potrà crearsi un a vasta collezione di sequenze semi-fisse (chunks) da utilizzare quando (il più tardi possibile) gli sarà richiesta la produzione di testi lunghi e complessi. La sperimentazione, che rappresenta il terzo ed ultimo tassello della struttura metodologica proposta da Lewis nel Lexical Approach, deve essere incoraggiata durante la fase di produzione linguistica dell’apprendente. Affinché l’apprendente provi quante più soluzioni linguistiche possibili, l’errore deve cessare di essere considerato un fallimento e va scoraggiata qualsiasi strategia di aggiramento degli ostacoli linguistici. Sebbene l’approccio lessicale consideri l’errore come parte del processo di acquisizione linguistica, il docente che adotti tale approccio
- 87. 86 non può sottrarsi al dovere di reagire alle sviste linguistiche degli/lle allievi/e. Lewis invita i/le insegnanti a rispondere agli errori prodotti nell’espressione orale e in quella scritta in due maniere differenti. In caso di errore nella produzione linguistica orale, Lewis suggerisce all’insegnante di ricorrere alla strategia della riformulazione (reformulation), poiché, riformulando quanto espresso erroneamente dal discente, si può tentare di fornire l’input lessicale o grammaticale necessario per colmare le lacune linguistiche emerse. Siccome, secondo Lewis, gran parte di queste lacune linguistiche sono dovute a carenze lessicali e i docenti, nella riformulazione dei messaggi, devono prestare più attenzione al lessico che alla grammatica. Nel caso in cui l’apprendente commetta errori in un elaborato scritto, Lewis, invece, consiglia all’educatore/trice di coinvolgere il discente in un processo di co-revisione dell’elaborato (feedback).
- 88. 87 Ciò che accomuna queste due differenti maniere di rispondere all’errore è il tentativo di consapevolizzazione dell’apprendente (awareness raising). Infatti, tanto la riformulazione quanto il processo di co-revisione degli elaborati scritti cercano di sviluppare nel discente l’attitudine alla riflessione linguistica perché, secondo Lewis, “la prima responsabilità di ogni insegnante è lo sviluppo negli studenti di una capacità di reazione agli stimoli80 ” 80 “The teacher’s primary responsability is response-ability” Lewis, Michael, 1993, The Lexical Approach. The State of ELT and a Way Forward, Heinle CENGAGE Learning, p. 188.
- 89. 88 Capitolo III “Parole, parole, parole” Il lessico della L2: quantità e qualità. Nell’apprendimento delle lingue straniere, la creazione di un proprio lessico mentale è un processo di capitale importanza. Infatti, come notava acutamente il linguista inglese Wilikins, chi va all’estero si munisce di un vocabolario non di una grammatica, perché, senza grammatica si può comunicare molto poco, ma senza lessico non si può comunicare proprio nulla81 . • Dal punto di vista quantitativo, l’obiettivo più ambizioso che può porsi chi apprende una L2 è quello di memorizzare tutte le parole presenti in una lingua. 81 “Without grammar, very little can be conveyed; without vocabulary nothing can be conveyed” Wilkins David A., 1972, Linguistics in Language Teaching, Edward Arnold, p. 111.
- 90. 89 Ma quante sono le parole presenti in una lingua? Per dare risposta ad un tale quesito, la cosa più semplice da poter fare è controllare il numero di parole presenti su un dizionario. Ma già a intorno al termine stesso di <parola> incominciano a sorgere problemi di natura teorica. Il concetto di <parola> è tanto radicato nella coscienza di ciascun individuo da aver prodotto in tutte le lingue svariati espressioni e modi di dire, come ad esempio: <uomo di poche parole>; <fatti non parole>; <a buen entendedor, pocas palabras bastan> (dallo spagnolo all’italiano: a buon intenditore poche parole); <ein Mensch von wenigen Worten> (dal tedesco all’italiano: un uomo di poche parole); <a man of his word> (dall’inglese all’italiano: un uomo di parola), ecc… Tuttavia, dal punto di vista linguistico, le parole sono talmente difficili da descrivere da aver indotto gli studiosi e le studiose ad adottare più di una definizione, ma con risultati poco soddisfacenti. Ad aggravare la confusione hanno contribuito le diversità esistenti tra le lingue.
- 91. 90 Chi ha pensato di considerare parola quei grafemi isolati da due spazi bianchi ha finito per escludere da tale categoria i composti, le parole di quegli idiomi che non hanno un sistema di scrittura e quelle lingue le cui parole possono essere composte da due caratteri separati da uno spazio (come ad esempio il cinese in cui ma ma significa mamma). I linguisti che hanno adoperato come definizione operativa quella di “unità della lingua che può essere usata da sola per formare un enunciato82 ” non hanno tenuto conto delle parole grammaticali come e, ma, di, con. C’è chi considera <parole> quelle unità al cui interno non si possono inserire degli altri elementi linguistici (<amo Maria> sono due parole che possono essere ‘interrotte’: <amo follemente Maria>). Per convenzione nei dizionari, le parole vengono inserite sotto forma di lemmi, ossia le unità grafiche che rappresentano tutte le forme flesse che la parola può assumere. 82 Graffi, Giorgio & Sergio Scalise, 2012, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica Bologna, Il Mulino, p. 115.
- 92. 91 Il vocabolario Zingarelli 2015 contiene più di 144.000 lemmi83 , il Grande Dizionario di Italiano Garzanti 250.00084 , la 23a edizione di El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española 93.00085 , il Duden nella sua 26a edizione comprende 150.000 entrate86 , la seconda edizione dell’Oxford English Dictionary conta più di 83 http://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/lo-zingarelli-vocabolario-della-lingua-italiana- zingarelli-001 Ultimo accesso: 19/06/2015 84 http://www.garzantilinguistica.it/products-page/cdrom-4/grande-dizionario-di-italiano- licenza-online-per-2-anni/ Ultimo accesso: 19/06/2015 85 http://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola/presentacion Ultimo accesso: 19/06/2015 86 http://www.duden.de/shop/duden-die-deutsche-rechtschreibung- 138511?campaign=D1_Startseitenbuehne/Startseite/Bild/D1&utm_source=Startseite&utm_m edium=Bild&utm_content=D1&utm_campaign=D1_Startseitenbuehne&affiliate_id=422 Ultimo accesso: 19/06/2015
- 93. 92 171.000 voci87 , mentre la terza edizione del Webster's International Dictionary ne ha al suo interno 470.00088 Nation, nonostante ritenga che la definizione di lemma sia sufficientemente comprensiva, preferisce adottare quella di famiglia lessicale89 . La famiglia lessicale costituisce l’insieme di quelle parole che hanno la stessa base o radice. Il concetto di famiglia lessicale si differenzia da quello di lemma perché include anche i vocaboli derivanti dall’aggiunta di morfemi lessicali; e non solo di morfemi grammaticali. Nation e Warring90 , in virtù del criterio di famiglia lessicale, hanno passato al setaccio i lemmi contenuti nella terza edizione del succitato 87 http://www.oxforddictionaries.com/words/how-many-words-are-there-in-the-english- language Ultimo accesso: 19/06/2015 88 http://www.merriam-webster.com/help/faq/total_words.htm Ultimo accesso: 19/06/2015. 89 Nation, I.S.P., 2013, Learning Vocabulary in Another Language. Second Edition, Cambridge University Press. 90 Nation, P. & R. Waring, R., 1997, “Vocabulary Size, text coverage and word list” in Schmitt N. & M. McCarthy (eds.), 1997, Vocabulary: description, acquisition and pedagogy, Cambridge, Cambridge University Press.
- 94. 93 Webster's International Dictionary e hanno trovato 54.000 famiglie lessicali. Le parole presenti sui dizionari costituiscono un quantità incomparabilmente più vasta rispetto a quella conosciuta, in media da un parlante nativo. Sfortunatamente, le ricerche sull’ampiezza media del lessico mentale (ossia, “la conoscenza delle parole prese ad una ad una, ma anche le conoscenze relative al funzionamento delle parole e dei complessi rapporti tra le varie parole, tra le varie classi di parole, ecc.91 ”) sono state poche e alcune di queste risultano viziate da errori di metodo che ne hanno invalidato l’affidabilità. Tuttavia, esistono due studi molto autorevoli a firma di Goulden92 e Zechmeister93 che convergono nell’affermare che il lessico mentale di 91 Graffi, Giorgio & Sergio Scalise, 2003, Cit. p. 148. 92 Goulden, R., I.S.P., Nation & J., Read, 1990, “How large can a receptive vocabulary be?”, Applied Linguistics, 11, 4, 341-63. 93 Zechmesiter, E.B., A.M. Chronis, W.L Cull., C.A. D’Anna,. & N.A. Healy, 1995, “Growth of a functionally important lexicon”, Journal of Reading Behaviour, 27, 2, 201-12.
- 95. 94 un adulto istruito si aggiri, in media, intorno alle 20.000 famiglie lessicali. Inoltre, secondo una stima fornita da Biemiller e Slonim, una persona, nell’età compresa tra i 3 ed i 25 anni, sarebbe in grado di memorizzare circa 1.000 famiglie lessicali l’anno94 . Un traguardo simile è chiaramente troppo pretenzioso per un apprendente di L2. Infatti, come ci ricorda Bettoni nel suo Imparare un’altra lingua. Lezioni di linguistica applicata95 , la L2 si differenzia dalla L1 anche perché, mentre per l’apprendimento completo della L1 raggiunto verso i cinque-sei anni, i bambini impiegano tra le 12.000 e le 14.000 ore, un intero corso scolastico di L2 (dalle elementari alle superiori) può contare solo su 1.000-1.200 ore spalmate su undici anni. E spesso queste lezioni sono condotte in L1. 94 Biemiller, L. and N. Slonim, 2001,” Estimating root vocabulary growth in normative and advantaged populations: Evidence for a common sequence of vocabulary acquisition”, Journal of Eucational Psychology, 93, 3, 489 – 520. 95 Bettoni, Camilla, 2002, Imparare un’altra lingua. Lezioni di linguistica applicata, Roma- Bari, Editori Laterza.
- 96. 95 Considerati questi limiti temporali, per ridurre il peso dell’apprendimento (learning burden96 ), ciò che si può fare è concentrare l’attenzione degli apprendenti sulle parole più usate, e quindi più necessarie, nella L2. Questa osservazione non è solo il prodotto di un ragionamento logico, ma è anche sostenuta dai dati forniti dalla linguistica dei corpora. Nation97 , dopo aver condotto uno studio sulle famiglie lessicali più frequenti all’interno del British National Corpus98 e averle raggruppate 96 Il learning burden (tradotto dallo scrivente come ‘peso dell’apprendimento’) è un concetto elaborato da Swenson & West (1934) ed indica la mole di sforzi necessaria per l’apprendimento. Swenson, E. & M.P. West, 1934, “On the counting of new words in textbooks for teaching foreign languages”, Bullettin of the Department of Educational Research, University of Toronto, 1. 97 Nation, I.S.P., 2006, “How Large a Vocabulary Is Needed For Reading and Listening?”, The Canadian Modern Language Review/La Revue canadienne des langues vivantes, 63, (September/septembre) 98 Il British National Corpus è una raccolta digitale di 100.000.000 parole databili a partire dal XX secolo e provenienti da campioni autentici di lingua parlata o scritta. What is BNC? http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml
- 97. 96 in gruppi di mille, ha analizzato vari tipi di testi ed è giunto a delle conclusioni particolarmente significative per la glottodidattica: affinché si possa comprendere il 98% delle parole in un qualsiasi tipo di testo è necessario conoscere le 9.000 famiglie lessicali più frequenti. Nation fissa questa percentuale come obiettivo di un apprendente di L2 perché, secondo più studi (Hu e Nation99 ; Schmitt100 ; Nation; van Zeeland e Schmitt101 ), la comprensione del 98% dei vocaboli presenti in un testo può consentire la deduzione del significato del rimanente 2%. Famiglie lessicali Ultimo accesso: 19/06/2015. 99 Hu M. & I.S.P., Nation, 2000, “Unknown vocabulary density and reading comprehension”. Reading in a Foreign Language 13, 1: 403-430. 100 Schmitt N., X., Jiang & W., Grabe, 2011, The percentage of words known in a text and reading comprehension. Modern Language Journal 95, 1: 26-43. 101 Van Zeeland, H., & N., Schmitt, 2012, “Lexical coverage in L1 and L2 listening comprehension: The same or different from reading comprehension”, Applied Linguistics, 34(4), 457-479.
- 98. 97 in ordine decrescente di frequenza102 % copertura testo 1° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 2° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 3° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 4° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 5° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 6° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 7° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 8° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 9° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 10° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 11° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 12° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 13° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 14° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 81,14 89,24 93,60 95,37 96,41 97,08 97,53 97,86 98,08 98,23 98,38 98,49 98,58 98,65 102 Tabella tratta da Nation I.S.P., 2013, Cit., p. 21.
- 99. 98 15° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 16° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 17° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 18° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 19° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 20° gruppo di 1.000 famiglie lessicali 98,71 98,75 98,79 98,83 98,58 98,86 Ovviamente, il numero di famiglie lessicali necessario per raggiungere l’obiettivo del 98% di copertura di un testo cambia a seconda del tipo di testo in questione. Ad esempio, la visione di un film per bambini richiede la conoscenza di un minor numero di vocaboli rispetto alla lettura di un romanzo o di un articolo di giornale. Tipi di testo103 95% di copertura testo conseguibile con 98% di copertura testo conseguibile con % Nomi propri 103 Tabella tratta da Nation, I.S.P., 2013, Cit., p 16.
- 100. 99 Romanzi le prime 4.000 famiglie lessicali le prime 9.000 famiglie lessicali 1-2% Articoli di giornale le prime 4.000 famiglie lessicali le prime 8.000 famiglie lessicali 5-6% Film per bambini le prime 4.000 famiglie lessicali le prime 6.000 famiglie lessicali 1.5% Inglese conversazionale le prime 3.000 famiglie lessicali le prime 7.000 famiglie lessicali 1.3%
- 101. 100 Se ogni tipo di testo richiede un lessico mentale più o meno ampio, è inevitabile che anche la crescita linguistica e le attività glottodidattiche ad essa connesse esigano un determinato inventario lessicale. Ancora una volta, Nation in Learning Vocabulary in Another Language, traccia un percorso ideale di espansione del vocabolario che condurrebbe l’apprendente a guadagnare gradualmente una maggiore autonomia. Finalità linguistica104 Ampiezza vocabolario Vocabolario di sopravvivenza per un viaggio all’estero 120 parole ed espressioni Letture elementari le prime 100-400 famiglie lessicali 104 Tabella tratta da Nation, I.S.P., Cit., p. 39.
- 102. 101 Letture graduate per il livello intermedio le prime 1.000 famiglie lessicali Abilità orali di base le prime 1.200 famiglie lessicali Abilità uditive di base le prime 3.000 famiglie lessicali Letture graduate e uso del dizionario monolingua le prime 3.000 famiglie lessicali Lettura di testi contenenti parole con frequenza media (6°-8° gruppo di 1.000 famiglie lessicali) le prime 4.000-6.000-8.000 famiglie lessicali Lettura di testi non semplificati e visione di programmi televisivi le prime 3.000 parole
- 103. 102 Lettura di testi non semplificati senza l’ausilio del dizionario le prime 6.000-9.000 parole Osservando i dati forniti da Nation, non si può non compararli con quelli elaborati da Tullio De Mauro nel 1980105 . Infatti, anche secondo il linguista napoletano, nella lingua italiana è individuabile un vocabolario di base. Questo vocabolario di base, composto da circa 7.000 parole, è conosciuto da chiunque abbia completato la scuola media inferiore. De Mauro lo suddivide in tre categorie: fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità. Tutte e tre le categorie, proprio come in Nation, si basano su un criterio di frequenza decrescente; tuttavia, nella suddivisione di De Mauro, la categoria dei vocaboli “di alta disponibilità” si distingue dalle altre anche perché contiene “parole che diciamo e scriviamo raramente, ma che pensiamo con grande frequenza106 ”. 105 De Mauro, Tullio, 1980, Guida all’uso delle parole. Parlare e scrivere semplice e preciso per capire e farsi capire, Roma, Editori Riuniti. 106 De Mauro, Tullio, Cit., p. 150.
- 104. 103 Vocabolario di base107 Ampiezza esempi Fondamentale 2,000 parole frutta, movimento, ricco Di alto uso 2,750 parole circa barzelletta, concepire Di alta disponibilità 2,300 parole circa lontananza, padroneggiare Avendo chiarito il quesito relativo alla quantità di vocaboli necessario ad un apprendente di L2, adesso possiamo concentrarci su un nuovo interrogativo: che cosa significa davvero conoscere una parola? A differenza di quanto si crede comunemente, la conoscenza delle parole della L2 non si esaurisce al riconoscimento della forma fonica e ortografica e alla memorizzazione del significato in L1, ma include 107 Tabella tratta da Bettoni, Camilla, 2002, Cit., p. 65.
- 105. 104 anche la cognizione di altre proprietà. Proprietà illustrate chiaramente da Laufer in Vocabulary Description, Acquisition and Pedagogy 108 : 1. forma 2. struttura morfologica 3. pattern sintattico 4. significato 5. relazioni lessicali 6. collocazioni. • Alla luce di tale osservazione, accanto ad una conoscenza delle parole di tipo quantitativo, non si può che parlare anche di una conoscenza delle parole di tipo qualitativo. 108 Laufer, Batia, 1997, “What's in a word that makes it hard or easy? Intralexical factors affecting the difficulty of vocabulary acquisition” in Schmitt, N., & M. McCarthy (eds.), 1997, Vocabulary Description, Acquisition and Pedagogy, Cambridge, Cambridge University Press.
- 106. 105 È evidente che il peso dell’apprendimento (learning burden) di ciascuna di queste proprietà varia a seconda della distanza tipologica e lessicale presente tra e due lingue109 . Lo sforzo sarà maggiore nel caso in cui la L2 possegga un sistema di scrittura differente, abbia dei fonemi difficilmente riproducibili dall’apprendente, non mostri una stabile corrispondenza tra grafemi e fonemi, presenti delle collocazioni diverse dalle L1, ecc…. Lo sforzo sarà minore per quegli apprendenti la cui L1 abbia delle affinità con L2: stesso sistema alfabetico, simile grammatica fonologica e grafemica, parole dallo stesso significato metaforico, ecc… Tra le proprietà elencate da Laufer la prima non poteva che essere la forma. Con essa si intendono sia la pronuncia che l’ortografia di una parola, insomma entrambe le forme (orale o scritta) che possono essere assunte dal significante nella comunicazione verbale. 109 Nation, I.S.P., 2013, Cit.