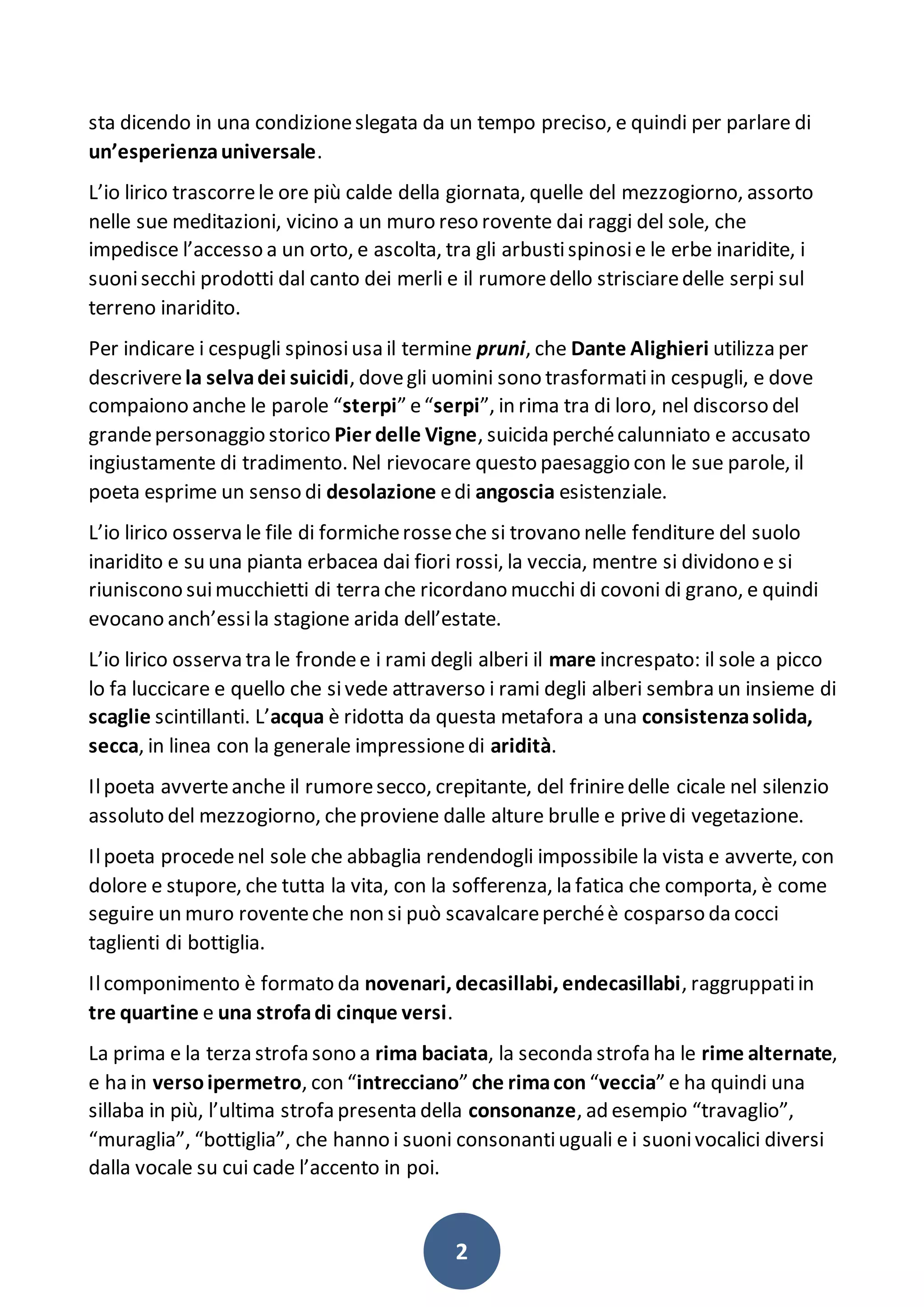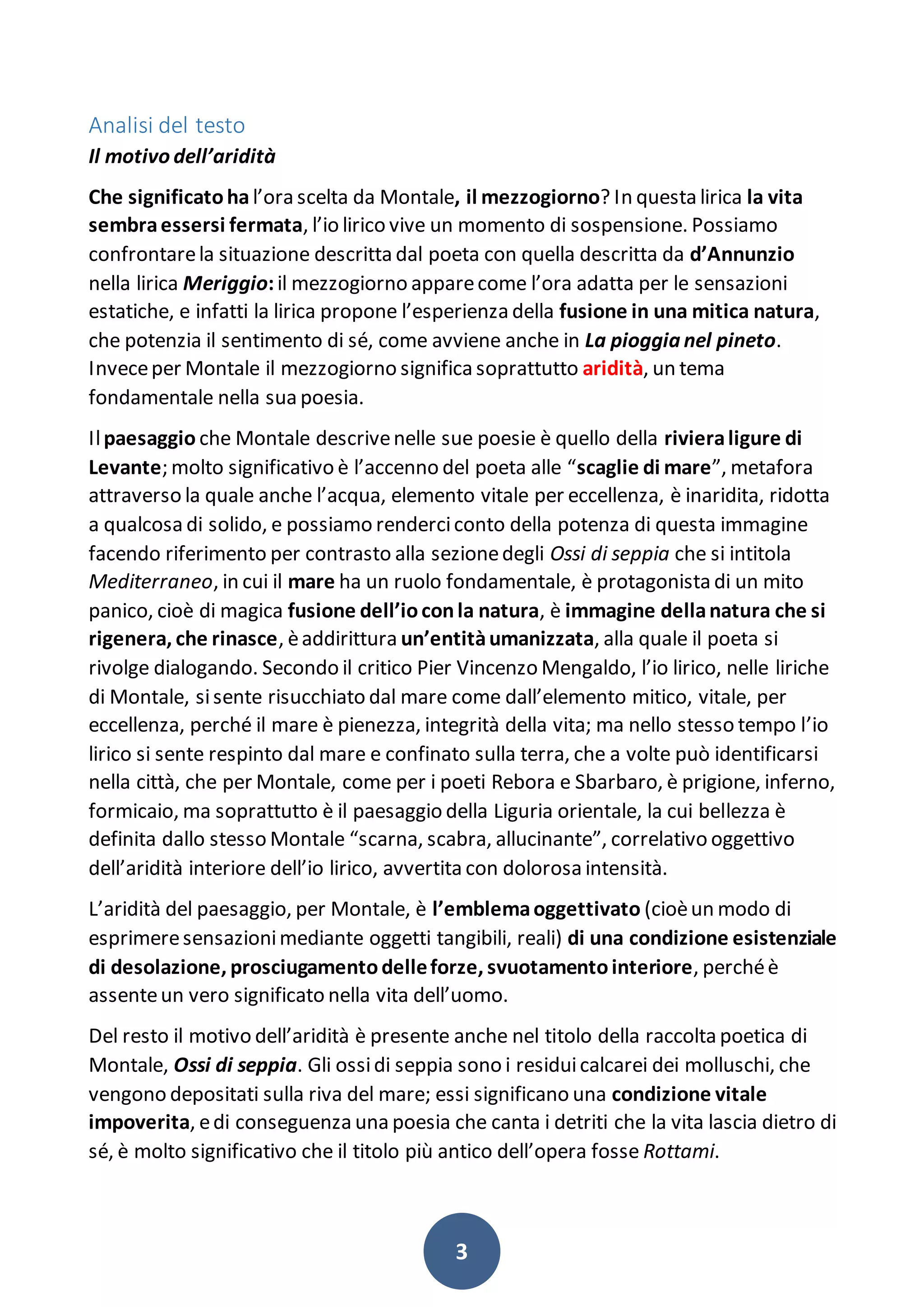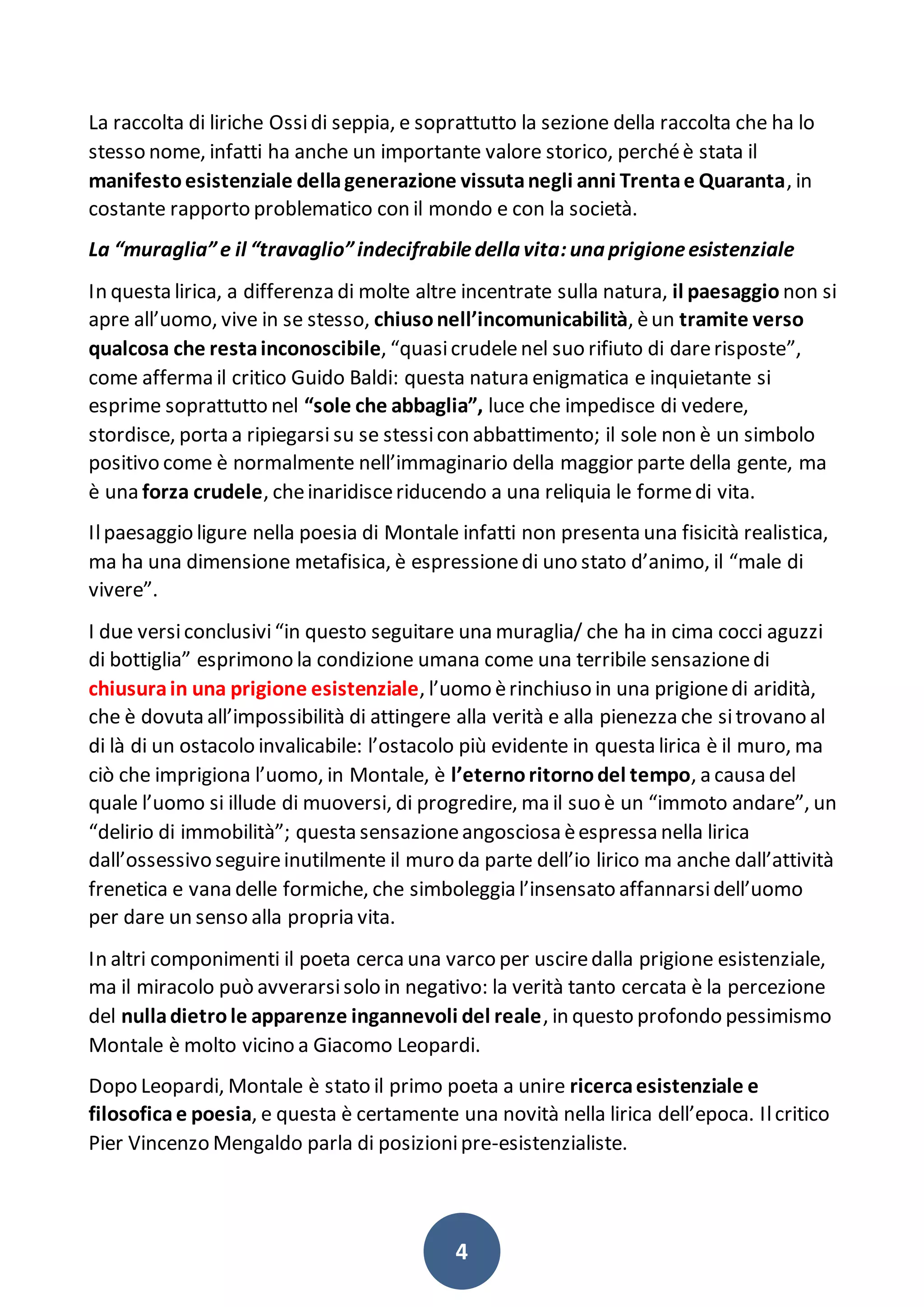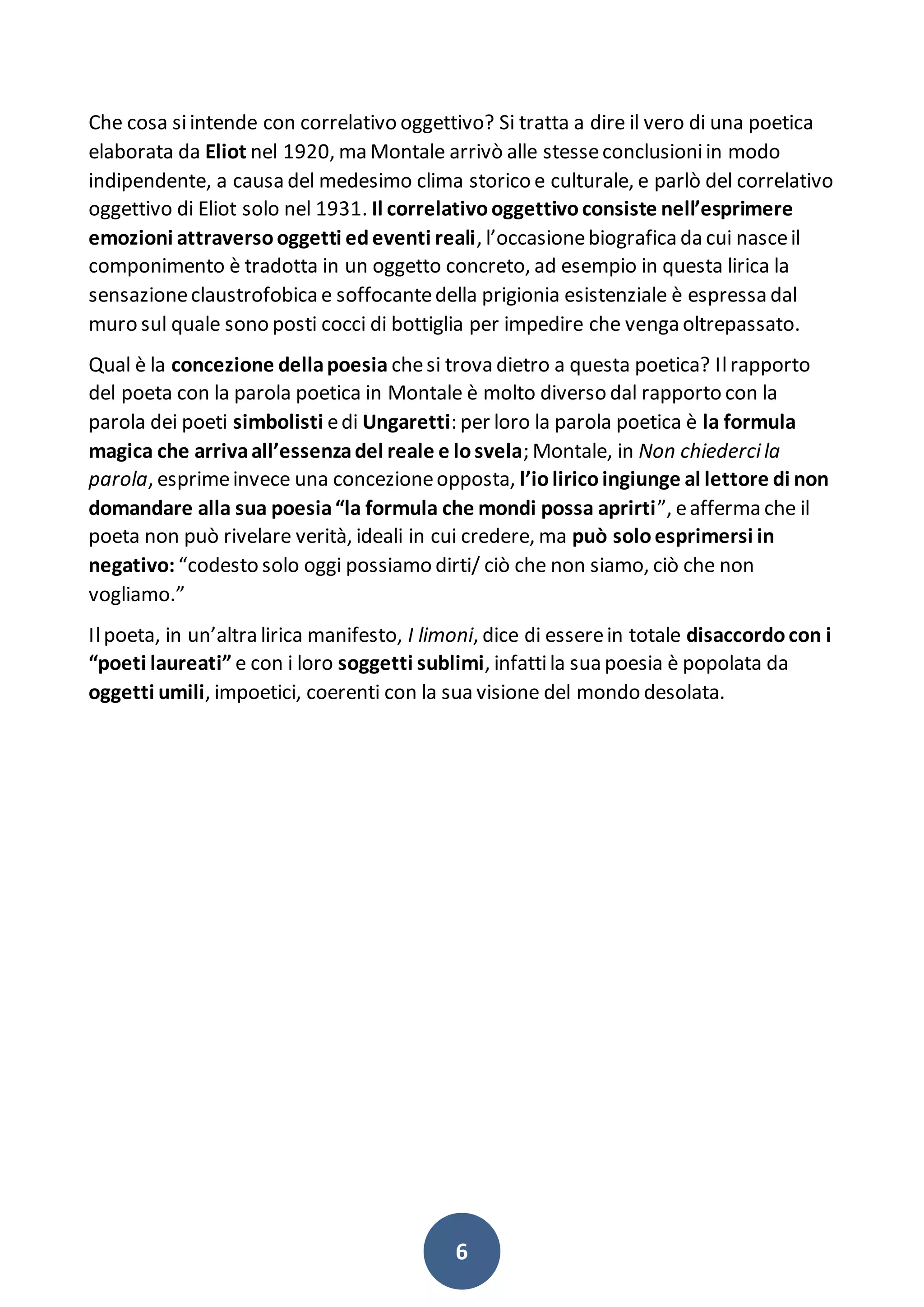La lirica 'Meriggiare pallido e assorto' di Eugenio Montale esprime una profonda angoscia esistenziale attraverso l'immagine di un paesaggio arido e desolato, simboleggiando una condizione interiore di impotenza e vuoto. Utilizzando un linguaggio ricco di metafore e un'analisi della tradizione poetica, il poeta riflette sulla vita come un viaggio senza scopo, intrappolato da una 'muraglia' di esperienze e sofferenze. La raccolta 'Ossi di seppia', da cui proviene questa lirica, funge da manifesto della disillusione di una generazione in crisi durante gli anni '30 e '40.