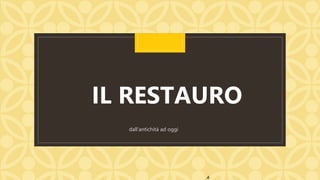
LAVORO ARTE.docx
- 1. C IL RESTAURO dall’antichità ad oggi A
- 4. CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
- 6. La sua storia: ANTICHITÀ Utilizzato per decorare e per motivi religiosi e politici Si basava su: • rifacimento • riedificazione • ripristino Inoltre, in epoca romana, veniva utilizzato lo stacco a massello.
- 10. MEDIOEVO: In questo periodo gli edifici erano riutilizzati come chiese dove, all’interno, le opere venivano aggiornate mediante cambiamenti: • liturgici • politici • estetici
- 11. Come nel caso dei mosaici della Chiesa di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna
- 12. Convertiti in chiese cristiane Pantheon Tempio di Antonio e Faustina
- 13. Chiesa di Sant’Apollinare Nuovo Corteo delle Sante Vergini
- 14. QUATTROCENTO Si intraprendono attività di pulitura dei dipinti e, per gli affreschi, i primi interventi di trasporto. Prende avvio la pratica di intervenire sulle sculture antiche per reintegrale Come nel caso del Laocoonte restaurato da Giovanni Angelo Prima Dopo
- 15. CINQUECENTO In questo periodo continua la tradizione di restaurare e completare sculture antiche per esporle nelle ville e nei palazzi. SEICENTO In questo secolo aumentano i restauri e gli adattamenti. Questo diffonde le pratiche di restauro più comuni: pulitura chimica e pulitura anebulizzazione Foderature patinature artificiali In entrambi i secoli alle pratiche di sostituzione delle opere se ne affiancano progressivamente altre di salvaguardia
- 16. Esempio di «stacco» Esempio di «strappo»
- 18. IL SETTECENTO In questo periodo si affermano due pratiche di distacco dei dipinti murali: • Distacco dell’intonaco (stacco) • distacco della sola pellicola pittorica (strappo) Utilizzate negli scavi
- 20. In questo secolo si afferma pienamente la distinzione tra restauratore e pittore.
- 21. IL NEOCLASSICISMO Introduce lo scrupolo filologico. Il Colosseo è l’esempio più famoso con i suoi due restauri: • parte orientale, ad opera di Raffaele Stern • parte occidentale, ad opera di Giuseppe Valadier L’OTTOCENTO In questo secolo le polemiche sui metodi e sulle concezioni di restauro divengono molto accese. Vengono inoltre teorizzate tre nuove tipologie di restauro: • stilistico (Eugene Viollet -le-Duc ) • romantico (John Ruskin ) • scientifico (Camillo Boito ) Per gli edifici danneggiati/semidistrutti: • riedificazione mimetica • restauro critico
- 22. CESARE BRANDI- storico dell’arte G ran sostenitore del restauro critico. Fondatore nel 1939 dell’Istituto Centrale del Restauro. Propone il concetto di restauro preventivo. Per i monumenti allo stato di rudere ritiene che sia necessario solamente il consolidamento. L’opera d’arte presenta due istanze da cui derivano due principi: • quella estetica • quella storica 1. Il restauro si esegue solo sulla materia costitutiva 2. Il restauro deve mirare a ristabilire l’unita potenziale dell’opera C i sono anche principi pratici su cui deve fondarsi ogni attività di integrazione: 1. deve essere riconoscibile 2. se la materia ha un ruolo fondamentale all’interno dell’aspetto dell’immagine non può essere sostituita; 3. deve essere reversibile
- 23. PROBLEMATICHE DI CUI SI OCCUPO’ • risarcimento delle lacune che risolse teorizzando e adottando la nuova tecnica del rigatino • per le lacune non reintegrabili brandi suggerisce un abbassamento ottico tonale. A questo problema si collega quello della patina del manufatto che va salvaguardata e quindi bisogna evitare l’eccessiva rimozione di quest’ultima Annunciazione di Antonello da Messina Cappella degli Scrovegni, affreschi
- 24. UMBERTO BALDINI storico dell’arte Propone due nuove tecniche: • SELEZIONE CROMATICA (piccole lacune): consiste nel separare i colori in piccoli tratti • ASTRAZIONE CROMATICA (lacune non integrabili): consiste nel riempimento della lacuna con colore neutro e con successive stesure di diversi colori
- 25. GIOVANNI URBANI- storico dell’arte e restauratore Ritiene necessari gli studi preliminari al restauro e l’uso di metodi innovativi . Dà importanza alla conservazione del patrimonio sviluppando : • SISTEMA DI TUTELA PROGRAMMATO per conservare le opere nel loro territorio • RESTAURO PREVENTIVO, che si basa sulla conservazione programmata e sulla manutenzione intesa come attività ordinaria
- 26. CARTA DEL RISCHIO • Scritta negli anni Novanta del Novecento • Si basa sulle idee di Giovanni Urbani che riguardano il restauro preventivo e la manutenzione • Misura i fattori di rischio sul territorio italiano per sapere quali sono i siti dove le opere si danneggiano maggiormente
- 28. statua equestre di Marco Aurelio IL RESTAUROOGGI È un lavoro d’equipe fra pr ofessionalità differenti: • lo storico dell’arte • lo scienziato • il restauratore In più: • sono stati integrati nuovi materiali • viene sempre utilizzata u n’adeguata documentazione
- 29. RESTAURO BASILICA DI SAN FRANCESCO (ASSISI) Intervento necessario dopo il terremoto del 1997. • DANNI MAGGIORI : lesioni sula volta della Basilica Superiore, due grandi squarci in prossimità dell’altare e dell’ingresso, frantumazione delle figure di 8 Santi e della Volta di San Girolamo Il cantiere fu soprannominato «CANTIERE DELL’UTOPIA» a causa della difficoltà del restauro che durò 8 anni sotto la guida di Giuseppe Basile .
- 30. METODI: • Classificazione dei frantumi degli affreschi al fini del riconoscimento grazie all’ausilio di gigantografie delle opere figure degli 8 Santi • Abbassamento ottico (metodo di Brandi) che consiste nello smorzamento dell’intonaco bianco con gli acquerelli Vela di San Girolamo • Ancoraggio rimovibile che rispetta il concetto di reversibilità del restauro Vela di San Girolamo