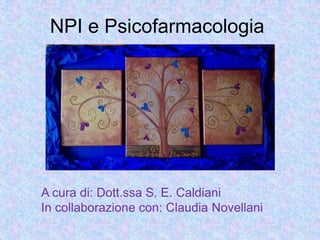
Npi e psicofarmaci
- 1. NPI e Psicofarmacologia A cura di: Dott.ssa S. E. Caldiani In collaborazione con: Claudia Novellani
- 2. Dott.ssa Silvia E. Caldiani Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, attualmente lavora per la NEUROPSICHIATRIA INFANTILE territoriale dell’ASL di Reggio Emilia.
- 3. Claudia Novellani Laureanda in psicologia clinica Università degli studi di Parma
- 4. Ambito di intervento della NPIA Età evolutiva Disturbi Neurologici Disturbi di Sviluppo Disturbi Psicopatologici
- 5. Rapporti culturali ed operativi della NPIA Neurologia Psichiatria Psicologia Riabilitazione Scienze Sociali Pedagogia Pediatria NPIA
- 6. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Approccio integrato: - competenze mediche e non mediche; Condivisione progetti e obiettivi: - linguaggi; - spazi; - prassi (riunioni di equipe, supervisione, gruppi di lavoro, colloqui tecnici).
- 7. Per una diagnosi ed un intervento corretti è necessario conoscere: - lo sviluppo tipico ed atipico; - le dinamiche delle relazioni familiari ed extra- familiari; - lo sviluppo del bambino; - le dinamiche della sua famiglia e del suo ambiente; - i punti di fragilità e le risorse disponibili.
- 8. La scuola è un “SETTING” PRIVILEGIATO, dove sono più IMMEDIATAMENTE OSSERVABILI COMPORTAMENTI PRECURSORI di un possibile DISAGIO che, a seconda della valenza, possono costituire la base per la costruzione successiva delle condotte sia socioaffettive che cognitive.
- 9. La scuola Rappresenta la prima istituzione nella quale il bambino deve: • adattarsi ad un AMBIENTE STRUTTURATO, • adeguarsi alle regole scolastiche, • raggiungere livelli prestabiliti di rendimento nei diversi ambiti dell’apprendimento • comportarsi in maniera adeguata ed appropriata all’età secondo i parametri sociali di riferimento. Tutte esperienze che contribuiscono ad una rielaborazione e ridefinizione del sé.
- 10. Nell’iter scolastico si evidenziano una serie di POTENZIALI EVENTI STRESSANTI: • eventi a carattere eccezionale (bocciature, trasferimenti, sospensioni); • eventi più comuni e ricorrenti (insuccessi, critiche e punizioni); • eventi che sono parte integrante del normale iter scolastico (primo ingresso a scuola, esami finali, passaggio da un ciclo di studi al successivo).
- 11. La scuola può costituire un elemento di attenuazione e MODERAZIONE del DISAGIO oppure può rappresentare uno STRESSOR la cui interazione, con ulteriori fattori di rischio, può avere effetti destabilizzanti.
- 12. Incidenza dei disturbi neuropsichici L’incidenza dei disturbi neuropsichici nella popolazione in età evolutiva, è oggetto di crescente attenzione da parte delle principali istituzioni politiche e scientifiche internazionali, anche perché se non adeguatamente riconosciuti e trattati, possono rappresentare la base delle futura psicopatologia dell’adulto.
- 13. Presa in carico e progetto terapeutico Di fronte ad un bambino con un disturbo di pertinenza neuropsichiatrica deve essere necessariamente messa in atto una presa in carico globale del bambino, della famiglia, dell’ambiente e delle relazioni paziente-famiglia-ambiente.
- 14. Disturbi comportamentali Spesso, in passato, sono state usate espressioni poco chiare quale, ad esempio quella di “alunno caratteriale”, per riferirsi a quei ragazzi il cui comportamento era talmente problematico da rendere estremamente difficile l’inserimento dentro la classe. All’interno di diverse agenzie sociali, si ricorre a particolari criteri per descrivere bambini e adolescenti con comportamenti problematici. La scuola può evidenziare difficoltà: a seguire le regole, a partecipare alle lezioni, a relazionarsi con i compagni, oltre ad un inadeguato rendimento scolastico. La famiglia può riferire difficoltà a farsi obbedire, ribellione, alterazioni dell’umore. I tribunali pongono l’attenzione su comportamenti devianti quali: violenza, atti di vandalismo, furti e altre violazioni della legge. (Di Pietro, 2009)
- 15. Possiamo dire che è presente un disturbo del comportamento quando il bambino o l’adolescente mostrano eccessi o deficit comportamentali che adulti autorevoli nell’ambiente circostante giudicano particolarmente rilevanti. Tali caratteristiche comportamentali sono considerate atipiche in quanto la loro frequenza, la loro intensità o la loro durata si scostano dalla norma. Gli eccessi comportamentali o i deficit possono manifestarsi attraverso uno o più repertori (cognitivo, verbale, emotivo, fisico, motorio) ed essere presenti in una varietà di situazioni. (Gresham, 1985)
- 16. Quando ci si riferisce ad un alunno con problemi di comportamento ci troviamo ad affrontare difficoltà che appartengono alla sfera dei disturbi esternalizzati. Si tratta di quei disturbi che, come il termine lascia supporre, si contraddistinguono per il fatto che il disagio del bambino o dell’adolescente si riversa verso l’esterno, provocando una situazione di disturbo nell’ambiente circostante. Nel DSM-IV i disturbi del comportamento del bambino e dell’adolescente vengono inclusi nella categoria “Comportamenti dirompenti” che comprende i seguenti disturbi: Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (Cod. ICD – 10 = F 90); Disturbo Oppositivo Provocatorio (Cod. ICD – 10 = F 91.3); Disturbo della Condotta (Cod. ICD – 10 = da F 91 a F 91.9).
- 17. Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (DDAI o ADHD) All’interno della categoria DDAI ci sono due sottocategorie: disattenzione e iperattività/impulsività; il decorso del disturbo varia. L’iperattività nella fanciullezza è un fattore di rischio per abuso di sostanze più avanti nel tempo, e/o disturbo antisociale di personalità. Esordio dei sintomi prima dei 7 anni; i sintomi devono essere presenti in due o più situazioni (scuola e casa). A scuola le difficoltà aumentano, poiché le disattenzioni causano problemi nel terminare compiti scolastici. Il deficit primario riguarda la distraibilità e la mancanza primaria di attenzione. I sintomi di iperattività/impulsività creano problemi a scuola, a causa dell’estrema irrequietezza.
- 18. I sintomi dell’ADHD possono non essere gli stessi per tutti 50-75% 20-30% < 15% Tipo Combinato Prevalentemente Iperattivo/ Impulsivo Prevalentemente Inattentivo Prevalentemente Inattentivo: - facilmente distraibile; -ma non eccessivamente iperattivo/ impulsivo. Prevalentemente Iperattivo/ Impulsivo: - estremamente Iperattivo/Impulsivo; -può non avere sintomi di inattenzione; - frequentemente bambini piccoli. Sottotipo Combinato: - maggioranza dei pazienti; -presenti tutte e tre i sintomi cardini. (Inattenzione, Iperattività/Impulsività)
- 19. SOTTOTIPI DEL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA’ (DDAI), SECONDO IL DSM-IV: • disturbi da DDAI, tipo combinato: almeno 6 sintomi di disattenzione e almeno 6 sintomi di iperattività/impulsività sono stati presenti per almeno 6 mesi. • disturbi da DDAI, tipo con disattenzione prevalente: sono presenti 6 sintomi di disattenzione, ma meno di 6 sintomi di iperattività/impulsività, per almeno 6 mesi. • disturbi da DDAI, tipo con iperattività/impulsività prevalenti: sono presenti almeno 6 sintomi di iperattività/impulsività, ma meno di 6 sintomi di disattenzione. • disturbi da DDAI-NAS: disturbi con sintomi rilevanti di disattenzione e iperattività/impulsività.
- 20. Deficit di attenzione focale e sostenuta; Facile distraibilità (stimoli banali); Ridotte capacità esecutive (compiti scolastici, attività quotidiane, gioco); Difficoltà nel seguire un discorso; Interruzione di attività iniziate; Evitamento di attività che richiedono sforzo cognitivo. Inattenzione
- 21. Sottotipo a disattenzione prevalente Le poche ricerche disponibili condotte finora sostengono che esistono bambini con solo deficit attentivo (sottotipo con disattenzione predominante), senza o con minimi tratti di iperattività. Di solito sono bambini: tranquilli, gentili, affettuosi, intelligenti ma che apparentemente sembrano non applicarsi. Tendono a essere più paurosi e ansiosi dei loro coetanei, vivono “tra le nuvole”, quasi in uno stato di letargo. I loro deficit principali riguardano la memoria e la velocità di analisi delle informazioni in entrata. Manifestano minori problemi di aggressività e d’impulsività rispetto ai coetanei DDAI in generale e al sottotipo iperattivo-impulsivo in particolare, per questo hanno minori difficoltà relazionali. Queste caratteristiche rendono il loro comportamento meno invasivo e di conseguenza anche meno riconoscibili le loro difficoltà. Questo genere di problematiche non sembra attenuarsi particolarmente con l’età e si presenta con percentuali analoghe nei due sessi.
- 22. Incapacità di stare fermi; attività motoria incongrua e a- finalistica; gioco rumoroso e disorganizzato; eccessive verbalizzazioni; ridotte possibilità di inibizione motoria. Iperattività
- 23. •Difficoltà di controllo comportamentale; •incapacità di inibire le risposte automatiche; •scarsa capacità di riflessione; •difficoltà a rispettare il proprio turno; •tendenza ad interrompere gli altri; •incapacità di prevedere le conseguenze di una azione; •mancato evitamento di situazioni pericolose. Impulsività
- 24. Sottotipo iperattivo-impulsivo Esistono poi bambini la cui principale difficoltà risiede non tanto nel prestare attenzione, ma piuttosto nella loro estrema vivacità e impulsività (sottotipo con iperattività-impulsività predominanti). Sono bambini descritti da genitori e insegnanti come irrequieti, perennemente in movimento, quasi fossero “sempre sul punto di partire”. Giocano in modo rumoroso, parlano eccessivamente e con un’intensità di voce piuttosto alta. A causa della loro impulsività, sono molto impazienti, incapaci di posticipare o semplicemente attendere la soddisfazione di qualsiasi desiderio o di concedersi tempo per svolgere al meglio le attività in cui sono impegnati. In altri termini, non riescono a controllare i propri comportamenti, gli impulsi e le emozioni, attraverso meccanismi di ponderazione e discernimento. Queste manifestazioni tendono a ridursi con l’età e si presentano con una frequenza tre volte maggiore nei maschi rispetto alle femmine.
- 25. Sottotipo combinato Esiste, infine, un sottotipo definito «combinato» nel cui caso sono evidenti sia manifestazioni di disattenzione che di iperattività e impulsività. Tale sottotipo presenta, pertanto, problemi di perseverazione nello svolgimento dei compiti e di inibizione dei dati irrilevanti, e inadeguata elaborazione delle informazioni contenute nella memoria di lavoro. I bambini con DDAI sottotipo combinato e iperattivo-impulsivo si oppongono frequentemente alle richieste che vengono loro rivolte, a volte presentano aggressività e nel 30% dei casi ricevono una seconda diagnosi di disturbo della condotta o di disturbo oppositivo-provocatorio.
- 26. DSM-V: nuovi criteri diagnostici Inizio dei sintomi prima di 12 anni; Criteri più sensibili per soggetti adolescenti o adulti; Per adolescenti > 17 anni ed adulti, sono richiesti 4 anziché 6 sintomi; Non più autismo come criterio di esclusione.
- 27. DISTURBO OPPOSITIVO-PROVOCATORIO Modalità ricorrente di comportamento: negativistico, provocatorio, disobbediente, ed ostile nei confronti delle figure dotate di autorità, che persiste per almeno 6 mesi, ed è caratterizzato da frequente insorgenza durante i quali sono stati presenti 4 (o più) dei seguenti sintomi: 1) spesso va in collera; 2) spesso litiga con gli adulti; 3) spesso sfida attivamente o si rifiuta di rispettare le richieste o regole degli adulti; 4) spesso irrita deliberatamente le persone; 5) spesso accusa gli altri per i propri errori o il proprio cattivo comportamento; 6) spesso suscettibile o facilmente irritato dagli altri; 7) spesso arrabbiato e rancoroso; 8 ) spesso dispettoso e vendicativo.
- 28. Il DOP diviene di solito evidente prima degli 8 anni di età e di solito non più tardi dell'adolescenza. I sintomi di opposizione spesso emergono nell'ambiente familiare, ma col tempo possono comparire anche in altri contesti. L'esordio è tipicamente graduale e di solito avviene nel corso di mesi o anni. In una quantità significativa di casi, il Disturbo Oppositivo Provocatorio precede lo sviluppo del Disturbo della Condotta. Questo disturbo risulta relativamente stabile nel tempo, ed è predittore dello sviluppo di una personalità antisociale in età adulta. Col passare del tempo la risposta al trattamento diminuisce. Il DOP è associato frequentemente a ADHD, basso Q.I., ed è in buona parte ereditario o appreso.
- 29. DISTURBO DELLA CONDOTTA I comportamenti dirompenti dei soggetti con Disturbo della Condotta sono di natura più grave rispetto a quelli dei soggetti con DOP e tipicamente includono, oltre alle manifestazioni del DOP: aggressioni contro persone o animali; distruzione di proprietà; l'abitudine al furto o alla frode. Il disturbo della condotta può essere suddiviso in due sottotipi: Tipo con Esordio nella Fanciullezza Questo sottotipo è definito sulla base dell'esordio di almeno uno dei criteri caratteristici del Disturbo della Condotta, prima dei 10 anni di età. Tipo ad Esordio nell'Adolescenza Questo sottotipo è definito dall'assenza di tutti i criteri caratteristici del Disturbo della Condotta, dopo i10 anni di età.
- 30. Caratteristiche del DC I ragazzi con Disturbo della condotta presentano specifiche distorsioni cognitive e manifestano deficit emotivi: otendono ad attribuire ad altri intenzioni ostili; osottostimano il proprio livello di aggressività e responsabilità nell’ iniziare una lite; osono anaffertivi e aggressivi ; oIpo-analitici e scarsamente empatici; omanifestano pattern anomali di identificazione delle emozioni (difficoltà ad anticipare sentimenti di paura e tristezza, confondono la rabbia con l’eccitazione); ohanno una visione positiva dell’aggressività nella risoluzione di problematiche sociali; ocredono che il comportamento aggressivo possa accrescere l’autostima.
- 31. La Terapia farmacologica in età evolutiva La terapia farmacologica è solo una parte, peraltro, la meno frequente, delle componenti della presa in carico che viene ad aggiungersi all’insieme degli altri interventi terapeutici: educativi, psicologici e di supporto ambientale.
- 32. Linee guida Nella decisione di intervenire farmacologicamente in età evolutiva sono di ausilio linee guida fondamentali: 1) La persistenza di un disturbo in età evolutiva non adeguatamente curato, può arrecare danni permanenti in epoche successive, che possono manifestarsi con la cronicizzazione del disturbo o con una facilitazione all’insorgenza successiva della patologia psichiatrica. 2) La persistenza del disturbo psichiatrico determina una patologia del rapporto relazionale, che può contribuire alla cronicizzazione del disturbo. 3) Non esistono terapie che non abbiano rischi di conseguenze; anche una modalità di interazione psicoterapeutica errata può avere effetti negativi, per questo è importante la modalità dell’intervento, la sua qualità e la sua durata in funzione della ragionevoli attese circa la sua efficacia.
- 33. Classi di psicofarmaci - Antipsicotici o neurolettici - Antidepressivi - Stabilizzanti dell'umore - Ansiolitici - Psicostimolanti - Antagonisti recettoriali degli oppiacei + - Antiepilettici - Beta-bloccanti
- 34. Gli stakeholder: sono tutte quelle persone che beneficiano della terapia farmacologica in maniera indiretta (compagni di classe, familiari, insegnanti, amici, ecc.). E’ di notevole importanza comprendere come ci possa essere un beneficio percepito dall’intero sistema relazionale ed ambientale.
- 35. Compliance e Concordanza La partecipazione del paziente e della sua famiglia deve andare oltre la semplicistica compliance ed arrivare invece alla concordanza. Compliance: il grado con cui il paziente «ubbidisce» alla prescrizione medica. Concordanza: la partecipazione alla costruzione di un accordo tra paziente e medico.
- 36. Di tutto questo intricato e delicatissimo processo deve essere parte fondamentale anche la famiglia. L’elaborazione di un progetto condiviso, infatti, dovrà essere tenuta ben presente, in quanto andrà a sconvolgere inevitabilmente tutto il sistema famiglia, già consolidato all’interno delle proprie routine e dei propri schemi di comportamento.
- 37. •Attualmente vi è un graduale incremento nell’uso degli psicofarmaci in età evolutiva. •Questo è dovuto agli innegabili progressi degli studi in materia di psico-farmacoterapia dell’infanzia e adolescenza. scoperta di nuove molecole meglio tollerate; contributo delle neuroscienze; evoluzione culturale circa gli aspetti di diagnosi e di trattamento della psicopatologia dell’età evolutiva.
- 38. Non si deve però dimenticare che un approccio esclusivamente farmacologico ai disturbi mentali, rischia di portare ad una semplificazione grossolana e riduttiva. Pensare che il riequilibrarsi di alcuni degli innumerevoli sistemi neurotrasmettitoriali possa permettere il modificarsi di pensieri, comportamenti, relazioni e condizioni affettive è inesatto e fuorviante.
- 39. Approccio integrato e globale •Si rende necessario prendere in considerazione l’importanza di un intervento integrato e globale. •L’intervento farmacologico deve essere integrato con altri strumenti terapeutici e collocato all’interno di un approccio globale al bambino e all’adolescente, che tenga presente anche il contesto familiare, sociale e scolastico, in cui egli è inserito. •Secondo questo tipo di approccio rimane prioritario l’intervento sulla relazione e sul contesto, ed è in questo ambito e in una chiave di lettura dinamica che va considerato anche l’uso dei farmaci. USO DEGLI PSICOFARMACI INTERVENTI PSICO-SOCIALI
- 40. IMPLICAZIONI PSICODINAMICHE DELLA PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PSICOFARMACI IN ETA’ EVOLUTIVA •L’effetto del farmaco non è legato solo all’aspetto chimico, ma anche all’atteggiamento dei genitori e del bambino/adolescente, nei confronti del farmaco. •La prescrizione e la somministrazione del farmaco, comporta una serie di implicazioni, che coinvolgono il rapporto del soggetto e della famiglia con: il farmaco, con il disturbo, l’equilibrio familiare e così via… •La prescrizione e la somministrazione del farmaco, va quindi pensata considerando che esso è un elemento della relazione terapeutica e non solo un oggetto che ha azione biologica.
- 41. Il farmaco ha un valore simbolico per tutte le persone coinvolte nella somministrazione: •Genitori che richiedono il farmaco: – può avere diverse valenze: emotive, fantasie collegate, spinte aggressive o sensi di colpa (per esempio non tollerano l’ansia legata alla sofferenza del figlio, oppure il farmaco ha significato di sostituire l’affetto che essi non riescono a dare al bambino); – la prescrizione va fatta sempre all’interno dell’analisi della domanda, ed è importante comprendere e rendere i genitori consapevoli di quali sono le valenze emotive che li hanno portati a richiedere il farmaco. •Genitori che rifiutano il farmaco: analizzare e lavorare sulle “fantasie” legate al farmaco: - il farmaco può modificare la mente del bambino; - timore della dipendenza. La prescrizione del farmaco può talora conferire al disturbo del bambino uno statuto nuovo, determinando un vero e proprio cambiamento nella rappresentazione che i genitori hanno del bambino e della sua patologia.
- 42. Adolescente – Richiede il farmaco: • il motivo più spesso riportato è legato al fatto che i disturbi ostacolano le attività quotidiane; • tentativo di eludere la dimensione intrapsichica del problema; • può essere legata ad una dinamica regressiva. La prescrizione deve analizzare, quindi, i significati sottostanti legati alla domanda e metterli in luce. – Rifiuta il farmaco = diverse situazioni e motivazioni: •il sintomo ha un significato costitutivo della propria identità (farmaco = intrusione); •rigetto nei confronti di un controllo esterno diretto o indiretto; •ferita narcisistica: la prescrizione del farmaco mette l’adolescente di fronte alla fragilità delle proprie risorse psichiche; •farmaco può assumere significato fobico o persecutorio: sostanza esterna che penetra all’interno del corpo per possederlo. Farmacoresistenza: si ha quando la resistenza ad un cambiamento è così forte da provocare una ricaduta anche sui meccanismi biologici dell’efficacia del farmaco.
- 43. … quindi: •Diventa importante collocare la prescrizione farmacologica all’interno della relazione terapeutica, analizzando le varie fantasie, ansie, preoccupazioni e valenze emotive circa l’assunzione di farmaci. •E’ importante considerare che l’effetto dipende non solo dal farmaco, ma anche dal valore che esso ha assunto nella relazione.
- 44. INTERVENTI •Primo livello di intervento: esplicativo, che illustri ai genitori e al bambino/adolescente, le caratteristiche del problema e la possibilità di eventuale intervento ambientale. •Secondo livello di intervento: in situazioni di maggiori compromissioni funzionali, proposta di intervento psicologico individuale o familiare. •Terzo livello di intervento (se i precedenti risultano insufficienti): terapia farmacologica. – I dati circa l’efficacia non sono univoci; – talora gli effetti collaterali sono più invalidanti dei sintomi stessi. Tenere sempre presente l’importanza di un progetto terapeutico integrato (interventi che considerino la famiglia, la scuola, il gruppo classe, l’individuo e anche l’intervento farmacologico).
Editor's Notes
- Key Points: Il sottotipo inattentivo è quello meno riconosciuto dovuto ad una componente motoria meno evidente. Rappresenta tra 1/5 ad 1/3 dei pazienti ADHD. In contrasto, la maggioranza dei pazienti ADHD hanno tutte e due i sintomi, inattenzione e iperattività/impulsività motoria e rappresentano tra il 50-75% dei pazienti ADHD. Il sottotipo prevalentemente iperattivo rappresenta meno del 15% dei pazienti. L’Inattenzione o facile distraibilità, si manifesta soprattutto come scarsa cura per i dettagli ed incapacità a portare a termine le azioni intraprese: i bambini appaiono costantemente distratti come se avessero sempre altro in mente, evitano di svolgere attività che richiedano attenzione per i particolari o abilità organizzative, perdono frequentemente oggetti significativi o dimenticano attività importanti. L’impulsività si manifesta come difficoltà, ad organizzare azioni complesse, con tendenza al cambiamento rapido da un’attività ad un’altra e difficoltà ad aspettare il proprio turno in situazioni di gioco e/ attività di gruppo. Tale impulsività è generalmente associata a Iperattività: questi bambini vengono riferiti come “mossi da un motorino”, hanno difficoltà a rispettare le regole, i tempi e gli spazi dei coetanei, a scuola trovano spesso difficile anche rimanere seduti. Tutti questi sintomi non sono trattati da deficit cognitivo (ritardo mentale) ma da difficoltà oggettive nell’autocontrollo e nella capacità di pianificazione. References: American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Text Revision. Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000. Barkley RA. Attention-deficit/hyperactivity disorder. In: Mash EJ, Barkley RA, eds. Child Psychopathology 1996;63-112