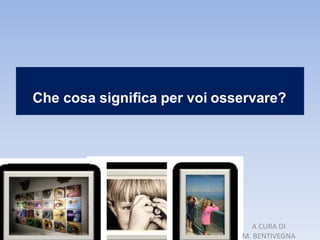
L'osservazione
- 1. Che cosa significa per voi osservare? A CURA DI M. BENTIVEGNA
- 2. Osserva e descrivi una situazione
- 3. Cosa è l’osservazione L'osservazione è un procedimento selettivo e si differenzia dal semplice guardare o vedere perchè lo sguardo dell'osservatore è guidato e selettivo e mira ad ottenere le informazioni rilevanti nel modo più accurato ed efficace. Ogni persona compie quotidianamente un numero molto ampio di osservazioni, che danno modo di conoscere, classificare, analizzare componenti diverse dell' ambiente umano e fisico che ci circonda.
- 4. Osservazione Osservatore Relazione fortissima e non eliminabile
- 5. Ruolo dell’osservatore Persona che in qualche modo “seleziona” i dati dell’osservazione Stabilisce un rapporto con l’oggetto dell’osservazione, si deve conoscere e definire il modo in cui si comporta con l’altro e il modo in cui agisce nell’ambiente e nel contesto di osservazione “incontro tra due persone” (osservatore e osservato) – ulteriore dato dell’osservazione
- 6. Tipi di osservazione 1-L'OSSERVAZIONE DIRETTA L'osservazione è diretta quando il suo impiego non richiede la presenza di strumenti o dispositivi che si frappongono tra l'osservatore e l'osservato, e si svolge senza una dilazione temporale , ossia osservazione e registrazione dei dati sono effettuate contemporaneamente. Esempio: visione diretta parco sommerso
- 7. Tipi di osservazione 2-L'OSSERVAZIONE NATURALISTICA L'osservazione naturalistica viene adottata per lo studio dei fenomeni e comportamenti che si presentano allo stato naturale, cioè in situazioni di vita reale. All'interno dello svolgersi di queste, uno o più osservatori registrano tutto ciò che avviene avendo cura di evitare che stimolazioni di disturbo possano interferire o alterare la comparsa spontanea di un certo comportamento. Il ruolo dell'osservazione naturalistica è studiare la natura per sé.
- 8. Tipi di osservazione 3-L'OSSERVAZIONE INDIRETTA L'osservazione si dice indiretta quando utilizza strumenti che si frappongono tra l'osservatore e l'osservato. Lo scopo di questi strumenti è soprattutto quello di raccogliere opinioni, idee ed esperienze circa il mondo e il comportamento dei soggetti.
- 9. osservatore Processo interno dell’osservatore mentre osserva Capacità di integrare e riflettere Consapevolezza del proprio mondo interno L’osservatore partecipa e interagisce L’osservatore registra ciò che avviene
- 10. ALTRA CARATTERISTICA L'OSSERVAZIONE PARTECIPANTE E NON L'esser coinvolto con il soggetto osservato, o l'intervenire nel contesto rappresentano un'altro aspetto secondo il quale si può considerare l'osservazione, cioè partecipante o non/partecipante.
- 11. Tipi di osservazione 1. osservazione partecipante (o partecipe), quando l’osservatore partecipa al fenomeno osservato divenendo egli stesso parte della situazione; 2. osservazione distaccata quando, invece, l’osservatore occupa una posizione esterna al campo di osservazione
- 12. Osservazione partecipe Caratteristiche: – L’osservatore è parte del fenomeno osservato – Si raccolgono informazioni in più ambiti osservativi – Si osservano comportamenti, reazioni, e vissuti – Si pone attenzione al significato al comportamento – Si confrontano e correlano dati, simboli, relazioni ed esperienze che hanno significato per il soggetto. – Si evita di attribuire significato arbitrario e chiarisce elementi non evidenti del comportamento – Si sospende di giudizio fino a che non ci siano dati che ne suggeriscono la rilevanza.
- 13. Osservazione distaccata Caratteristiche L’osservatore occupa una posizione esterna al campo di osservazione, è indifferente agli approcci del soggetto osservato, è silenzioso e discreto E’ data maggiore attenzione al dettaglio Descrizione rigorosa del comportamento e sua misurazione Attenzione alla rilevazione del comportamento Parte da osservazioni libere e poi sceglie i dati in base alla regolarità
- 14. 1- La descrizione Trae origine dal metodo dei diari che dal punto di vista storico, è uno dei metodi più antichi utilizzati in psicologia. Esso consiste nel segnare per iscritto, giorno per giorno, la successione dei comportamenti o delle modificazioni dei comportamenti che si verificano. E’ introdotta una limitazione temporale, spaziale o situazionale al cosa osservare. Posta questa limitazione, il compito dell'osservatore resta quello di descrivere tutto quello che accade, senza essere in alcun modo deliberatamente selettivo Appare chiaro che questo metodo ha il pregio di descrivere il comportamento nella sua continuità. Tecniche per osservare o per registrare idati
- 15. Esempio: descrivi un oggetto
- 16. Esempio 2: descrivi un compagno di classe
- 17. Il metodo della descrizione nella stesura dei testi Il testo descrittivo
- 18. Il testo descrittivo Il testo descrittivo mostra, attraverso un’attenta osservazione come e’ fatta una cosa (un luogo, una persona, un animale), evidenziandone le caratteristiche, le qualità, gli aspetti distintivi, allo scopo di fornirne un’immagine chiara e completa.
- 19. Obiettivo del testo descrittivo 1)L’obiettivo principale di un testo descrittivo è informare: è il caso delle descrizioni tecniche e scientifiche presenti nelle enciclopedie, nei manuali, nei dizionari, nelle guide. 2)Accanto a questo obiettivo, però, se ne possono perseguire altri come Influenzare il destinatario (colui a cui è indirizzato il testo), positivamente o negativamente, circa l’oggetto della descrizione. Il testo viene in questo caso usato a scopo prevalentemente persuasivo. A questa categoria appartengono i testi pubblicitari, che pongono in evidenza le qualità del prodotto e ne omettono i difetti, allo scopo di indurre il destinatario ad apprezzare il prodotto in questione a scapito di altri. 3)Nel caso in cui domini invece l’esigenza di esprimere, attraverso una descrizione, sentimenti, emozioni o stati d’animo, prevale lo scopo espressivo. Questa tipologia di testi è molto diffusa in tutti gli ambiti della vita sociale. Spesso si trovano inseriti all’interno di un testo narrativo, espositivo o argomentativo. Qualunque testo giornalistico, pubblicitario, manuale scientifico, ecc… contiene, infatti, una o più parti descrittive.
- 20. La struttura del testo descrittivo La struttura del testo descrittivo I testi descrittivi, pur variando tra loro a seconda dell’oggetto descritto, della situazione comunicativa e dello scopo per cui sono prodotti, presentano, nella loro struttura, alcune caratteristiche generali: - il referente, cioè la cosa, la persona o l’animale descritto; - le qualità e le parti, cioè gli elementi del referente che vengono elencati durante la descrizione. Per offrire un quadro chiaro dell’oggetto è necessario che si facciano riferimenti precisi alle varie parti di cui è composto e alle qualità che lo contraddistinguono.
- 21. Tipi di descrizione Descrizione soggettiva e oggettiva La descrizione può essere fatta in modo personale (soggettivo) o in modo impersonale (oggettivo). Nella descrizione soggettiva l’autore propone il referente della descrizione (cioè l’oggetto descritto) dal suo personale punto di vista; ne dà una rappresentazione filtrata attraverso il suo particolare modo di vedere e di sentire la realtà che lo circonda, nell’intento di suscitare analoghe emozioni nel destinatario. Lo scopo principale di un testo di questo tipo è evidentemente persuasivo o emotivo
- 22. ESEMPIO DI TESTO SOGGETTIVO Non avevo mai visto niente di più bello. Era perfetta, ancora più affascinante di come l’avevo immaginata. Alcune settimane prima, quando l’avevo vista su quella fotografia, mi avevano colpito la linea snella e i colori brillanti, che facevano risaltare le sue forme armoniose. Ora lei era davanti a me: immobile, sicura di sé, che mi guardava. Ero così emozionato che non riuscivo ad avvicinarmi. Mi chiedevo se quella che stavo vivendo era una situazione reale o uno straordinario sogno, che si sarebbe dissolto poco dopo, per sempre. Chiusi gli occhi, li riaprii. Lei era ancora lì: splendente. La guardai, prima di avvicinarmi, in ogni dettaglio: nella realtà era più grande e meno leggera di come appariva in fotografia, ma non per questo meno proporzionata; mi appariva elegantissima, curata in ogni particolare. Mi feci coraggio e mi accostai, dicendole che il suo arrivo mi riempiva di felicità. Lei, muta, mi faceva capire che sarebbe stata per me una amica fedele e una inseparabile compagna di viaggio. L’avevo desiderata tanto ed ora era mia: era la mia nuova moto.
- 23. DESCRIZIONE OGGETTIVA Nella descrizione oggettiva l’autore non esprime emozioni o giudizi personali, presenta il referente in modo impersonale e oggettivo. Lo scopo preminente di questo tipo di descrizione è quello informativo.
- 24. ESEMPIO DI TESTO OGGETTIVO Esempio: La regione Marche, collocata nell’Italia centrale, è bagnata, ad est, dal mare Adriatico e confina a nord con L’Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino, ad ovest con la Toscana e l’Umbria, a sud con l’Abruzzo e il Lazio. Il suo territorio (10 chilometri quadrati circa) è suddiviso fra quattro province: Pesaro, Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno. Ancona è il capoluogo delle Marche. Lo sviluppo delle vie di comunicazione è la condizione fondamentale per il raggiungimento di questa meta. Il principale asse stradale, autostradale e ferroviario si snoda lungo la costa adriatica e a esso fanno capo importanti arterie trasversali, che mettono in comunicazione il versante adriatico con quello tirrenico. (Modificato da Enciclopedia della geografia, De Agostini, Novara, 1996)
- 25. Riassumendo… Le caratteristiche dello stile di un testo descrittivo Le principali caratteristiche di un testo descrittivo da un punto di vista linguistico sono le seguenti: -l’uso degli indicatori spaziali: avverbi, preposizioni, locuzioni avverbiali (davanti, dietro, in basso, in alto, a sinistra, a destra, ecc…), indispensabili nella descrizione di un luogo, di una persona, per la collocazione di un oggetto nello spazio e per la definizione delle parti che lo compongono; -l’uso degli aggettivi, che indicano le qualità del referente; -l’uso di frasi brevi, per una maggiore chiarezza della descrizione; -l’uso dei verbi all’indicativo presente e imperfetto, cioè dei cosiddetti tempi durativi, che permettono di esprimere azioni che durano nel tempo; - ricchezza e varietà nell’uso dei termini, indispensabile per fornire un’immagine chiara e precisa del referente e delle parti che lo compongono.
- 26. Le tecniche della descrizione A secondo del soggetto da descrivere, dello scopo e del destinatario, variano anche le tecniche della descrizione stessa. Un elemento discriminante è sicuramente il punto di vista da cui si sceglie di osservare e descrivere la realtà (una finestra su un cortile, l’ultimo piano un palazzo, il centro di una piazza). Si può poi scegliere un criterio particolare di ordine, spaziale o gerarchico, in base al quale impostare la descrizione. Nel primo caso si procederà dall’alto verso il basso o viceversa, da sinistra a destra o da destra a sinistra; nel secondo caso si può partire da una visione d’insieme per giungere all’analisi dei particolari dell’immagine o viceversa.
- 27. Esempio: L’autobus stava per partire, rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell’alba, sfilacce di nebbia ai campanili della Matrice; solo il rombo dell’autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde panelle, implorante ed ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello, l’autobus si mosse con un rumore di sfasciume. (L. Sciascia, Il giorno della civetta, Adelphi, Milano, 1988) Questa descrizione di una piazza e della partenza di un autobus è realizzata in modo assolutamente oggettivo e impersonale, secondo un criterio di ordine che procede dall’esterno (piazza) all’interno (autobus).
- 28. la presenza delle sensazioni uditive Un altro elemento importante attraverso cui viene costruita la scena è la presenza delle sensazioni uditive che contribuiscono a creare un’immagine viva e dinamica davanti ai nostri occhi di lettori. L’udito, l’olfatto, il gusto, il tatto, oltre naturalmente alla vista, sono i canali attraverso cui percepiamo il mondo che ci circonda e i messaggi che la realtà esterna ci invia. E’ inevitabile quindi che i nostri sensi rimangano coinvolti nel momento stesso in cui descriviamo qualcosa. Come abbiamo già ricordato, il testo descrittivo si trova spesso inserito all’interno di altri testi. E’ il caso di romanzi e racconti nei quali abbondano le descrizioni di luoghi e personaggi sia nei loro tratti fisici che caratteriali.
- 29. Esempio: […] I suoi abiti erano miseri: un vestito di tela, un vecchio velo sbiadito e sandali con le suole consunte, ma si era avvolta nel velo in modo far risaltare la figura slanciata, il sedere sporgente, il petto formoso, le gambe ben fatte e aveva lasciato scoperta la riga dei capelli neri e il volto abbronzato e grazioso. […] Non aveva famiglia, né mezzi, ma non perdeva mai la fiducia in se stessa. tanta sicurezza era probabilmente dovuta alla sua grande bellezza, ma non era questo l’unico motivo. Era forte per natura e quella forza non l’abbandonava un solo istante. I suoi splendidi occhi tradivano a volte questo sentimento rendendola meno attraente per alcuni e molto più per gli altri (Nagib Mahfuz, Vicolo del mortaio)
- 30. Esempi Esempio descrizione soggettiva Dear Future Generations: Sorry Doppiato In Italiano! – YouTube Esempio descrizione oggettiva il ciclo dell inquinamento atmosferico - YouTube
- 31. Domande???
