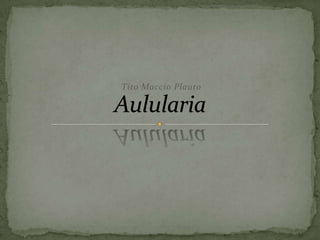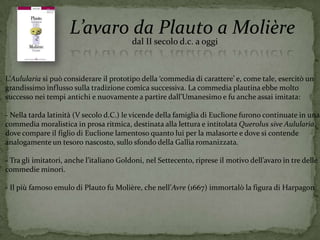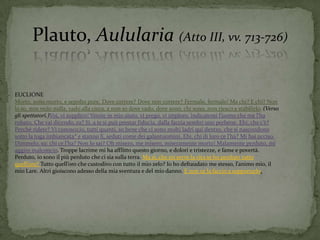Tito Maccio Plauto, commediografo romano nato a Sarsina nel 250 a.C., è noto per le sue opere influenti nella commedia, tra cui 'Aulularia', che racconta le avventure di Euclione, un vecchio avaro che trova una pentola d'oro. I suoi personaggi, tra cui la figlia Fedra e il vicino Megadoro, intrecciano comicamente storie di furto e avarizia, riflettendo le debolezze umane. La sua eredità ha influenzato successivi drammaturghi come Molière, che riflette le stesse tematiche in 'L'avaro'.