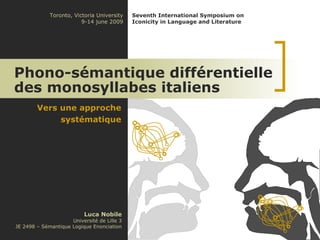
Nobile - Phonosemantique monosyllabes italiens
- 1. Vers une approche systématique Phono-sémantique différentielle des monosyllabes italiens Luca Nobile Université de Lille 3 JE 2498 – Sémantique Logique Enonciation Toronto, Victoria University 9-14 june 2009 Seventh International Symposium on Iconicity in Language and Literature
- 2. 0. I ntroduction Saussure (1922) Un système linguistique est une série de différences de sons , combinées avec une série de différences d’idées ; mais cette mise en regard d’un certain nombre de signes acoustiques avec autant de découpures faites dans la masse de la pensée engendre un système de valeurs ; et c’est ce système qui constitue le lien effectif entre les éléments phoniques et psychiques à l’intérieur de chaque signe.
- 5. 0.2 S ystème phonologique 0. Introduction ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z OUVERT FERM É L È VRES VOILE LANGUE AVANT ARRI È RE
- 6. 1. M onophonèmes Monophonèmes i e è a ha ho o uh i /i/ article ; défini ; pluriel « les » e /e/ conjonction ; copulative « et » è /’ ɛ / P3 ; essere « est » a /a/ préposition ; locative « à » ha /’a/ P3 ; avere « a » ho /’ ɔ / P1 ; avere « ai » o /o/ conjonction ; disjonctive « ou » uh /u/ meta-onomatopée « ouh » un /un/ article ; indéfini; singulier « un »
- 10. 1.2 D irections sémantiques 1. Monophonèmes « les » INDEXICAL COLLECTIF (diagrammaticité figurative)
- 11. 1.2 D irections sémantiques 1. Monophonèmes « les » INDEXICAL COLLECTIF « ouh » AUTODEXICAL SINGULATIF (diagrammaticité figurative)
- 12. 1.2 D irections sémantiques 1. Monophonèmes « et » UNITIF (diagrammaticité figurative)
- 13. 1.2 D irections sémantiques 1. Monophonèmes « et » UNITIF « ou » SEPARATIF (diagrammaticité figurative)
- 14. 1.2 D irections sémantiques 1. Monophonèmes « (il) est » INDEXICAL (3 e personne) UNITIF (copule) CONVEXE ( être ) (diagrammaticité figurative)
- 15. 1.2 D irections sémantiques 1. Monophonèmes « (il) est » INDEXICAL (3 e personne) UNITIF (copule) CONVEXE ( être ) « (j’) ai » AUTODEXICAL (1 e personne) SEPARATIF (transitif) CREUX ( avoir ) (diagrammaticité figurative)
- 16. 1.2 D irections sémantiques 1. Monophonèmes « à » LOCATIF CONVEXE (diagrammaticité figurative)
- 17. 1.2 D irections sémantiques 1. Monophonèmes « à » LOCATIF CONVEXE « (il) a » LOCUS CREUX (diagrammaticité figurative)
- 24. 2.2 D irections sémantiques : aperture 2. Personnes (diagrammaticité figurative) FERMETURE PHONOLOGIQUE (CONSONNE) ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z l a
- 25. 2.2 D irections sémantiques : aperture 2. Personnes (diagrammaticité figurative) OUVERTURE PHONOLOGIQUE (VOYELLE) FERMETURE PHONOLOGIQUE (CONSONNE) ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z l a
- 26. 2.2 D irections sémantiques : aperture 2. Personnes (diagrammaticité figurative) FERMETURE ONTOLOGIQUE (ENTIT É ) OUVERTURE PHONOLOGIQUE (VOYELLE) FERMETURE ONTOLOGIQUE (ENTIT É) lui lo FERMETURE PHONOLOGIQUE (CONSONNE) ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z l a
- 27. 2.2 D irections sémantiques : aperture 2. Personnes (diagrammaticité figurative) OUVERTURE ONTOLOGIQUE (RELATION) FERMETURE ONTOLOGIQUE (ENTIT É ) OUVERTURE PHONOLOGIQUE (VOYELLE) FERMETURE ONTOLOGIQUE (ENTIT É) lui lo ha FERMETURE PHONOLOGIQUE (CONSONNE) ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z l a
- 28. 2.3 D irections sémantiques : lieu 2. Personnes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE (1 e PERSONNE) ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 29. 2.3 D irections sémantiques : lieu 2. Personnes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE (1 e PERSONNE) mi POST É RIORIT É ONTOLOGIQUE (LOCUTEUR) ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 30. 2.3 D irections sémantiques : lieu 2. Personnes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE (1 e PERSONNE) ANT É RIORIT É PHONOLOGIQUE (2 e PERSONNE) mi POST É RIORIT É ONTOLOGIQUE (LOCUTEUR) ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 31. 2.3 D irections sémantiques : lieu 2. Personnes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE (1 e PERSONNE) ANT É RIORIT É PHONOLOGIQUE (2 e PERSONNE) mi ti POST É RIORIT É ONTOLOGIQUE (LOCUTEUR) ANT É RIORIT É ONTOLOGIQUE (ALLOCUTAIRE) ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 32. 2.3 D irections sémantiques : lieu 2. Personnes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE (1 e PERSONNE) ANT É RIORIT É PHONOLOGIQUE (2 e PERSONNE) mi ti CENTRALIT É & OUVERTURE PHONOLOGIQUE (3 e PERSONNE) POST É RIORIT É ONTOLOGIQUE (LOCUTEUR) ANT É RIORIT É ONTOLOGIQUE (ALLOCUTAIRE) ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 33. 2.3 D irections sémantiques : lieu 2. Personnes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE (1 e PERSONNE) ANT É RIORIT É PHONOLOGIQUE (2 e PERSONNE) li mi ti CENTRALIT É & OUVERTURE PHONOLOGIQUE (3 e PERSONNE) POST É RIORIT É ONTOLOGIQUE (LOCUTEUR) ANT É RIORIT É ONTOLOGIQUE (ALLOCUTAIRE) CENTRALIT É & OUVERTURE ONTOLOGIQUE (LE MONDE) ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 36. 3.2 L ieux : directions sémantiques 3. Adverbes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE QUI, QUA « ICI » ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 37. 3.2 L ieux : directions sémantiques 3. Adverbes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE QUI, QUA « ICI » POST É RIORIT É ONTOLOGIQUE « PR ÈS DU LOCUTEUR » ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 38. 3.2 L ieux : directions sémantiques 3. Adverbes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE QUI, QUA « ICI » ANT É RIORIT É PHONOLOGIQUE L Ì LÀ « L À -BAS » POST É RIORIT É ONTOLOGIQUE « PR ÈS DU LOCUTEUR » ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 39. 3.2 L ieux : directions sémantiques 3. Adverbes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE QUI, QUA « ICI » ANT É RIORIT É PHONOLOGIQUE L Ì LÀ « L À -BAS » POST É RIORIT É ONTOLOGIQUE « PR ÈS DU LOCUTEUR » ANT É RIORIT É ONTOLOGIQUE « LOIN DU LOCUTEUR » ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 40. 3.2 L ieux : directions sémantiques 3. Adverbes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE QUI, QUA « ICI » ANT É RIORIT É PHONOLOGIQUE L Ì LÀ « L À -BAS » EXT É RIORIT É PHONOLOGIQUE VIA « AILLEURS » POST É RIORIT É ONTOLOGIQUE « PR ÈS DU LOCUTEUR » ANT É RIORIT É ONTOLOGIQUE « LOIN DU LOCUTEUR » ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 41. 3.2 L ieux : directions sémantiques 3. Adverbes (diagrammaticité figurative) POST É RIORIT É PHONOLOGIQUE QUI, QUA « ICI » ANT É RIORIT É PHONOLOGIQUE L Ì LÀ « L À -BAS » EXT É RIORIT É PHONOLOGIQUE VIA « AILLEURS » POST É RIORIT É ONTOLOGIQUE « PR ÈS DU LOCUTEUR » ANT É RIORIT É ONTOLOGIQUE « LOIN DU LOCUTEUR » EXT É RIORIT É ONTOLOGIQUE « HORS DE LA SITUATION É NONCIATIVE » ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 42. 3.2 L ieux : directions sémantiques 3. Adverbes (diagrammaticité figurative) FERMETURE PHONOLOGIQUE QUI, L Ì ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 43. 3.2 L ieux : directions sémantiques 3. Adverbes (diagrammaticité figurative) OUVERTURE PHONOLOGIQUE QUA, L À FERMETURE PHONOLOGIQUE QUI, L Ì ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 44. 3.2 L ieux : directions sémantiques 3. Adverbes (diagrammaticité figurative) FERMETURE ONTOLOGIQUE « PONCTUEL » OUVERTURE PHONOLOGIQUE QUA, L À FERMETURE PHONOLOGIQUE QUI, L Ì ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 45. 3.2 L ieux : directions sémantiques 3. Adverbes (diagrammaticité figurative) FERMETURE ONTOLOGIQUE « PONCTUEL » OUVERTURE ONTOLOGIQUE « ÉTENDU » OUVERTURE PHONOLOGIQUE QUA, L À FERMETURE PHONOLOGIQUE QUI, L Ì ɔ i u o ɛ e a p ʦ ʣ ʧ ʤ ʎ ɲ b t v f d k g ʃ w j m n l r s z
- 53. Merci www.lucanobile.eu lux.nobile@gmail.com
Editor's Notes
- Bonjour. Le but de mon intervention est de vous présenter ma recherche sur l’iconicité des structures phonologiques de l’italien. Mon hypothèse est qu’il existe une iconicité structurale, concernant non seulement certaines parties du lexique, mais la totalité du système sémantique et cognitif. Je vous présenterai très brièvement mes premisses théoriques et méthodologiques avant d’approfondir l’analise des monosyllabes italiens.
- Puisque traditionnellement les objections les plus importantes à la théorie de l’iconicité viennent de la linguistique saussurienne, j’ai cru intéressant d’élaborer une théorie de l’iconicité du signe fondée précisément sur la conception de la langue de Saussure. Cette possibilité est offerte par plusieurs passages du « Cour de linguistique générale » et notamment par celui-ci. Selon Saussure, c’est le système des différences entre les signes qui expliquerait le rapport entre le son et le sens à l’intérieur de chaque signe. Par la suite, Benveniste a montré que cette conception est incompatible avec la notion traditionnelle de l’arbitraire du signe, que l’on attribue habituellement à Saussure. Par contre, Jakobson a montré que la conception saussurienne de la langue en tant que système est parfaitement compatible avec une théorie différentielle de l’iconicité, qu’il appelle « iconicité diagrammatique », en reprenant un terme de Peirce.
- Puisque traditionnellement les objections les plus importantes à la théorie de l’iconicité viennent de la linguistique saussurienne, j’ai cru intéressant d’élaborer une théorie de l’iconicité du signe fondée précisément sur la conception de la langue de Saussure. Cette possibilité est offerte par plusieurs passages du « Cour de linguistique générale » et notamment par celui-ci. Selon Saussure, c’est le système des différences entre les signes qui expliquerait le rapport entre le son et le sens à l’intérieur de chaque signe. Par la suite, Benveniste a montré que cette conception est incompatible avec la notion traditionnelle de l’arbitraire du signe, que l’on attribue habituellement à Saussure. Par contre, Jakobson a montré que la conception saussurienne de la langue en tant que système est parfaitement compatible avec une théorie différentielle de l’iconicité, qu’il appelle « iconicité diagrammatique », en reprenant un terme de Peirce.
- Il corpus comprende tutte le parole di 1, 2 o 3 fonemi, escluse tutte le onomatopee tranne una, le interiezioni, le sigle, i nomi delle lettere, ed altre parole speciali. Sono marcati in azzurro i verbi, in arancione i pronomi personali e in verde gli avverbi, che sono le forme che esaminero’ oggi Diversi aspetti di metodo meriterebbero una discussione più approfondita, ma preferisco passare subito alla presentazione dei risultati
- Il corpus comprende tutte le parole di 1, 2 o 3 fonemi, escluse tutte le onomatopee tranne una, le interiezioni, le sigle, i nomi delle lettere, ed altre parole speciali. Sono marcati in azzurro i verbi, in arancione i pronomi personali e in verde gli avverbi, che sono le forme che esaminero’ oggi Diversi aspetti di metodo meriterebbero una discussione più approfondita, ma preferisco passare subito alla presentazione dei risultati
- >>> Ciascuno dei fonemi vocalici dell’italiano, ad eccezione di /u/ , costituisce un lessema grammaticale . >>> La vocale posteriore /u/ è l’unica che non dà luogo a una parola distinta. Questa proprietà la caratterizza distintivamente. E quindi a lingua la sfrutta, facendone l’emblema della voce umana non linguistica , per esempio la voce del selvaggio, del bruto, del fantasma. In pratica, ne fa la metaonomatopea della voce stessa dell’uomo. Poiché « uh » non possiede tratti morfologici distintivi , che permettano di compararla in modo analitico con gli altri elementi, >>> la affianchiamo nell’analisi con l’unico monosillabo grammaticale dell’italiano cominciante per /-u/, cioè « un » >>> Al contrario di « uh », la vocale centrale /a/ manifesta un surplus di linguisticità , dando luogo a due quasi-omofoni, Gli altri fonemi corrispondono ciascuno a una parola distinta. >>> Se adesso scriviamo accanto a questi lessemi i loro nomi grammaticali completi ci rendiamo subito conto che la loro distribuzione nel triangolo fonetico non è meramente casuale.
- In primo luogo, studiando le direttrici oppositive in un’ottica puramente formale noi possiamo fornire una descrizione praticamente completa dei tratti fonologici distintivi, associando a ciascuno un tratto logico-semantico costante. >>> In primo luogo, il tratto [tonico]:[atono] distingue i verbi da tutto il resto. >>> In secondo luogo, ciascun grado di apertura, tranne quello di /a/, corrisponde a una categoria grammaticale distinta >>>il grado [chiuso] distingue i due [articoli] >>> il grado [medio-chiuso] le due [congiunzioni] >>> il grado [medio-aperto] i due [verbi ausiliari] >>> Quanto al LUOGO, infine, le [anteriori] si oppongono sempre alle [posteriori] come il versante [positivo/convesso] e il versante [negativo/concavo] di un nucleo semantico comune. Abbiamo infatti: >>>[definito] : [indefinito] >>>[plurale] : [singolare] >>>[copulativa] : [disgiuntiva] >>>[ essere ] : [ avere ] >>>[3 persona] : [1 persona] Nelll’insieme, dunque, il sistema delle differenze fonetiche è quasi esattamente isomorfico al sistema delle differenze logico-semantiche, cioè ne costitusce un’immagine.
- In primo luogo, studiando le direttrici oppositive in un’ottica puramente formale noi possiamo fornire una descrizione praticamente completa dei tratti fonologici distintivi, associando a ciascuno un tratto logico-semantico costante. >>> In primo luogo, il tratto [tonico]:[atono] distingue i verbi da tutto il resto. >>> In secondo luogo, ciascun grado di apertura, tranne quello di /a/, corrisponde a una categoria grammaticale distinta >>>il grado [chiuso] distingue i due [articoli] >>> il grado [medio-chiuso] le due [congiunzioni] >>> il grado [medio-aperto] i due [verbi ausiliari] >>> Quanto al LUOGO, infine, le [anteriori] si oppongono sempre alle [posteriori] come il versante [positivo/convesso] e il versante [negativo/concavo] di un nucleo semantico comune. Abbiamo infatti: >>>[definito] : [indefinito] >>>[plurale] : [singolare] >>>[copulativa] : [disgiuntiva] >>>[ essere ] : [ avere ] >>>[3 persona] : [1 persona] Nelll’insieme, dunque, il sistema delle differenze fonetiche è quasi esattamente isomorfico al sistema delle differenze logico-semantiche, cioè ne costitusce un’immagine.
- In primo luogo, studiando le direttrici oppositive in un’ottica puramente formale noi possiamo fornire una descrizione praticamente completa dei tratti fonologici distintivi, associando a ciascuno un tratto logico-semantico costante. >>> In primo luogo, il tratto [tonico]:[atono] distingue i verbi da tutto il resto. >>> In secondo luogo, ciascun grado di apertura, tranne quello di /a/, corrisponde a una categoria grammaticale distinta >>>il grado [chiuso] distingue i due [articoli] >>> il grado [medio-chiuso] le due [congiunzioni] >>> il grado [medio-aperto] i due [verbi ausiliari] >>> Quanto al LUOGO, infine, le [anteriori] si oppongono sempre alle [posteriori] come il versante [positivo/convesso] e il versante [negativo/concavo] di un nucleo semantico comune. Abbiamo infatti: >>>[definito] : [indefinito] >>>[plurale] : [singolare] >>>[copulativa] : [disgiuntiva] >>>[ essere ] : [ avere ] >>>[3 persona] : [1 persona] Nelll’insieme, dunque, il sistema delle differenze fonetiche è quasi esattamente isomorfico al sistema delle differenze logico-semantiche, cioè ne costitusce un’immagine.
- Se ora passiamo dall’analisi formale delle direttrici a un’ analisi sostanziale delle direzioni , >>> cioè teniamo conto del corpo del locutore nello spazio di enunciazione, il quadro si chiarisce ulteriormente. Infatti il locutore >>> con il gesto di avanzare la lingua verso l’esterno della bocca, >>> contro il gesto di ritirarla verso il proprio interno e di avanzare simultaneamente le labbra in senso contrario connota distintivamente , sui diversi gradi di apertura: >>> un valore indessicale collettivo, riferito alla pluralità degli enti, « i » >>> contro un valore autodessicale singolativo, riferito all’unicità della propria voce « uh » >>> un valore unitivo « e » contro un valore separativo « o » un valore indessicale (3 persona), unitivo (copula) e convesso (essere) « è » contro un valore autodessicale (1 persona), separativo (transitivo) e concavo (avere) « ho » infine, nel caso di /a/, >>> con il gesto di appiattire la lingua al centro della bocca esibendo l’apparato articolatorio come tale, composto di una cavità (la bocca) entro cui si muove un convessità (la lingua) >>> il locutore distingue un valore locativo convesso, la preposizione semplice « a » da un valore di locus concavo, la terza persona del verbo avere « ha » Nell’insieme, il sistema si presenta dunque come una piccola cosmogonia cioè come una segmantazione della la totalità dell’esperienza sensibile lungo due assi principali: quello del rapporto tra il locutore e il mondo, che corre lungo il luogo di articolazione e quello del rapporto tra le cose e lo spazio, che corre lungo il grado di apertura. Vediamo ora come questa totalità sia ulteriormente segmentata, in modo sempre più fine, dalle parole più lunghe.
- Se ora passiamo dall’analisi formale delle direttrici a un’ analisi sostanziale delle direzioni , >>> cioè teniamo conto del corpo del locutore nello spazio di enunciazione, il quadro si chiarisce ulteriormente. Infatti il locutore >>> con il gesto di avanzare la lingua verso l’esterno della bocca, >>> contro il gesto di ritirarla verso il proprio interno e di avanzare simultaneamente le labbra in senso contrario connota distintivamente , sui diversi gradi di apertura: >>> un valore indessicale collettivo, riferito alla pluralità degli enti, « i » >>> contro un valore autodessicale singolativo, riferito all’unicità della propria voce « uh » >>> un valore unitivo « e » contro un valore separativo « o » un valore indessicale (3 persona), unitivo (copula) e convesso (essere) « è » contro un valore autodessicale (1 persona), separativo (transitivo) e concavo (avere) « ho » infine, nel caso di /a/, >>> con il gesto di appiattire la lingua al centro della bocca esibendo l’apparato articolatorio come tale, composto di una cavità (la bocca) entro cui si muove un convessità (la lingua) >>> il locutore distingue un valore locativo convesso, la preposizione semplice « a » da un valore di locus concavo, la terza persona del verbo avere « ha » Nell’insieme, il sistema si presenta dunque come una piccola cosmogonia cioè come una segmantazione della la totalità dell’esperienza sensibile lungo due assi principali: quello del rapporto tra il locutore e il mondo, che corre lungo il luogo di articolazione e quello del rapporto tra le cose e lo spazio, che corre lungo il grado di apertura. Vediamo ora come questa totalità sia ulteriormente segmentata, in modo sempre più fine, dalle parole più lunghe.
- Se ora passiamo dall’analisi formale delle direttrici a un’ analisi sostanziale delle direzioni , >>> cioè teniamo conto del corpo del locutore nello spazio di enunciazione, il quadro si chiarisce ulteriormente. Infatti il locutore >>> con il gesto di avanzare la lingua verso l’esterno della bocca, >>> contro il gesto di ritirarla verso il proprio interno e di avanzare simultaneamente le labbra in senso contrario connota distintivamente , sui diversi gradi di apertura: >>> un valore indessicale collettivo, riferito alla pluralità degli enti, « i » >>> contro un valore autodessicale singolativo, riferito all’unicità della propria voce « uh » >>> un valore unitivo « e » contro un valore separativo « o » un valore indessicale (3 persona), unitivo (copula) e convesso (essere) « è » contro un valore autodessicale (1 persona), separativo (transitivo) e concavo (avere) « ho » infine, nel caso di /a/, >>> con il gesto di appiattire la lingua al centro della bocca esibendo l’apparato articolatorio come tale, composto di una cavità (la bocca) entro cui si muove un convessità (la lingua) >>> il locutore distingue un valore locativo convesso, la preposizione semplice « a » da un valore di locus concavo, la terza persona del verbo avere « ha » Nell’insieme, il sistema si presenta dunque come una piccola cosmogonia cioè come una segmantazione della la totalità dell’esperienza sensibile lungo due assi principali: quello del rapporto tra il locutore e il mondo, che corre lungo il luogo di articolazione e quello del rapporto tra le cose e lo spazio, che corre lungo il grado di apertura. Vediamo ora come questa totalità sia ulteriormente segmentata, in modo sempre più fine, dalle parole più lunghe.
- Se ora passiamo dall’analisi formale delle direttrici a un’ analisi sostanziale delle direzioni , >>> cioè teniamo conto del corpo del locutore nello spazio di enunciazione, il quadro si chiarisce ulteriormente. Infatti il locutore >>> con il gesto di avanzare la lingua verso l’esterno della bocca, >>> contro il gesto di ritirarla verso il proprio interno e di avanzare simultaneamente le labbra in senso contrario connota distintivamente , sui diversi gradi di apertura: >>> un valore indessicale collettivo, riferito alla pluralità degli enti, « i » >>> contro un valore autodessicale singolativo, riferito all’unicità della propria voce « uh » >>> un valore unitivo « e » contro un valore separativo « o » un valore indessicale (3 persona), unitivo (copula) e convesso (essere) « è » contro un valore autodessicale (1 persona), separativo (transitivo) e concavo (avere) « ho » infine, nel caso di /a/, >>> con il gesto di appiattire la lingua al centro della bocca esibendo l’apparato articolatorio come tale, composto di una cavità (la bocca) entro cui si muove un convessità (la lingua) >>> il locutore distingue un valore locativo convesso, la preposizione semplice « a » da un valore di locus concavo, la terza persona del verbo avere « ha » Nell’insieme, il sistema si presenta dunque come una piccola cosmogonia cioè come una segmantazione della la totalità dell’esperienza sensibile lungo due assi principali: quello del rapporto tra il locutore e il mondo, che corre lungo il luogo di articolazione e quello del rapporto tra le cose e lo spazio, che corre lungo il grado di apertura. Vediamo ora come questa totalità sia ulteriormente segmentata, in modo sempre più fine, dalle parole più lunghe.
- Se ora passiamo dall’analisi formale delle direttrici a un’ analisi sostanziale delle direzioni , >>> cioè teniamo conto del corpo del locutore nello spazio di enunciazione, il quadro si chiarisce ulteriormente. Infatti il locutore >>> con il gesto di avanzare la lingua verso l’esterno della bocca, >>> contro il gesto di ritirarla verso il proprio interno e di avanzare simultaneamente le labbra in senso contrario connota distintivamente , sui diversi gradi di apertura: >>> un valore indessicale collettivo, riferito alla pluralità degli enti, « i » >>> contro un valore autodessicale singolativo, riferito all’unicità della propria voce « uh » >>> un valore unitivo « e » contro un valore separativo « o » un valore indessicale (3 persona), unitivo (copula) e convesso (essere) « è » contro un valore autodessicale (1 persona), separativo (transitivo) e concavo (avere) « ho » infine, nel caso di /a/, >>> con il gesto di appiattire la lingua al centro della bocca esibendo l’apparato articolatorio come tale, composto di una cavità (la bocca) entro cui si muove un convessità (la lingua) >>> il locutore distingue un valore locativo convesso, la preposizione semplice « a » da un valore di locus concavo, la terza persona del verbo avere « ha » Nell’insieme, il sistema si presenta dunque come una piccola cosmogonia cioè come una segmantazione della la totalità dell’esperienza sensibile lungo due assi principali: quello del rapporto tra il locutore e il mondo, che corre lungo il luogo di articolazione e quello del rapporto tra le cose e lo spazio, che corre lungo il grado di apertura. Vediamo ora come questa totalità sia ulteriormente segmentata, in modo sempre più fine, dalle parole più lunghe.
- Se ora passiamo dall’analisi formale delle direttrici a un’ analisi sostanziale delle direzioni , >>> cioè teniamo conto del corpo del locutore nello spazio di enunciazione, il quadro si chiarisce ulteriormente. Infatti il locutore >>> con il gesto di avanzare la lingua verso l’esterno della bocca, >>> contro il gesto di ritirarla verso il proprio interno e di avanzare simultaneamente le labbra in senso contrario connota distintivamente , sui diversi gradi di apertura: >>> un valore indessicale collettivo, riferito alla pluralità degli enti, « i » >>> contro un valore autodessicale singolativo, riferito all’unicità della propria voce « uh » >>> un valore unitivo « e » contro un valore separativo « o » un valore indessicale (3 persona), unitivo (copula) e convesso (essere) « è » contro un valore autodessicale (1 persona), separativo (transitivo) e concavo (avere) « ho » infine, nel caso di /a/, >>> con il gesto di appiattire la lingua al centro della bocca esibendo l’apparato articolatorio come tale, composto di una cavità (la bocca) entro cui si muove un convessità (la lingua) >>> il locutore distingue un valore locativo convesso, la preposizione semplice « a » da un valore di locus concavo, la terza persona del verbo avere « ha » Nell’insieme, il sistema si presenta dunque come una piccola cosmogonia cioè come una segmantazione della la totalità dell’esperienza sensibile lungo due assi principali: quello del rapporto tra il locutore e il mondo, che corre lungo il luogo di articolazione e quello del rapporto tra le cose e lo spazio, che corre lungo il grado di apertura. Vediamo ora come questa totalità sia ulteriormente segmentata, in modo sempre più fine, dalle parole più lunghe.
- Se ora passiamo dall’analisi formale delle direttrici a un’ analisi sostanziale delle direzioni , >>> cioè teniamo conto del corpo del locutore nello spazio di enunciazione, il quadro si chiarisce ulteriormente. Infatti il locutore >>> con il gesto di avanzare la lingua verso l’esterno della bocca, >>> contro il gesto di ritirarla verso il proprio interno e di avanzare simultaneamente le labbra in senso contrario connota distintivamente , sui diversi gradi di apertura: >>> un valore indessicale collettivo, riferito alla pluralità degli enti, « i » >>> contro un valore autodessicale singolativo, riferito all’unicità della propria voce « uh » >>> un valore unitivo « e » contro un valore separativo « o » un valore indessicale (3 persona), unitivo (copula) e convesso (essere) « è » contro un valore autodessicale (1 persona), separativo (transitivo) e concavo (avere) « ho » infine, nel caso di /a/, >>> con il gesto di appiattire la lingua al centro della bocca esibendo l’apparato articolatorio come tale, composto di una cavità (la bocca) entro cui si muove un convessità (la lingua) >>> il locutore distingue un valore locativo convesso, la preposizione semplice « a » da un valore di locus concavo, la terza persona del verbo avere « ha » Nell’insieme, il sistema si presenta dunque come una piccola cosmogonia cioè come una segmantazione della la totalità dell’esperienza sensibile lungo due assi principali: quello del rapporto tra il locutore e il mondo, che corre lungo il luogo di articolazione e quello del rapporto tra le cose e lo spazio, che corre lungo il grado di apertura. Vediamo ora come questa totalità sia ulteriormente segmentata, in modo sempre più fine, dalle parole più lunghe.
- Se ora passiamo dall’analisi formale delle direttrici a un’ analisi sostanziale delle direzioni , >>> cioè teniamo conto del corpo del locutore nello spazio di enunciazione, il quadro si chiarisce ulteriormente. Infatti il locutore >>> con il gesto di avanzare la lingua verso l’esterno della bocca, >>> contro il gesto di ritirarla verso il proprio interno e di avanzare simultaneamente le labbra in senso contrario connota distintivamente , sui diversi gradi di apertura: >>> un valore indessicale collettivo, riferito alla pluralità degli enti, « i » >>> contro un valore autodessicale singolativo, riferito all’unicità della propria voce « uh » >>> un valore unitivo « e » contro un valore separativo « o » un valore indessicale (3 persona), unitivo (copula) e convesso (essere) « è » contro un valore autodessicale (1 persona), separativo (transitivo) e concavo (avere) « ho » infine, nel caso di /a/, >>> con il gesto di appiattire la lingua al centro della bocca esibendo l’apparato articolatorio come tale, composto di una cavità (la bocca) entro cui si muove un convessità (la lingua) >>> il locutore distingue un valore locativo convesso, la preposizione semplice « a » da un valore di locus concavo, la terza persona del verbo avere « ha » Nell’insieme, il sistema si presenta dunque come una piccola cosmogonia cioè come una segmantazione della la totalità dell’esperienza sensibile lungo due assi principali: quello del rapporto tra il locutore e il mondo, che corre lungo il luogo di articolazione e quello del rapporto tra le cose e lo spazio, che corre lungo il grado di apertura. Vediamo ora come questa totalità sia ulteriormente segmentata, in modo sempre più fine, dalle parole più lunghe.
- Ricapitolo le mie premesse: L’oggetto della ricerca non è il rapporto tra i suoni e i significati ma il rapporto tra le differenze di suono e le differenze di significato. L’elemento minimo della ricerca non è quindi il fonema ma il tratto distintivo. Il campo, non è l’universalità del linguaggio ma la specificità di ogni lingua. Il metodo non è l’accumulazione di esempi, ma la descrizione completa e coerente della totalità di un sistema di opposizioni. Il problema che si pone è come studiare la totalità di un sistema di opposizioni senza dover studiare la totalità delle opposizioni della lingua
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Ricapitolo le mie premesse: L’oggetto della ricerca non è il rapporto tra i suoni e i significati ma il rapporto tra le differenze di suono e le differenze di significato. L’elemento minimo della ricerca non è quindi il fonema ma il tratto distintivo. Il campo, non è l’universalità del linguaggio ma la specificità di ogni lingua. Il metodo non è l’accumulazione di esempi, ma la descrizione completa e coerente della totalità di un sistema di opposizioni. Il problema che si pone è come studiare la totalità di un sistema di opposizioni senza dover studiare la totalità delle opposizioni della lingua
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Il sistema delle persone prevede due sottosistemi principali: Quello delle persone verbali e quello delle persone pronominali Le persone verbali, con la parziale eccezione di essere, si distinguono mediante terminazioni vocaliche. Le persone pronominali, con la sola eccezione di « io » si distinguono mediante iniziali consonantiche. Questo ci permette di affermare che in italiano >>> i [verbi] stanno alle [vocali] circa come i [pronomi] stanno alle [consonanti] Siccome già tra i monofonemi l’apertura si opponeva alla chiusura come il gruppo verbale al gruppo nominale, sembra di poter dire che la coppia [aperto:chiuso] funzioni come un diagramma della coppia [azione:oggetto] . Infatti, le azioni e le relazioni hanno tipicamente luogo nello spazio aperto che si estende tra gli oggetti, mentre gli oggetti sono tipicamente chiusi, cioè impenetrabili. Percio’ l’azione o la relazione che la persona verbale esprime è distintivamente connotata dalla lingua come un’apertura. Mentre quando la persona è il punto di partenza o di arrivo di un’azione, cioè un pronome, allora è connotata distintivamente come una chiusura . Rimarcata questa differenza preliminare, chiediamoci come sia possibile che con mezzi fonetici cosi’ diversi, verbi e pronomi pervengano a distinguere gli stessi attori nello spazio di enunciazione. La mia ipotesi è che i due sistemi di opposizioni fonetiche sono solo due differenti diagrammi dello stesso sistema di opposizioni semantiche: un po’ come sarebbero un istogramma e un diagramma a torta dello stesso dato statistico.
- Quindi ad esempio i neuroni specchio non possono spiegare la rapidità con cui i bambini acquisiscono le distinzioni semantiche per mezzo delle distinzioni fonetiche.
